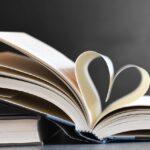Nella sua lunga carriera ai vertici di vari media e alla direzione della RAI lei ha avuto modo di seguire da vicino ciò che accadeva nelle stanze del potere. Crede ancora nella possibilità di un’informazione libera dai condizionamenti della politica?
«È una sfida sempre più difficile. Come dimostrano gli ultimi avvenimenti – vedi la censura sui social media svelata dai Twitter files – anche in democrazia la tendenza a orientare e a controllare i media è sempre più marcata. Il che spesso sfocia nel pensiero unico. I margini del dibattito sono vieppiù limitati, rendendo off limits certi temi e certe opinioni. Tuttavia c’è stata una reazione a mio giudizio salutare: alcune testate (ancora poche, purtroppo) mantengono un’indipendenza di giudizio mentre sul web le voci fuori dal coro continuano ad essere numerose, il che permette di mantenere accesa la fiamma di un giornalismo libero e non politicizzato».
La velocità di cambiamento nel mondo dei mass media ha raggiunto picchi incredibilmente elevati e fino ad oggi sconosciuti. Che cosa c’è da attendersi per l’immediato futuro?
«Il processo di sviluppo digitale è impetuoso e sta trasformando la fruizione mediatica. Le nuove generazioni si informano secondo modalità in continua evoluzione e sempre più frammentate. C’è chi privilegia TikTok, chi Snapchat, chi Instagram, chi Twitter, mentre Facebook è già considerato un social per… vecchi! Conseguentemente si creano mondi informativi e di intrattenimento che non comunicano fra loro, il che ha un forte impatto sociale e valoriale. Molti giovani si informano solo sui loro canali e solo assecondando i propri interessi; dunque si formano tante bolle che non comunicano fra loro. E questo ha un impatto considerevole su chi fa informazione e comunicazione».
In che modo la trasformazione digitale sta impattando sull’informazione on e off line?
«L’impatto su quella off line è drammatica: i giornali e la carta stampata sono in un declino probabilmente irreversibile, raggiungono delle nicchie, per quanto qualificate, ma non toccano più le masse. Anche l’informazione digitale, tuttavia, non se la passa bene, perché gran parte della pubblicità online è drenata da Google, Meta e Amazon; dunque alle testate arrivano pochi ricavi anche quando hanno molto successo. È un drammatico paradosso di internet perché, per la prima volta nella storia dei media, avere un pubblico vasto non basta a garantire la sostenibilità economica e dunque le risorse necessarie per fare buon giornalismo».
Lei ha di recente pubblicato il libro “Il sistema (in)visibile”, dove si parla di un sistema che può essere compreso solo uscendo dai classici schemi interpretativi. Perché la scelta di un argomento (e di un titolo) così denso di problemi attuali?
«Per spiegare il malessere che attanaglia le società occidentali e che, soprattutto nei grandi Paesi, finora appare irrisolto. Sia il mondo intellettuale sia quello accademico sono troppo specializzati, mentre la società di oggi si può capire solo osservandola dall’alto, con spirito olistico, e cogliendo i legami (in)visibili tra ambiti apparentemente scollegati e multidisciplinari. Nel libro compongo il puzzle e dimostro quali sono le dinamiche reali che condizionano il nostro destino, al di là della volontà popolare, tema a noi molto caro, fino a snaturare le democrazie».
Come è possibile, nella società contemporanea, modellare le masse, cambiare i valori, orientare la politica, l’economia e i media avvalendosi anche di tecniche di influenza psicologica?
«La Guerra Fredda tra Occidente e Urss è stata combattuta anche attraverso tecniche sempre più sofisticare di influenza psicologica, di cui i cittadini non erano consapevoli ma che sono state documentate attingendo agli archivi desecretati di Cia e Kgb. Quelle tecniche, caduto il Muro di Berlino, non sono state riposte nel cassetto ma continuano ad essere usate. Il tema è fondamentale ma viene ignorato sia dai media sia dagli intellettuali. Eppure rappresenta una chiave di lettura imprescindibile per capire il mondo complesso in cui viviamo».
Una questione di cui si è fatto un gran parlare riguarda il ruolo delle fake news e la loro capacità di minare l’attendibilità dell’informazione. Qual è il suo parere in proposito e cosa bisognerebbe fare per essere maggiormente tutelati rispetto alle false notizie?
«Le fake news sono un’arma a doppio taglio: che esistano è innegabile ma sono diffuse anche da agenzie di intelligence di Paesi insospettabili. La disinformazione online avviene su scala industriale e secondo modalità e finalità sempre più sofisticate. Non a caso spettro delle fake news viene agitato per giustificare e dunque tentare di imporre una censura di fatto a tutti i media; il che è molto pericoloso e contrario ai principi democratici e della libertà di stampa, perché presuppone che l’unica verità accettata sia quella sancita da organi ufficiali. Ecco perché ritengo che l’argomento fake news vada trattato con molta circospezione e senza limitarsi ad analisi superficiali».
Che cosa ci può anticipare riguardo ai suoi prossimi impegni e incarichi professionali?
«Il successo de “Il sistema (in)visibile”, giunto alla terza ristampa in poche settimane, rafforza le mie convinzioni. Negli ambiti in cui mi muovo ora (intellettuale, universitario, aziendale, incluso l’essere consigliere di amministrazione di una società importante quale Azimut, quotata alla Borsa di Milano) è sempre più importante analizzare la realtà con una visione aperta, analitica e disincantata. Di certo il libro rappresenta non una fine ma l’inizio di un’ulteriore evoluzione intellettuale e professionale».