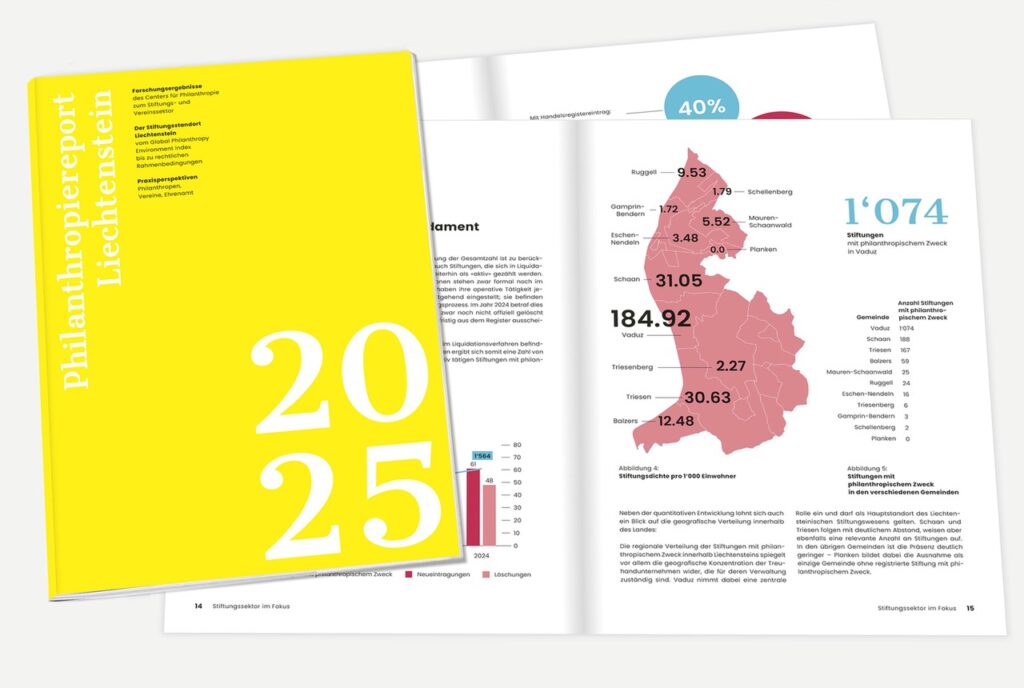Ina Piattini Pelloni, durante la sua significativa carriera manageriale con ruoli di leadership a vari livelli, quali esperienze di vita l’hanno spinta a considerare la generosità come un valore fondamentale nella sua vita?
«Non parlerei di esperienze, ma piuttosto di esempi che ti accompagnano nel definire una sorta di visione della vita. In primis metterei quindi l’esempio di mia madre: non negava l’aiuto a nessuno. Sono cresciuta in città, ma con l’innato “spirito della contadina”: quello che s’ha da dare lo si fa senza se e senza ma; se il tuo vicino ha bisogno di aiuto glielo dai perché domani potresti essere tu ad avere bisogno del suo. È uno spirito che diventa parte di te stessa, in qualunque ruolo tu sia chiamata a viverlo».
In passato come ha integrato la generosità nel suo approccio al lavoro e alla gestione delle risorse umane?
«Generosità e risorse umane. Due parole importanti che fissano due ambiti precisi, nei quali però non mi ci trovo. L’approccio è qualcosa che dovrebbe nascere spontaneamente, “di pelle”, e non di pensiero e tanto meno di ragionamento».
Quali persone che ha incontrato nel corso della sua vita considera come punti di riferimento spirituali e intellettuali per le sue attività filantropiche?
«La “zia Irma” di mio marito, una persona speciale. Quando l’ho conosciuta passava i novant’anni, erano gli ultimi mesi della sua vita, ed emanava una gran dolcezza e generosità d’animo. Mi ricordava mia mamma, che purtroppo ho perso quand’ero giovane».
Nel 1995 con suo marito ha istituito una propria fondazione, la Fondazione Ina e Sandro Pelloni-Piattini, che cosa l’ha spinta a questa scelta?
«È nata per iniziativa di mio marito. Ha potuto studiare medicina grazie alle borse di studio che hanno accompagnato il suo impegno negli studi. E ha potuto studiare musica (sax) grazie a 5 franchi ricevuti da bambino dalla “zia Irma”, appunto, per entrare a far parte della banda del paese».
Di che cosa si occupa la fondazione?
«Promuove la formazione professionale e culturale a beneficio di giovani ticinesi meritevoli e bisognosi di sostegno, rispettivamente sostiene l’attività di istituzioni culturali e formative attive nell’ambito di un progetto concreto (ad esempio le scuole del CSI e la FOSI)».
Dal 1999 lei è Presidente della Fondazione Conservatorio della Svizzera Italiana: quale è stato il momento più significativo o gratificante che hai vissuto finora in questa posizione di leadership?
«Non mi sono mai considerata uno “skipper”, il comandante di una barca. Bensì un marinaio che si mette ai remi (lo spirito della contadina) per concorrere, nei limiti delle sue capacità, al successo di una meravigliosa équipe. Direi quindi che ogni momento è stato significativo e gratificante, dal giorno in cui, grazie ad Armin Brenner (deus ex machina), ho avuto il privilegio di partecipare alla nascita (1985) dell’Associazione, poi divenuta (1999) Fondazione del Conservatorio della Svizzera italiana, al prossimo anno, quando festeggeremo i primi 40 anni».
Come nasce la sua passione per la musica?
«A 17 anni avrei voluto frequentare un conservatorio per diventare una pianista (senza molto talento, purtroppo). Le alternative di allora non erano proprio “sotto casa” (Zurigo o Milano), un’opzione che non rispondeva alle aspettative di mia madre, docente di matematica. Per cui mi sono dedicata all’economia; i numeri sono comunque la mia seconda passione, ora come allora».
Parliamo del progetto «Città della musica»: di che cosa si tratta e quali saranno le principali strutture presenti nella Città della Musica?
«Nella Città della musica (cittadellamusica.ch) – progetto di cui la Fondazione CSI (conservatorio.ch) è leader – troveranno spazio: le tre scuole del CSI (complessivamente circa 1500 allievi), la Fonoteca Nazionale (di proprietà della Confederazione, unica sede in Svizzera), gli uffici-studi dell’OSI, dei Barocchisti e di Sonart, nonché gli studi di produzione e registrazione musicale della RSI. Non si tratterà di semplici “coinquilini” ma di strutture complementari che punteranno ad ottimizzare collaborazioni e sinergie, a sviluppare prospettive e nuovi profili professionali».
Quali generi musicali avranno uno spazio dedicato all’interno del progetto?
«Tutta la buona musica. È la qualità che fa la differenza».
Quale è la sua visione relativamente al finanziamento della «Città della musica»?
«Il dipartimento Scuola universitaria di Musica (SUM) potrà beneficiare dei contributi sia federali sia cantonali previsti nell’ambito della legge sulle università. Sono contributi importanti. Non risolvono il finanziamento del progetto, ma ne pongono una base concreta e soprattutto, danno garanzia di fattibilità. Gli enti erogatori che ne hanno verificato e quantificato i contenuti seguiranno l’evoluzione del progetto, garantendo serietà ed efficienza nella realizzazione. Una premessa che, confido, non verrà sottovalutata dai mecenati il cui apporto sarà Fondamentale».
Quali strategie adotta per coinvolgere altre personalità e per sensibilizzarle a partecipare al progetto?
«Puntiamo sulla massima trasparenza e sul coinvolgimento nel progetto da parte di chi vorrà lasciare un segno concreto della sua partecipazione a questo importante passo nell’evoluzione culturale non solo della Città di Lugano, ma dell’intero Cantone e anche al di là di questo».
Perché pensa che la «Città della musica» sia importante per il Canton Ticino?
«Penso possa concorrere e dare evidenza materiale alle strutture di straordinaria qualità già menzionate, che già oggi contribuiscono alla ricchezza immateriale del nostro territorio. Ne è un esempio il LAC: i numerosi eventi – e i “sold out” che si susseguono – dimostrano come questa presenza abbia dato uno scossone alla vita culturale della città».
Quali sono i suoi obiettivi personali e cosa spera di poter realizzare, se pensa a questo progetto?
«Parlerei di obiettivi collettivi, perché collettivi sono gli sforzi che stanno propugnando la Città di Lugano, il Cantone, la Confederazione – e ovviamente la Fondazione CSI – e tutti coloro che vorranno lasciare un duraturo e concreto segno della loro partecipazione a questo magnifico progetto».
Qual è il messaggio che vorrebbe trasmettere a chi desidera intraprendere un cammino nel mondo della filantropia e come vorrebbe essere ricordata per il suo impegno in questo settore?
«Non so se sarò ricordata o meno. Mi auguro che a essere ricordato sia quanto è stato possibile creare, grazie all’impegno di tanti e grazie alle spinte filantropiche di chi con noi ha condiviso un ideale, che permette di lasciare in eredità all’intero nostro territorio la Città della Musica».
Chi è Ina Piattini Pelloni
Co-fondatrice nel 1985, insieme ad Armin Brenner, dell’Associazione (poi Fondazione) del Conservatorio della Svizzera italiana, e da allora ne presiede il CdF. Di formazione commerciale, dal 1991 al 2001 è stata DG e dal 2001 al 2015 membro del CdA di Fidinam Group Holding SA. Parallelamente è stata membro del Comitato della SSR Svizzera italiana CORSI; dell’Ufficio presidenziale della Cc-Ti e della Commissione di sorveglianza dell’OSEC. Dal 1994 al 1995 quale membro del GC del Canton Ticino, ha presieduto la prima Commissione per la “Legge cantonale sull’Università” entrata in vigore il 3 ottobre 1995. Dal 1995 al 2004 è stata membro del Consiglio della SUPSI.