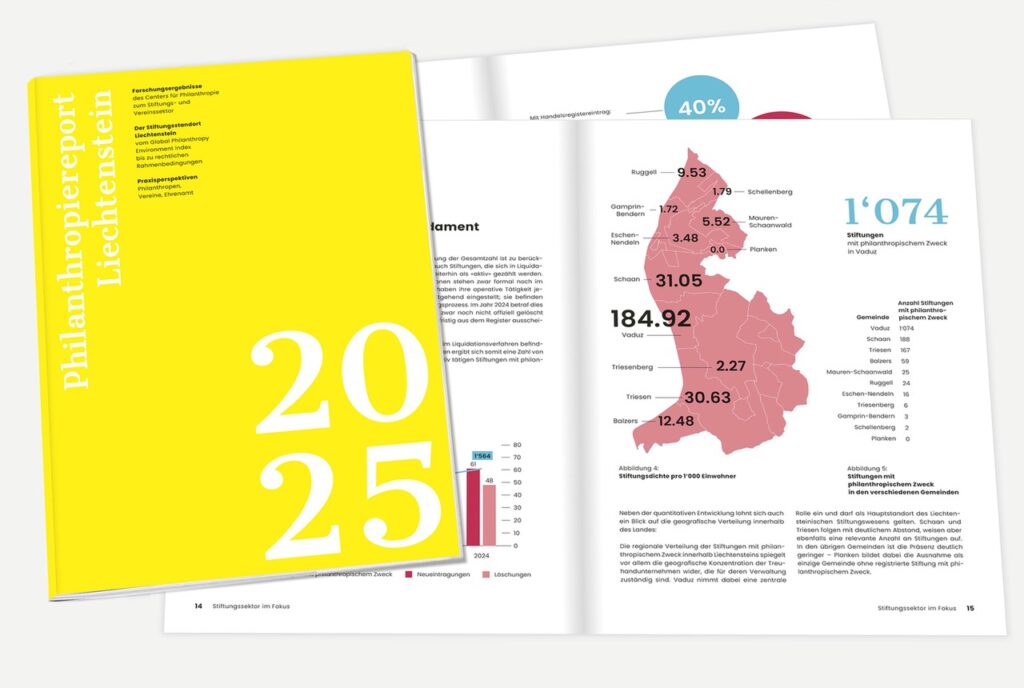Dottoressa Bortoluzzi Dubach, se dovesse ridefinire il significato di generosità, quale formulazione proporrebbe?
«Per me, la generosità assume un significato profondo, che va oltre le definizioni tradizionali come “altruista” o “di buon cuore”. È la capacità di generare speranza con gesti di rispetto, comprensione e solidarietà verso gli altri. In un mondo che esalta l’individualismo e l’autorealizzazione, la generosità ha una valenza rivoluzionaria, direi dirompente, crea una contro-energia rispetto alla lettura della realtà a cui ci abitua una parte della politica internazionale e la lettura dei giornali. Considero la generosità una pratica quotidiana, vissuta come esperienza di vita, che ha il potere di trasformare la natura dell’esistenza, proiettandola verso una dimensione più gioiosa e significativa. Trent’anni trascorsi accanto a filantropi illuminati, volontari e persone che vivono la propria vita con intensità, gioia e un autentico apprezzamento per la socialità, mi hanno insegnato che è solo attraverso un costante esercizio quotidiano che si raggiunge tale profondità».
Perché parla volentieri di una “generosità che cura”?
«Donare è un modo per creare connessioni significative e arricchire identità e senso di appartenenza. Già nel 2014 Pier Mario Vello, nel suo libro La società generosa, scriveva: “Il dono è il principale creatore simbolico di socialità e, allo stesso tempo, è il motore della circolazione materiale dei beni, reazione di fronte all’ignoto e forza alla base dello sviluppo delle alleanze. Il dono scardina, non crea gerarchie, viene prima dell’economia e dello Stato”. Nel 2020 è nato il Movimento Italia Gentile, che rappresenta non solo cittadini e istituzioni ma coinvolge città che si impegnano a coltivare relazioni positive, migliorare la qualità della vita e incoraggiare il senso di appartenenza, spesso attraverso progetti educativi, culturali e sociali e naturalmente iniziative filantropiche. La Repubblica di San Marino è stata riconosciuta come il primo Stato Gentile al mondo. Il movimento ha assunto una dimensione globale attraverso l’International Kindness Movement, che promuove una “rivoluzione gentile”, incoraggiando la collaborazione e la solidarietà tra individui, enti pubblici e privati. Tuttavia parlare di dono non è semplice, e spesso mi capita di percepire scetticismo attorno all’argomento».
Qual è il legame fra la generosità che cura e la filantropia?
«Nel libro Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, scritto con Luigino Bruni, l’economista Stefano Zamagni descrive la filantropia come un “umanesimo civile”, definizione da me condivisa. Generosità e filantropia sono strettamente legate, poiché entrambe si basano sul desiderio di aiutare gli altri e migliorare il benessere della comunità. Se il dono personale è simbolo di cura e connessione, la filantropia espande questa visione, trasformandola in un movimento strutturato e orientato a un impatto più ampio. Ci sono però alcune differenze chiave fra generosità e filantropia: mentre la generosità si riferisce a piccoli e grandi atti di gentilezza quotidiana che hanno un impatto positivo e immediato sul benessere emotivo, mentale e fisico di individui o gruppi, la filantropia rappresenta una forma più strutturata e organizzata di donazione, che mira a risolvere problemi sociali su scala più ampia. Un esempio è quello della famiglia Ponti, imprenditori della Ponti S.p.A., che nel Novarese ha sostenuto numerose iniziative culturali e di solidarietà, contribuendo alla creazione di centri residenziali per disabili e case per anziani, dimostrando un forte impegno verso la responsabilità sociale e il territorio. Generosità e filantropia, sono una sfida al consumismo per promuovere valore».
Per quale motivo l’associazione tra il concetto di generosità e l’attività espressa da fondazioni e filantropi spesso è aspramente criticata?
«L’associazione tra generosità e filantropia da parte di fondazioni e filantropi può suscitare critiche e scherno quando è percepita come un mezzo per guadagnare prestigio personale, influenzare decisioni politiche o deviare l’attenzione da pratiche contestabili. Alcuni accusano queste iniziative di favorire un approccio paternalistico, in cui la distribuzione delle risorse è gestita senza un reale coinvolgimento delle comunità beneficiarie. Per rispondere a tali critiche, è importante adottare un approccio trasparente, misurare l’effettivo impatto sociale delle iniziative e incoraggiare un dialogo aperto con le comunità, per garantire che i bisogni reali siano davvero al centro delle attività filantropiche».
Le viene in mente una storia di un filantropo particolarmente generoso?
«Un esempio toccante viene dalla vita di colui che è stato definito “l’Angelo della filantropia”, il milanese Roberto Bagnato, recentemente scomparso, che di fronte alle difficoltà della gente ripeteva: “Non riesco ad accettare che a Milano si possa vivere così”. Bocconiano, ex funzionario di banca ed esperto di finanza, Bagnato ha trascorso l’ultima parte dell’esistenza ad aiutare i bisognosi, rimanendo sempre nell’ombra, senza mai far conoscere la sua identità. Aveva incominciato la sua missione, naturalmente in incognito, nel 2001, dopo aver letto un articolo su un ex barista costretto a dormire in macchina. Il suo era il desiderio di scuotere le coscienze e denunciare l’indifferenza che nella metropoli lascia troppe persone da sole, magari malate e senza mezzi o lavoro. Dopo le sue prime azioni, il centralino del “Corriere della Sera” diventò di fuoco, tutti volevano aiuto e conoscerlo, l’“Angelo invisibile” era diventato quasi una leggenda. Bagnato sosteneva che occorresse attivarsi in prima persona, mettendo la gente nella condizione di poter ripartire, perché chi ha di più deve dare qualcosa a chi ha di meno».
Come può un filantropo dimostrare generosità autentica, non solo con il denaro, ma anche con le azioni e l’atteggiamento?
«Un filantropo può per esempio dedicarsi all’incontro con gli artisti che sostiene, prendendosi il tempo per ascoltare chi ha bisogno di condividere i propri pensieri. Così ha fatto per anni il grande filantropo di Winterthur, Werner Reinhart, promotore di musicisti quali Alban Berg, Paul Hindemith, Ernst Krenek, Arnold Schönberg, Richard Strauss, Igor Stravinskij, Anton Webern (cfr. Werner Reinhart, Mäzen der Moderne, Ulrich Tadday Editore, 2024). Può donare il proprio tempo e il proprio sapere, mettendo le sue competenze a disposizione per aiutare un’organizzazione non profit in difficoltà. Un esempio interessante è quello della Elea Foundation for Ethics in Globalization, istituita da Peter Wuffli. La fondazione collabora strettamente con un gruppo di investitori filantropici che condividono la convinzione che la povertà possa essere combattuta efficacemente attraverso strumenti imprenditoriali. Elea offre loro l’opportunità di mettere a disposizione capitale e competenze a favore di aziende che abbiano un forte impatto sociale. Infine, un filantropo può offrire supporto emotivo, esprimendo parole di incoraggiamento e conforto in momenti complicati per le istituzioni o le persone che sostiene e mettendo a disposizione le sue reti sociali. Compiere anche gesti semplici, come mostrare apprezzamento a un partner che si sostiene economicamente, può rappresentare un’importante forma di generosità».
In che modo le fondazioni o i mecenati possono attivare forme di “generosità che cura”?
«Per esempio mobilitando risorse per sostenere progetti che migliorino il benessere complessivo delle persone. Il concetto di “curare” va ben oltre la guarigione fisica, e abbraccia una dimensione più ampia che include l’aspetto emotivo, mentale e sociale di ogni individuo. Offrire sostegno a organizzazioni non profit significa consentire loro di operare con maggiore impatto, fornendo attenzioni e servizi che facciano sentire le persone accolte, comprese e valorizzate. Molte fondazioni filantropiche, come la Pro Mente Sana, lavorano per sostenere coloro che attraversano momenti di difficoltà emotiva. Attraverso il supporto di donatori filantropi, queste organizzazioni offrono programmi di supporto psicologico e counselling, aiutando individui e famiglie a superare crisi personali e a migliorare il benessere mentale. Un altro esempio significativo è la Fondazione Patrizio Paoletti, che ha sviluppato programmi formativi basati su scoperte neuroscientifiche, psicologiche e pedagogiche per aiutare le persone a coltivare la resilienza nella vita quotidiana. Le esperienze di chi riesce a trasformare situazioni di obbiettiva difficoltà in resilienza grazie al supporto ricevuto dimostrano in modo concreto come la filantropia possa generare valore, non solo umano ma anche sociale, trasformando le sfide in opportunità di crescita».
Come possiamo bilanciare l’urgenza di rispondere a bisogni crescenti con la necessità di evitare la “philanthropy fatigue” tra donatori e filantropi, e garantire un impatto sostenibile nel lungo termine?
«Nonostante i numerosi benefici, la filantropia presenta anche alcune incognite. Tra queste la “philanthropy fatigue”, ovvero la stanchezza da esaurimento o quella emotiva e finanziaria che i filantropi possono finire per provare quando si tratta di elargire donazioni continue o di rispondere a esigenze umanitarie che si protraggono per un lungo lasso di tempo. Qualche tempo fa, a titolo di esempio, una famiglia di filantropi che ha scelto l’anonimato, e che per anni aveva sostenuto le più svariate iniziative nel campo della salute, ha scelto di concentrarsi su un unico soggetto richiedente. Non certo una sconfitta, ma piuttosto un gesto di generosità verso sé stessi, un modo per indirizzare le proprie energie, ottimizzare l’impatto delle donazioni e vivere pienamente il significato autentico della filantropia. Concentrarsi non significa ridurre il valore dell’aiuto, ma rafforzarlo, trasformandolo in un impegno profondo e mirato, capace di lasciare un segno duraturo».
Elisa Bortoluzzi Dubach
La Dottoressa Elisa Bortoluzzi Dubach è consulente di Relazioni Pubbliche, Sponsorizzazioni e Fondazioni, docente presso varie università e istituti superiori in Svizzera e Italia e co-autrice fra gli altri di La relazione generosa-Guida alla collaborazione con filantropi e mecenati.
www.elisabortoluzzi.com/