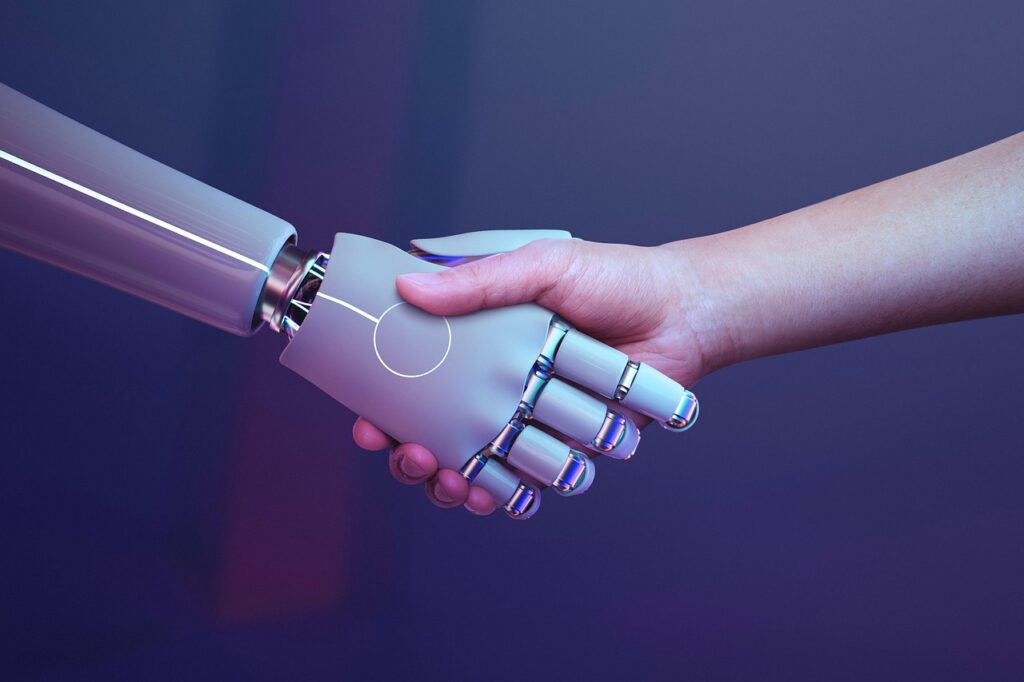Dovesse spiegare in poche parole cos’è l’intelligenza artificiale, cosa direbbe?
«L’intelligenza artificiale è sostanzialmente una macchina che imita il comportamento umano all’interno di un mondo complesso. Si tratta di un algoritmo implementato su un computer in grado di imparare dai dati che osserva, fare delle previsioni e adattarsi alle condizioni mutevoli di questi dati. Detto altrimenti, l’IA ha la capacità di imparare dal passato e prevedere il futuro o prendere delle decisioni sul corso di azioni future in modo autonomo».

L’IA non è una tecnologia nuova, tanto è vero che l’IDSIA USI-SUPSI ha di recente compiuto 35 anni. Com’è cambiata l’IA?
«L’essere umano è sempre stato affascinato dall’idea di creare un automa. A guardar bene, l’industria orologiera svizzera è un effetto collaterale delle invenzioni di quei maestri della meccanica, quali Henri-Louis Jacquet-Droz, che volevano realizzare delle creature stupefacenti in grado di riprodurre il comportamento e il movimento di umani e animali.
Il termine vero e proprio è stato coniato negli anni ’50 in occasione di un convegno tenutosi al Dartmouth College negli Stati Uniti. All’epoca gli studi si concentravano sulla riproduzione dei meccanismi del ragionamento umano di alto livello, con un approccio basato sulla logica. L’IA moderna poggia invece sull’apprendimento dei dati in una modalità simile a quella con cui gli esseri umani, ad esempio, da bambini imparano a muoversi e interagire con l’ambiente. Riproducendo questo tipo di meccanismo si è sviluppata un’IA basata sulle reti neurali, che rispecchia il funzionamento del nostro cervello.
C’è un passaggio ulteriore, perché oggi cerchiamo di capire come le strutture emergenti dei dati possano essere trasmesse e spiegate a un essere umano. Le reti neurali funzionano bene ma non ci dicono perché abbiano compiuto una determinata azione. Gli studi sull’IA oggi vogliono estrarre i concetti dai dati e quindi produrre conoscenza vera e propria».
L’IA più famosa è ChatGPT, ma quanto capisce quello che gli diciamo e quello che ci dice?
«Nessun ricercatore affermerebbe che queste IA siano pienamente dotate di coscienza. Eppure, lo stesso Chief scientist di Open AI, Ilya Sutskever, afferma che ChatGPT ha degli sprazzi di coscienza nel momento in cui elabora una risposta articolata a un problema che gli è sottoposto. In effetti, talvolta abbiamo visto IA capaci di spiegare, in modo limitato, perché hanno prodotto un risultato. Sono IA che hanno imparato anche il procedimento per risolvere un problema. Non si tratta però di una vera coscienza: non sanno quello che stanno facendo, del perché lo stanno facendo e di quali potrebbero essere le conseguenze delle loro azioni».
Il fattore umano quanto incide oggi sull’IA?
«Il fattore umano incide tantissimo. Gli algoritmi di ChatGPT funzionano molto bene grazie allo human reinforcement learning: un apprendimento con rinforzo in cui l’essere umano valida le risposte create da ChatGPT. Nella fase di addestramento le risposte sono verificate e valutate da essere umani. La macchina impara dalla mole di dati con cui è nutrita, ma ha bisogno dell’uomo per avere una costante guida e migliorare la qualità delle risposte. Discorso analogo si può fare con chi interagisce con la macchina. Se non facciamo le domande giuste, non riceviamo le risposte che ci aspettiamo. Se stimoliamo la macchina con domande che tengono conto di come sono state organizzate le informazioni e le caratteristiche dell’algoritmo, miglioriamo la qualità delle risposte. Per questo il fattore umano è fondamentale e lo sarà sempre più: perché l’IA che dobbiamo sviluppare deve collaborare con l’uomo e non sostituirlo».

Il successo di ChatGPT ha accelerato la corsa all’IA, con i GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) che stanno compiendo una vera e propria corsa all’oro. E come allora là fuori è il far west. I Governi sono in ritardo con una regolamentazione della tecnologia?
«Nel corso dell’ultimo decennio la ricerca si è spostata dai centri universitari alle aziende big tech che oggi dettano l’agenda. L’Unione Europea si è profilata con il primo IA Act che l’ha assurta al ruolo di paladina nella regolamentazione dell’Intelligenza Artificiale. Norme e leggi arriveranno ovunque, ma è chiaro che bisognerà prestare attenzione all’uso e all’abuso, sapendo che la regolamentazione sarà sempre un passo indietro allo sviluppo tecnologico».
All’interno del contesto globale come si posiziona la Svizzera?
«Secondo il Global AI Index la Svizzera occupa il nono posto per livello di investimenti, innovazione e implementazione dell’Intelligenza Artificiale. Abbiamo un numero molto alto di ricercatori e pubblicazioni scientifiche, ma come piccolo paese siamo penalizzati nelle applicazioni di questa tecnologia su larga scala. Detto questo, abbiamo un numero interessante di unicorni (aziende con almeno un miliardo di capitalizzazione) e siamo ben posizionati a livello europeo. Bisogna tenere il passo perché la competizione è sempre più agguerrita».
Veniamo a voi. Quali sono i principali assi di ricerca dell’IDSIA USI-SUPSI?
«Noi continuiamo a seguire l’ispirazione del nostro fondatore Angelo Dalle Molle: conduciamo una ricerca sull’intelligenza artificiale che porti al miglioramento della qualità della vita. Lavoriamo sulla social robotics, con robot che si interfacciano con gli esseri umani, capiscono e intuiscono le loro esigenze e necessità. Un altro asse di ricerca riguarda la trasparenza dei modelli di intelligenza artificiale: vogliamo giungere ai motivi per cui determinate decisioni sono state prese; al perché gli algoritmi producono determinati suggerimenti. Ci interessa che l’IA aiuti e fornisca suggerimenti senza sottrarre all’uomo la propria capacità decisionale. Gli aspetti etici sono molto rilevanti nelle nostre ricerche».

Quale aspetto dell’IA le desta maggior preoccupazione?
«L’impatto sul mercato del lavoro. Se non sarà mitigato da strumenti di sicurezza sociale potrebbe essere devastante».
Quale aspetto dell’IA porterà beneficio all’umanità?
«I benefici sono innumerevoli. Se devo scegliere, penso al supporto che potrà dare nel prendere decisione politiche che possano mitigare il cambiamento climatico».
Da che parte pende la bilancia: più rischi o opportunità?
«Vedo decisamente più opportunità, ma come per tutte le tecnologie c’è sempre un altro lato della medaglia. Non dobbiamo illuderci che non ci sarà nessuno che, per proprio interesse, tenterà di sfruttare i lati più oscuri di questa tecnologia. La guardia deve rimanere alta, sempre».