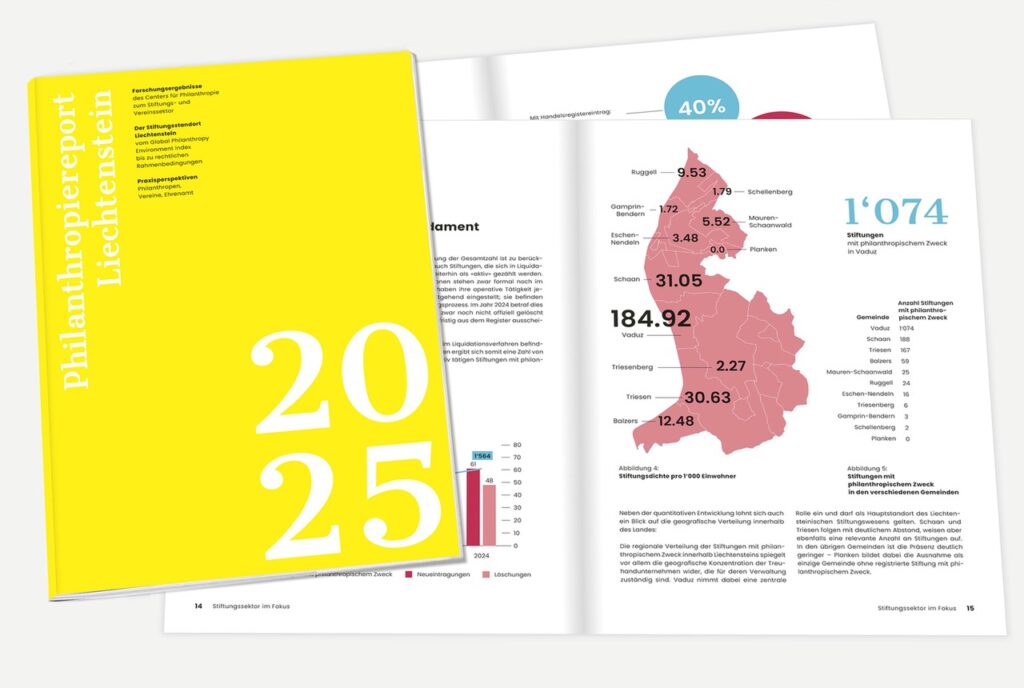Pamela Agazzi, lei è una neurologa di chiara fama che si occupa di malattie o disturbi cerebrali. Quando parliamo di emozioni di che cosa si tratta esattamente?
«Una definizione scientifica è che si tratta di stati psicofisiologici indotti da stimoli (come eventi, scene, ma anche oggetti), la cui funzione principale è quella di consentire una reazione immediata a determinate situazioni, ai fini dell’adattamento e della sopravvivenza. Hanno anche un ruolo nelle relazioni, perché comunicano rapidamente agli altri i nostri stati d’animo attraverso un linguaggio corporeo non verbale, ad esempio una variazione dell’espressione del volto o del tono della voce. Gli atti di generosità e di aiuto sono in grado di generare emozioni che ci mettono in connessione con gli altri e producono importanti o profondi cambiamenti nel nostro cervello».
Come nascono le emozioni?
«Lo stimolo generato dall’emozione, per esempio nel caso della filantropia ascoltando la musica di un artista che la donna mecenate ha sostenuto, viene elaborato a livello cerebrale in due fasi e da strutture diverse: la prima viene elaborata da alcune strutture sottocorticali che si esprime attraverso cambiamenti corporei, come variazione dei battiti del cuore; la seconda è quando lo stimolo viene inviato anche agli emisferi cerebrali, in particolare alla corteccia associativa, divenendo consapevole. L’emozione, quindi, si esprime inizialmente mediante una modifica del corpo e solo in un secondo tempo noi la avvertiamo e riusciamo a darle un nome (gioia, passione, meraviglia, ma anche rabbia o disgusto)».
In che modo le emozioni influenzano concretamente i comportamenti delle filantrope?
«A livello cerebrale i processi cognitivi ed emozionali sono profondamente integrati e collegati tra loro mediante complessi circuiti nervosi che coinvolgono diverse regioni. Ecco perché le emozioni sono in grado di produrre processi cognitivi, determinando importanti cambiamenti, e motivano il comportamento, influenzando il continuo interscambio tra noi ed il mondo esterno. Le donne, che tradizionalmente sono più attente alle loro emozioni, possono avere maggiore motivazione verso la riuscita di progetti di filantropia che coinvolgono rapporti umani e che possano produrre del bene per i singoli individui oltre che per la società. Inoltre gli stimoli che generano emozioni attivano i “circuiti emozionali” che sono strettamente connessi con le aree della memoria. Ovvero, il nostro cervello grazie alle emozioni ricorda più intensamente perché riconoscere, accogliere le emozioni ed elaborarle crea nuove connessioni cerebrali. I ricordi che rivivono grazie alle emozioni si colorano di sfumature più intense e permangono nel tempo. Possiamo “gustarli” di più».
Viviana Kasam, un ambito in cui le donne si distinguono per la loro qualificata presenza è, al contrario di quanto si è spesso portati a credere, quello delle scienze in generale e delle neuroscienze in particolare. Che cosa ci può raccontare in proposito?
«Al giorno d’oggi nelle università il numero di donne che si iscrivono a facoltà scientifiche e si laureano brillantemente è in molti Paesi quasi pari a quello degli uomini. Quello che ancora manca alle donne scienziate è la notorietà. Nei convegni scientifici i relatori sono per la maggior parte, se non tutti, uomini. Per questo ho ideato e organizzato il BrainForum itinerante Emotions (www.emotionsbrainforum.org), dove le relatrici sono esclusivamente donne. Credo che sia importante per le donne, e per le donne mecenati in particolare, impegnarsi per superare quello che viene chiamato il “soffitto di cristallo”, ovvero la barriera invisibile che impedisce alle donne di accedere ai ponti di comando. In molti settori questa barriera è superata, nella scienza e soprattutto nelle neuroscienze, purtroppo no. Proprio per questo, sto cercando di far rete con donne mecenati in tutto il mondo per sostenere le scienziate».
Lei è anche fondatrice e filantropa. È vero che la generosità, la gentilezza, la gratitudine possono creare benessere sia per quello che riguarda la psiche e il cervello, sia, di riflesso, nel corpo?
«Esistono parecchie ricerche scientifiche che testimoniano come i comportamenti positivi, per esempio la pratica sistematica della generosità e quindi della filantropia, abbiano un effetto benefico non solo per chi riceve ma anche per chi dà. Essere gentili aumenta la produzione di serotonina, l’ormone della felicità.
Mentre il rancore, l’invidia, la tirchieria non fanno male solo a chi ne è oggetto, ma prima di tutto a chi nutre queste emozioni negative. Nel 2003 la psicologa Barbara Fredrickson dell’Università del Nord Carolina ha pubblicato uno studio in cui dimostra che le emozioni positive controbilanciano il danno delle emozioni negative, e ha teorizzato quella che chiama la “positive ratio” (rapporto positivo): 3 a 1. Ovvero, sarebbero necessarie tre azioni buone per controbilanciare lo stress causato da una emozione negativa.
Sugli effetti positivi della generosità esistono una infinità di studi. I primi di cui sono consapevole -ma non escludo che ve ne sia stati anche dei precedenti- risalgono agli anni ’90 del secolo scorso. Deborah Danner, insieme ad altri collaboratori dell’Università del Kentucky, rileggendo nel 2001 i diari scritti negli anni ’30 da 180 suore cattoliche, si accorse che quelle che avevano espresso più emozioni positive, erano vissute in media 10 anni in più delle altre e non avevano sviluppato sintoni di demenza.
Lo studio più citato è però quello di Doug Oman, dell’Università di Berkeley in California, che si occupa di spiritualità e mindfulness, la disciplina oggi tanto di moda tra i giovani che si ispira alla meditazione e allo yoga. Già nel 1990 Oman cominciò a studiare 2015 residenti de una regione californiana, Marin County, attivi nel volontariato. I parametri di Oman sono piuttosto complessi e non posso elencarli in una breve intervista. Il risultato finale è che le persone molto attive nel volontariato risultarono mantenersi più sani e longevi del gruppo di controllo. E uno studio analogo condotto quasi contemporaneamente da scienziati dell’Università del Michigan su 2.153 persone anziane in Giappone, volto a studiare il rapporto tra religione, aiuto agli altri e salute, confermò il rapporto tra buona salute e generosità. L’altruismo crea maggiore integrazione sociale, distrazione dai problemi personali e dall’ansia, dà significato alla vita, combatte l’isolamento e la passività spesso collegate all’invecchiamento. Ed è un forte antidoto allo stress, uno dei fattori principali di malattia. Questi risultati sono stati confermati dagli studi di Stephen Post dell’Università di Chicago, autore di parecchi best sellers su questi temi, che dimostra come la beneficenza migliori la salute e la felicità di chi dà, e come l’empatia e la compassione non solo abbiano un effetto positivo sui malati e i bisognosi, ma anche su chi si occupa di loro. Gli attuali studi dei neuroscienziati affondano in queste ricerche. Ora è possibile misurare, attraverso le apparecchiature di brain imaging, l’attività del cervello mentre si compiono atti di generosità. Uno studio condotto da un team di ricercatori guidati da Philippe Tobler e Ernst Fehr dell’Università di Zurigo, in collaborazione con la Northwestern University di Chicago e pubblicato e nel 2018 su Nature Communications ha evidenziato gli effetti della generosità su alcune specifiche aree cerebrali, chiarendo finalmente l’interazione che esiste tra altruismo e felicità. Servendosi della risonanza magnetica funzionale, il team di ricercatori ha monitorato i cambiamenti cerebrali in 50 volontari reclutati per lo studio. A metà era stato chiesto era stato chiesto di pensare a come avrebbero speso 100 CHF per comprarsi qualcosa, all’altra metà per aiutare qualcuno. Alla fine dell’esperimento, i ricercatori sottoposero tutti i volontari a un test per verificare se era riscontrabile un cambiamento nell’umore. E sì, i generosi erano più felici e soddisfatti.
Come ci spiegano bene gli evoluzionisti, noi esseri umani ci siamo evoluti anche e soprattutto perché ad un certo punto abbiamo cominciato a cooperare, e a collaborare. Ora ne abbiamo una conferma anche a livello biologico: la sopravvivenza non è più solo un fatto di forza e competitività, ma anche di empatia e vicinanza al prossimo. E se poi pensiamo alla sopravvivenza non individuale, ma del genere umano e del pianeta, allora non ci sono dubbi».
La gentilezza è un tratto importante che può essere caratterizzante di una concezione di filantropia positiva. Che cosa ne pensa?
«Ci sono tanti modi di fare del bene, non solo economici. Dare il proprio tempo, il proprio lavoro è una importante forma di filantropia. Lo stesso vale per la gentilezza, per il modo di relazionarci agli altri.
Lo sostengono un sociobiologo, Daniel Lumera, e un’epidemiologa, Immacutata De Vivo, (un’autorità ad Harvard, che ha sintetizzato sei anni di studi al microscopio su che cosa favorisce o meno la longevità e l’assenza di malattie) nel recente libro Biologia della gentilezza, che dimostra sulla base di studi scientifici come esista un vantaggio biologico alla gentilezza e all’empatia, contraddicendo alcune errate ma popolari interpretazioni del pensiero di Darwin. Si evolverebbe il più adatto, ma non nei termini di forza fisica. Questo è confermato dai teleomeri, strutture di Dna alle estremità dei cromosomi che si accorciano man mano che diminuisce la salute e l’aspettativa di vita: nei generosi i teleomeri sono più lunghi».
Il mecenatismo femminile è diverso dal quello maschile?
«I modi in cui si esplica la filantropia sono spesso anche una questione di genere. Le donne tendono più spesso a essere toccate nell’empatia, aiutare chi ha bisogno, chi conoscono o cause alle quali si sentono partecipi. E sono inclini a fare rete. Recenti studi hanno evidenziato come stiano aumentando esponenzialmente le reti di donne mecenati in tutto il mondo e soprattutto nei Paesi emergenti. Gli uomini prediligono più spesso i grandi progetti ai quali amano dare il loro nome, una paternità surrogata di cui le donne forse hanno meno bisogno, in quanto i figli li mettono al mondo fisicamente. Nella filantropia le emozioni giochino un ruolo fondamentale, ed è indubbio che nella nostra cultura le emozioni hanno un “genere”, tema proprio del nostro incontro di Emotions a Lugano (vedi box 1).
Lei è nota per essere una persona generosa, ha mai avuto esperienze negative? Che cosa è la sindrome rancorosa del beneficato/della beneficata?
«Anche ricevere può scatenare reazioni opposte. C’è chi è grato per tutta la vita a una persona che gli ha dato aiuto, e chi invece cova rancore, forse perché si vergogna, forse perché si sente inferiore, forse perché non accetta l’idea di aver avuto bisogno degli altri.
I cervelli sono tutti simili nella loro struttura, e tutti diversi nelle connessioni che determinano le nostre emozioni e i nostri sentimenti. Personalmente ho imparato a non aspettarmi nulla dalle persone che aiuto, e credo che questo sia importante per non andare incontro a delusioni. Se aiuto qualcuno lo faccio perché lo ritengo giusto e importante, non per essere ringraziata. Se poi arrivano manifestazioni di gratitudine, sono un piacere in più, ma il vero piacere per me è quello di fare del bene e di sentirmi utile».
Che cosa suggerisce alle giovani donne alla loro prima esperienza con il mecenatismo?
«Per chi dà, vorrei dire che il mecenatismo non è riservato alle persone ricche. Esistono in tutto il mondo reti di mecenati donne che devolvono piccole cifre per una causa in cui credono. Cento donne che danno mille franchi equivale a una donazione di 100.000. E questo consente anche di diversificare i propri “investimenti” benefici: non uso a caso la parola investimenti, lo sono dal punto di vista morale e sociale.
Per chi chiede, vorrei sottolineare l’importanza di attenersi a un galateo, nel chiedere, nel ricevere e nel ringraziare, come avviene nella maggior parte dei comportamenti e delle interazioni sociali. Un galateo vero e proprio non è ancora stato scritto, ma il libro La relazione generosa: guida alla collaborazione con mecenati e filantropi di Elisa Bortoluzzi Dubach e Chiara Tinonin, pubblicato da Franco Angeli, illustra con chiarezza le regole di comportamento che consentono di evitare delusioni da entrambe le parti. Purtroppo oggi l’etichetta è considerata obsoleta e ridicola: e invece è la base della convivenza, anche se a volte può sembrare obsoleta».
*Pamela Agazzi, laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano, specialista in Neurologia. Attualmente capo servizio in Neurologia presso l’Ospedale Regionale di Lugano EOC, responsabile dell’ambulatorio di epilessia. Fa parte di Medicinadigenere.ch un gruppo di medici specialisti che ha sentito l’esigenza di dare spazio e voce alla medicina di genere.
**Viviana Kasam, giornalista scientifica e mecenate, dopo una trentennale esperienza di lavoro per le più importanti testate giornalistiche e televisive italiane, ha lasciato l’attività retribuita per dedicarsi a tempo pieno all filantropia. Ha fondato e presiede BrainCircleItaia e BrainCircleLugano, è Board Member dell’Università Ebraica di Gerusalemme, vicepresidente della Fondazione Spitzer di Lugano e ha istituito la Fondazione Lilah, il cui significato è “per me e per te”, a ribadire il benefico effetto della generosità su chi dona. Organizza a titolo di volontariato importanti eventi culturali, nel campo della musica e delle neuroscienze, le sue due passioni.