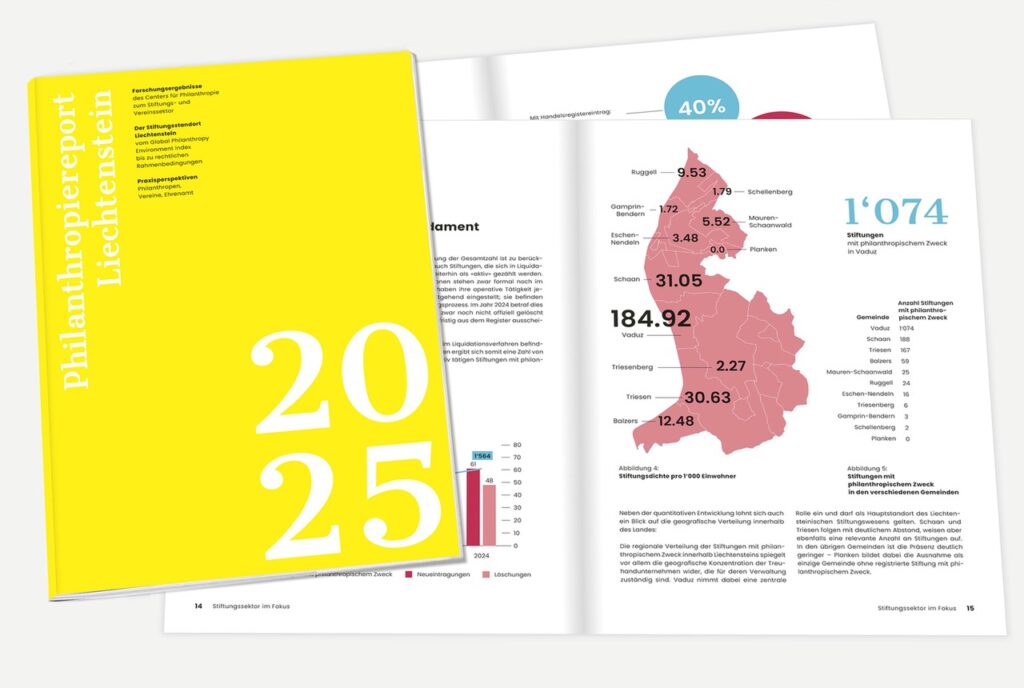“A poche ore dai durissimi attacchi russi in territorio ucraino del 24 febbraio, la Fondazione Francesca Rava si è attivata localmente per definire le necessità più urgenti tramite il primario dell’Ospedale Pediatrico della Bukovnian State Medical University di Chernivtsi, il Dottor Oleg Bodnar. Bodnar è un chirurgo pediatra volontario della Fondazione Rava e ha compiuto diverse missioni al St. Damien in Haiti. L’emergenza sanitaria più acuta riguarda la cura dei feriti e l’attenzione ai bambini ricoverati negli ospedali pediatrici. Molti ospedali sono stati bombardati e il materiale medico è andato perduto. Per questo è importante sostituirlo tempestivamente per poter garantire l’assistenza sanitaria ai soldati feriti. È urgente acquistare e inviare strumenti chirurgici, kit di pronto soccorso, elettrocoagulatori, monitor per i parametri vitali, antibiotici, anticoagulanti, ferri chirurgici, ellettrobisturi, tourniquet, coperte ipotermiche. Prima ancora di attivare la raccolta fondi, abbiamo già ordinato macchinari e materiale medicale urgente per un valore di 140.000 €. Per rispondere all’emergenza sanitaria abbiamo bisogno di raccogliere al più presto 500.000 € per procurare tempestivamente quanto ci è stato richiesto, in tempo per la partenza dei prossimi convogli. La Fondazione lavora in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero della Difesa e la Protezione Civile. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per acquistare attrezzature, materiale medico e farmaci richiesti dagli Ospedali.
Per donare
- IBAN: IT39G0306234210000000760000 – BIC/SWIFT: MEDBITMM
- Causale: Emergenza Ucraina
- Per informazioni tel 02.54122917
- info@nph-italia.org
La nostra intervista
Chi è Mariavittoria Rava? Vuole raccontarmi dove è cresciuta e quali sono state le tappe salienti della sua vita?
«Sono nata e cresciuta Milano. Dopo la maturità classica ho conseguito la Laurea in legge e sono diventata avvocato. Ma un drammatico evento ha completamente stravolto la mia esistenza e quella della mia famiglia: l’improvvisa perdita di mia sorella Francesca. Dopo questo grave lutto ho dedicato parte del mio tempo ad offrire consulenze gratuite nel modo del non profit. Ho conosciuto così l’organizzazione internazionale N.P.H. – Nuestros Pequeños Hermanos (i nostri piccoli fratelli), fondata nel 1954 per aiutare i bambini orfani abbandonati in America Latina, con uffici di raccolta fondi in tutto il mondo e con l’obiettivo di aprire un ufficio anche Italia. Nel dare questa consulenza, ho avuto l’occasione di leggere i libri scritti dal fondatore Padre William Wasson e di appassionarmi alla sua straordinaria opera. Dopo la conoscenza diretta di N.P.H. attraverso la visita dei progetti in America Latina e dei principali uffici di raccolta fondi in Europa, nel 2000 ho fondato la Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus, dedicata a mia sorella Francesca e della quale sono Presidente. Sono mamma di due ragazzi, abituati fin da piccoli ad essere i primi volontari della Fondazione. Abbiamo trascorso i nostri Natali e i periodi di vacanza ad aiutare i bambini delle Case N.P.H. ed è stato un grande privilegio che negli anni ho voluto offrire anche a centinaia di altri giovani e ai nostri donatori con le loro famiglie. Partecipare in prima persona e vedere con i propri occhi i progetti, rimboccarsi le maniche per partecipare alle attività, abbracciare i bambini, sono le esperienze che cambiano la vita di tutti, anche dei filantropi».
Che scopi ha la Fondazione Rava e quali pensa siano le ragioni per cui è riuscita in tempi così brevi a profilarsi a livello internazionale?
«La Fondazione Francesca Rava ha come mission l’aiuto all’infanzia e all’adolescenza in condizioni di disagio, le mamme e le donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo. Certamente una delle motivazioni che hanno spinto la Fondazione a profilarsi a livello internazionale è l’intervento in prima linea in modo tempestivo e concreto nelle emergenze che colpiscono i bambini e le loro famiglie. Con la sua costante opera, la Fondazione contribuisce, inoltre, al raggiungimento dei Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (UNSDG), lavorando anche al fianco delle aziende e della società civile. Aiutiamo i bambini tramite adozioni a distanza, progetti, la sensibilizzazione sui diritti dei minori, la diffusione della cultura del volontariato con programmi specifici in Italia e all’estero. I principali settori in cui opera sono l’assistenza sanitaria, l’istruzione, l’accoglienza ai bambini orfani, abbandonati o in disperato bisogno, con risposte immediate e programmi di empowerment a medio-lungo termine».
Di quali progetti si occupa concretamente la Fondazione?
«Il nostro cuore è nella poverissima Haiti, dove abbiamo realizzato l’ospedale Saint Damien, unico pediatrico, che assiste 80.000 bambini l’anno, struttura d’eccellenza realizzata e sostenuta dalla Fondazione Francesca Rava. La Fondazione rappresenta in Italia N.P.H. – Nuestros Pequeños Hermanos, organizzazione umanitaria internazionale che dal 1954 salva i bambini orfani e abbandonati nelle sue Case, scuole ed ospedali in 9 paesi dell’America Latina con il motto “un bambino per volta, dalla strada alla laurea”. Rappresenta, inoltre, la Fondazione St Luc di Haiti che riunisce i ragazzi cresciuti nella Casa N.P.H. sull’isola. Interviene con numerosi progetti di assistenza sanitaria, educativa e di empowerment. La formazione del personale sanitario, avviene grazie a gemellaggi con ospedali italiani d’eccellenza. Anche per questo, l’ospedale Saint Damien e l’ospedale Saint Luc sono Centri di riferimento sia per la lotta al Covid-19 che dei soccorsi per l’emergenza terremoto. Ma non solo. La Fondazione è costantemente attiva anche in Italia, su tutto il territorio nazionale. Con l’iniziativa “In Farmacia per i bambini” aiuta 40.000 bambini in povertà sanitaria; contrasta l’abbandono neonatale con il progetto nazionale “ninna ho”, realizzato insieme al Network KPMG; sostiene con progetti medici ed educativi i bambini di oltre 800 case famiglia, comunità per minori, enti che aiutano le famiglie in difficoltà. Nel Centro Italia colpito dal terremoto del 2016, ha realizzato 8 scuole. Nell’emergenza Covid-19 la Fondazione ha supportato 30 ospedali in 11 Regioni con invio di volontari sanitari specializzati e attrezzature altamente sofisticate. Con il progetto “SOS Spesa – La Spesa per chi ha bisogno” – ha aiutato 50.000 persone tra case famiglia e comunità per minori, famiglie e anziani soli e in povertà. Con il progetto “SOS Scuola” garantisce il diritto allo studio ai ragazzi accolti nelle Case famiglia e comunità per minori».
Al contrario di quanto avviene in America non esiste in Europa ancora un “The Giving Pledge”? Che cosa pensa di questo tipo di esperienza?
«Sarebbe molto bello se nascesse un The Given Pledge anche in Europa. Sicuramente la condivisione delle esperienze, in generale, e quindi anche nella filantropia, produce crescita, apprendimento e aiuta a indirizzare le forze verso best practices, proprio per guidare le risorse e la generosità in un modo sempre più efficiente ed efficace.
La condivisione permette di unire le forze dove c’è più bisogno, oppure di separare gli sforzi laddove è necessario rispondere a diverse aree di bisogno non coperte. Ma un elemento importantissimo di Gibbi in Pledge e l’emulazione e quindi lo sforzo dei filantropi di creare una cultura della generosità e di stimolare, attraverso il loro esempio, lo stesso comportamento positivo da parte di persone con analoghe risorse. Questo tipo di iniziative e di movimenti non attecchiscono facilmente in Europa per i principi della religione cattolica che insegna che la carità deve rimanere nascosta. Ma sempre di più anche sull’onda dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite, che impone obiettivi condivisi e dichiarati per tutti a partire dai cittadini, alle Aziende e ai filantropi; il momento è fertile per questo tipo di iniziative. Nella mia esperienza personale della Fondazione Francesca Rava è l’effetto straordinario, dato dall’esempio di donatori che nell’ambito dei nostri progetti e dei nostri eventi sono stati invitati a raccontare e a testimoniare la loro scelta filantropica a favore della Fondazione e i risultati concreti realizzati, producendo immediati effetti emulativi di altri filantropi».
Ritiene che possa essere proficuo che mecenati e filantropi si incontrino a ritmi regolari fra di loro? Quali pensano che possano essere i vantaggi?
«Penso che sia estremamente importante ed utile per gli scopi di arricchimento, di scambio e condivisione di cui ho appena parlato, purché non diventi un circolo chiuso ma, al contrario, un motore di energia positiva, di azione, di responsabilizzazione e di unione di forze per raggiungere obiettivi concreti e meccanismi virtuosi di bene attraverso il leading example. Può sembrare paradossale, ma è estremamente comune che una delle criticità più grandi che incontrano i filantropi è avere soddisfazione dalla allocazione delle proprie risorse pari allo slancio filantropico e allo spirito altruistico che li anima. Normalmente si dice che si riceve più di quello che si dona. Il filantropo per sua vocazione ha la promozione e creazione di felicità e benessere degli altri ed è molto sensibile nel percepire se questo si realizza proprio perché tale propensione viene dalla predisposizione d’animo molto sensibile e speciale. Perciò il filantropo non deve rischiare di distaccarsi dalla dimensione umana e concreta, quella più nobile dell’aiuto, che deve rimanere il focus dei dialoghi e degli scambi di questi incontri».
Quali caratteristiche dovrebbe avere un gruppo di lavoro di questo tipo sia dal punto di vista strategico che organizzativo?
«Riterrei utile una composizione nazionale ma anche internazionale. Per mantenere uno sguardo globale, dovrebbe porsi obiettivi chiari e strettamente pertinenti ai valori di cui i filantropi sono portatori, con attenzione a non uniformarsi ai numerosi convegni legati al terzo settore, alla solidarietà, alle politiche internazionali. Scegliere una guida carismatica, che si distingua per umanità e umiltà, con capacità motivazionali e organizzative. E tra gli obiettivi quello, il più nobile di tutti, che distingue i filantropi, la promozione del valore del dono e dello spirito altruistico come scopo ultimo».
Oggi la filantropia è esposta anche a critiche. Personalmente che cosa ne pensa?
«Si sente parlare di filantrocapitalismo, la versione più sofisticata della filantropia, che stanzierebbe in una strategia di una ristretta classe di filantropi che influiscono a livello politico sulla scena della globalizzazione economica e finanziaria. A mio avviso se uno dei nobili scopi del filantropo che può perseguire più facilmente aggregandosi con altri filantropi è l’influenza, tecnicamente l’advocacy, di buone pratiche e di attenzione alle tematiche o aree geografiche del pianeta dimenticate e in sofferenza. Non si può parlare di influenza negativa, anzi è esattamente uno degli esercizi che il filantropo responsabile deve compiere. Poi come in tutte le famiglie, il rischio è che qualcuno indossi il vestito del filantropo, svolgendo ruoli ingombranti in conflitto con l’animo puro del filantropo».
Che tipo di comportamenti si sente di suggerire ai beneficiari delle erogazioni filantropiche?
«Posso raccontare i principi e le linee guida che segue la Fondazione Francesca Rava e nei quali io credo moltissimo fin dal primo giorno della sua costituzione, ormai più di vent’anni fa. La serietà, la trasparenza sia nei conti che nei progetti, la persona al centro, a partire dal filantropo che si avvicina innanzitutto con l’anima e il cuore al nobile obiettivo della tua mission e desidera sentire quella connessione umana che è alla base della creazione del benessere, anche per gli altri. E poi l’apertura e il coinvolgimento del filantropo in alcune fasi attuative del progetto, creando occasioni di incontro con i beneficiari finali che sono la parte più importante della filiera del bene. Guardare con i propri occhi, toccare con mano le realizzazioni delle proprie erogazioni filantropiche è un tassello importantissimo. La gratitudine con la G maiuscola, deve essere in ogni parola e in ogni azione di chi riceve erogazioni filantropiche nei confronti del filantropo».
Perchè in tutto questo la comunicazione è la chiave di volta?
«Magari uso un modo di dire non proprio attinente, ma ciò che ripeto ogni giorno del mio lavoro in Fondazione è che prima è importante cucinare un buon arrosto, perché il suo profumo da solo non basta. Quindi dico sempre in Fondazione che prima si fa e poi si comunica, perché comunicare fumo, quindi le cose prima che siano realizzate, non ha efficacia, non ha valore e non è trasparente. Però è comunque indispensabile comunicare sia sottoforma di racconto e rendicontazione al filantropo, non solo con freddi report economici, ma soprattutto è molto importante attraverso testimonianze, immagini e video che riescono a documentare anche la verità delle emozioni e del cambiamento che insieme si è realizzato. E poi c’è la scelta di comunicare anche all’esterno, agli altri portatori di interesse, al fine di sensibilizzazione e stimolare un effetto emulativo. È fondamentale, in ogni caso, ogni volta concordare con il filantropo in base al suo stile, al suo sentimento e alla sua personalità che va sempre rispettata prima di ogni altra cosa».
Qual è da ultimo la sua visione per la filantropia del futuro?
«La filantropia è una condizione dell’essere umano, una disposizione dell’animo all’amore e al bene che si realizza attraverso il dono che non ha epoca. Non voglio dimenticare le parole che ne compongono il significato del greco antico: Filia (amore) e Antropos (uomo). Detto questo, credo tantissimo nella purezza dei giovani e se devo immaginare la filantropia del futuro, ma anche del presente, vedo i filantropi avvicinarsi di più al mondo dei giovani, anche solo dei loro nipoti e dei giovani che vivono tanti tipi di povertà: sociale, economica, educativa, per cogliere ispirazione e alimentare la purezza del loro animo filantropico e ascoltare ciò che i giovani desiderano per la creazione del benessere e di un mondo migliore».