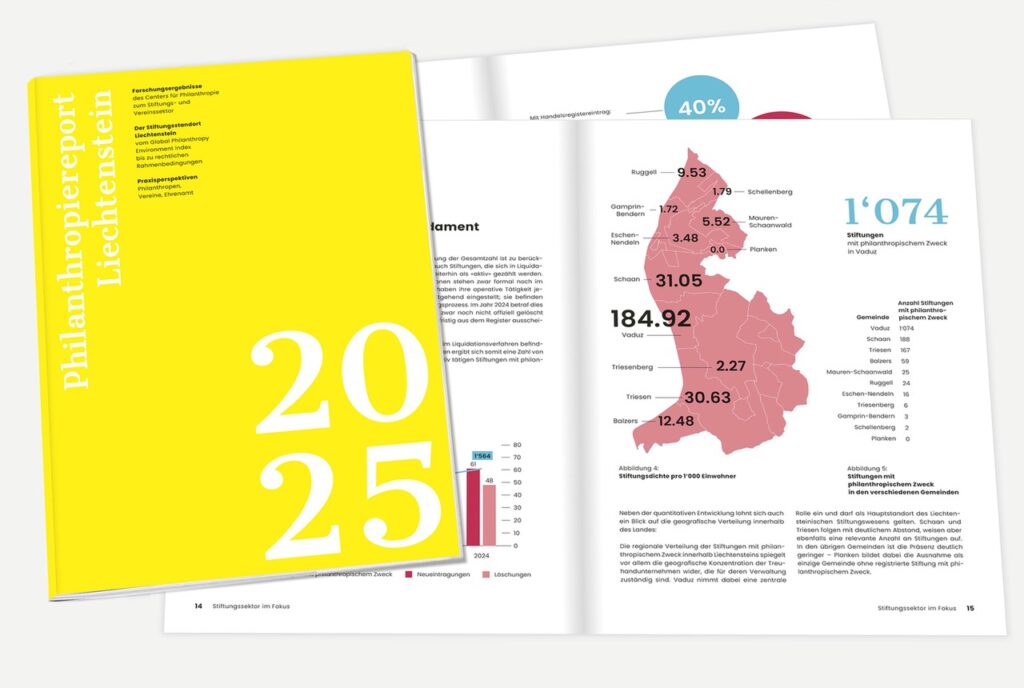Vuoi riassumere brevemente la sua lunga esperienza? Com’è nato il Conservatorio della Svizzera Italiana?
«Ormai sono vent’anni che ricopro la carica di direttore qui a Lugano, dopo aver lavorato come musicista e docente. (Per formazione sono violista e violinista, inoltre mi sono laureato in Storia e in Filologia italiana.) Sono stati anni intensi, di grandi progressi, come la creazione delle Scuole universitarie di musica e la sparizione di molti dei vecchi conservatori, le procedure di riconoscimento e accreditamento e certificazione del modello “Bologna”. Siamo riusciti a trasformare questa piccola scuola a respiro regionale in un istituto che ormai ha raggiunto un’importanza internazionale, grazie all’impegno e all’entusiasmo dei collaboratori e di chi ci ha sempre sostenuto».
Quali motivazioni hanno determinato la scelta di istituire una fondazione e qual è il suo scopo statutario?
«Il Conservatorio è una scuola giovane, nata più o meno in una notte del 1985 – sulle ceneri di un’altra scuola che aveva interrotto la sua attività -, sotto il nome di “Accademia di Musica della Svizzera italiana”, all’epoca sotto la forma di un’associazione formata da quattro persone, una delle quali era la nostra presidente, Ina Piattini Pelloni, un’altra mio padre, che ha assunto il ruolo di direttore. Dopo tre anni soli è arrivato il riconoscimento da parte della Conferenza dei direttori dei conservatori svizzeri, seguito dal riconoscimento da parte del Canton Ticino. Il nome è poi stato trasformato in “Conservatorio della Svizzera italiana” e l’associazione ha ceduto il posto e una fondazione di diritto privato. Da subito, 4 pilastri molto chiari: l’educazione musicale elementare indirizzata a bambini, l’educazione musicale amatoriale, entrambi l’organizzazione della scuola di musica, la formazione professionale dei futuri musicisti, oggi organizzata dalla Scuola universitaria di musica; infine la formazione dei docenti, con un Diploma di pedagogia musicale, oggi Master of Arts in Music Pedagogy. Nel 1999 è stato aggiunto un altro pilastro, con la formazione dei talenti e la creazione del corso pre-professionale, oggi Pre-College, che dispone di 55 posti e si applica in un numero chiuso come la Scuola universitaria».
Qual è la strategia della fondazione per il futuro a breve-medio termine?
«La trasformazione dell’associazione in fondazione di diritto privato, avvenuta in contemporanea con la mia nomina, aveva come scopo la creazione di una base giuridica più solida e sostenibile. Coincideva anche con l’incarico da parte del Consiglio di Stato Giuseppe Buffi, poi confermato da un mandato da parte del Consiglio di Stato ticinese nel 2000, di creare una Scuola universitaria di musica in Ticino. I nostri statuti enunciano, all’articolo 3, lo scopo della Fondazione: «La Fondazione ha lo scopo di promuovere nella Svizzera italiana la diffusione della cultura musicale, l’uso dell’insegnamento di base e quello professionale, come pure la promozione e l’accompagnamento di attività artistiche. La Fondazione persegue gli scopi di utilità pubblica e si astiene da ogni bene di lucro o di interesse privato. Oggi il Conservatorio della Svizzera italiana gestisce tre dipartimenti operativamente autonomi: la Scuola universitaria di musica per gli studenti professionali, il Pre-College per i talenti adolescenti e la Scuola di musica per l’educazione musicale amatoriale. La Scuola Universitaria è affiliata alla SUPSI, che si traduce in un’integrazione universale (che garantisce il riconoscimento dei titoli), un fronte di una completa autonomia amministrativa e gestionale. L’interazione tra questi tre dipartimenti è un elemento fondamentale del nostro successo e dà vita a numerose sinergie: un esempio tra tutti è la formazione dei docenti di strumento o di canto per le scuole di musica. Un altro esempio riguarda la promozione dei giovani talenti attraverso la possibilità di essere in regolare contatto non solo con gli studenti della Scuola Universitaria, ma anche con i musicisti di fama internazionale. Non sono da sottovalutare infine le sinergie “tecniche” come l’uso coordinato degli spazi e dell’organizzazione logistica».
Qual è la strategia della fondazione per il futuro a breve-medio termine?
«La strategia della Fondazione è articolata su vari livelli: abbiamo degli obbiettivi per la fondazione, validi per tutti i dipartimenti e degli obbiettivi strategici per i singoli dipartimenti, in base alle esigenze specifiche del relativo settore. Come valori principali vanno enunciati innanzitutto la qualità, intesa a tutti i livelli, a partire dalla scelta dei collaboratori, e che si esprime anche in un rigoroso controllo delle finanze. Siamo piuttosto orgogliosi del fatto che la nostra amministrazione è snella ed efficace. Ma la lotta alla burocrazia rimane una sfida di tutti i giorni. La Scuola di musica ed il Pre-College sono legati in un primo luogo al nostro territorio, vorremmo offrire a tutti i bambini e ragazzi un’educazione qualificata ed è un tutti i talenti una formazione mirata. La Scuola Universitaria è orientata verso un mercato di lavoro e un corpo studenti (e docenti) internazionale, aumentando contemporaneamente il numero di studenti confederati. Altro obbiettivi della Scuola Universitaria, nell’ambito della formazione, è l’aumento delgi studenti».
A quali progetti avete dato fornito negli ultimi anni e cosa avete pianificato per il futuro?
«Il progetto principale è la ricerca di una sede definitiva, organizzata da un campus per le nostre attività. Fondamentale la presenza di una sala da concerto . Sarebbe un sogno poterlo fare principalmente con l’aiuto di privati, com’è avvenuto e come accade nelle due scuole prestigiose di Basilea e Ginevra».
Da qualche tempo la Fondazione si occupa anche di mecenatismo, ce ne può parlare in dettaglio?
«Per una scuola come la nostra, creata e cresciuta grazie all’impegno e al sostegno di privati, il meccanismo è un elemento che fa parte del nostro DNA: senza i privati questa scuola non sarebbe né nata, né sopravvissuta. Personalmente, essendo nato e cresciuto a Basilea, ho vissuto l’attenzione del mecenatismo per la cultura e l’arte nella mia città. Come storico conosco inoltre benefici del meccanismo per l’arte durante i secoli, non solo per il valore in sé delle opere che ha generato, ma anche per gli aspetti economici che da quelle riverbera attraverso i secoli. Il tema del meccanismo è quindi di fondamentale importanza per il mondo della musica, è quindi stata una scelta logica inserire l’argomento nel nostro MAS in Gestione culturale, come elemento formativo».