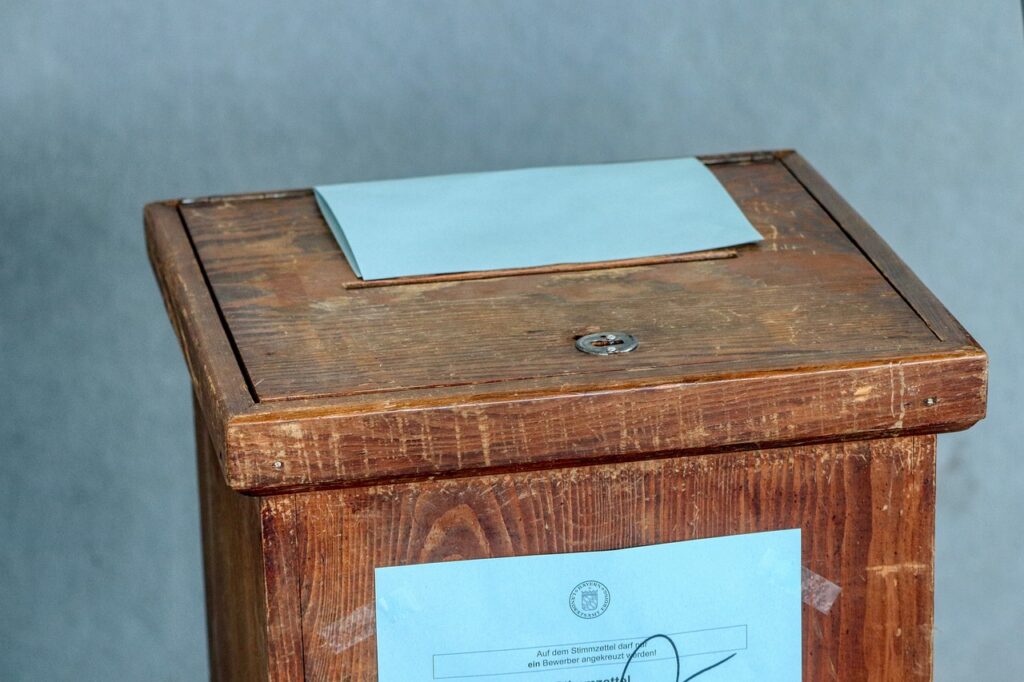Che ci sia un’urgente necessità di agire è evidente se si guarda all’ampiezza delle trasformazioni dal punto di vista economico e sociale. Durante i “trent’anni gloriosi” del secondo dopoguerra – quando la mobilità fisica individuale era diventata il simbolo della libertà – a dominare i mercati finanziari erano le grandi società produttrici di petrolio, le cosiddette “Sette sorelle”, un paio delle quali rimarranno fra i maggiori gruppi azionari al mondo fino a una decina di anni fa. Ma oggi, a dominare le borse sono tutte le grandi società americane del web Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft e le loro concorrenti cinesi Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi e Huawei (l’Europa è fuori gioco), che grazie alle tecnologie digitali hanno fatto dello scambio di informazioni e contatti sulla rete (la mobilità virtuale) e del commercio di dati il principale business del Ventunesimo secolo. Per dare un’idea, nel solo quarto trimestre del 2020 – l’anno della pandemia che ha paralizzato il mondo – il gigante delle reti sociali Facebook ha incassato 11 miliardi di dollari di utili, in crescita del 53% rispetto all’anno precedente.
I predicatori del nuovo “sole dell’avvenire digitale” vantano il vento rivoluzionario di questa svolta: il fatto che queste aziende non nascono da imperi dinastici come quello dei Rockefeller ma dalle idee geniali di alcuni giovani squattrinati studenti, partorite in un garage di casa o in una stanza del campus di Harward e trasformate in start up che hanno cambiato il mondo. Si compiacciono che grazie a Google, Apple e Microsoft l’informazione e il sapere non siano più appannaggio di pochi ma siano diffusi e condivisi; che grazie a Wikileaks i potentati politici ed economici siano nudi e grazie ai social network i cambiamenti sociali e la resistenza politica, le Primavere arabe o le rivolte popolari di Hong Kong, siano rese possibili e conosciute nel mondo intero. Nell’era dell’intelligenza interconnessa, l’informazione, l’interazione e addirittura le transazioni economico-finanziarie possono ormai avvenire senza intermediari, da pari a pari, e nell’era digitale una nuova imprenditoria è alla portata di tutti coloro che hanno le idee, la creatività e la tenacia per innovare lanciando una start up.
Tutto vero. Anche senza accompagnarla col suono delle trombe, la rivoluzione digitale è effettivamente senza precedenti, paragonabile – dicono alcuni – a quella della ruota e della stampa messi insieme. Ma questa è la faccia creativa e positiva di una rivoluzione che sta procedendo ad una velocità supersonica senza regole o quasi. Un processo che si sviluppa anarchicamente e che mette a dura prova l’apparato politico-istituzionale e giuridico costruito sull’arco di secoli a protezione dei diritti dell’uomo e della democrazia. Se ad esempio i social network permettono di trascendere le frontiere di nazionalità aprendosi agli altri su scala sovranazionale, d’altra parte essi configurano una società di tipo neotribale in cui i like e i dislike includono ma anche escludono clanicamente chi non risponde ai requisiti voluti. In cui i blog o i tweet possono trasmettere odio e dove l’informazione non verificata o manipolata può raggiungere una rete capillare di persone per favorire campagne di denigrazione, condanne senza processo e anche il terrorismo.
Nei social network dove si accede in modo nominale – visto che il finanziamento avviene tramite la consegna agli inserzionisti dei dati personali e comportamentali degli utenti – la privacy è invasa e la manipolazione dei comportamenti (consumistici ma anche politici) su vasta scala non solo è possibile ma già effettiva. Gli algoritmi, infatti, non sono neutrali. Dove sono finiti i principi fondanti delle nostre istituzioni democratiche come la presunzione di innocenza e il diritto ad essere giudicati da un tribunale e non dalla piazza, magari aizzata, o il diritto all’autodeterminazione tutelato dalla privacy? Oppure semplicemente la tolleranza nei confronti delle opinioni altrui? A questi quesiti sociopolitici che richiederebbero, con adeguate riforme giuridiche, il coraggio e la volontà di non seguire l’onda del popolaccio se ne aggiungono altri di natura economica e fiscale.
Di fronte all’odierno strapotere economico-finanziario dei giganti del web (il valore di mercato del cosiddetto GAFAM supera il PIL cumulato della Francia e della Germania) occorre avere la volontà politica di adottare misure incisive simili a quelle della legge votata nel 1890 negli Stati Uniti per contrastare i cartelli della Standard Oil di Rockefeller, l’American Tobacco e il gruppo chimico Du Pont. E trovare inoltre soluzioni internazionali che impediscano un dumping fiscale sistematico.
Questa necessità di non subire ma di governare la rivoluzione digitale e i suoi sviluppi – se si vogliono preservare valori fondamentali per l’individuo e la democrazia – non trova oggi un terreno particolarmente propizio. Infatti, il primo corno del gigante economico digitale è statunitense. Ciò significa che la rete è controllata e usata dai servizi di intelligence e dalle società americane in funzione degli interessi strategici della prima economia mondiale. Il secondo corno è cinese. Ciò significa che la rete è controllata pervasivamente e usata come strumento di potere da un governo autoritario per il quale la privacy, l’autodeterminazione personale e della società civile, i diritti democratici, sono repressi perché considerati d’intralcio al progresso “armonico”, economico e sociale, di un Paese gigantesco che mira a diventare economicamente egemone nel mondo. E che utilizza anche a questo scopo i formidabili strumenti di controllo su scala mondiale che offre la propria tecnologia digitale.
L’Europa, che in questo campo strategico è a rimorchio, non potrà non scegliere da che parte stare. Ma, mi auguro, investendo le proprie energie migliori per cercare da un lato di recuperare il terreno tecnologico perduto e dall’altro per contribuire a dare a una rivoluzione foriera anche di serie minacce un quadro etico-giuridico internazionale indispensabile.