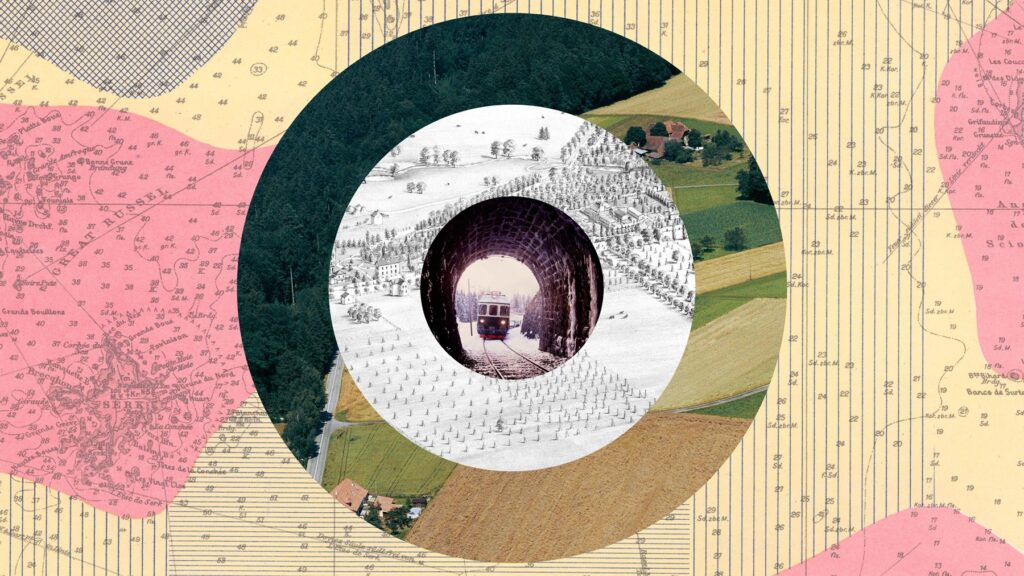Questo progetto nasce dalla volontà di Danna e Giancarlo Olgiati di muoversi all’interno di uno spazio fisico e mentale ben definito, quello dello studio, della casa scrigno, dei due collezionisti dalla forte attitudine umanista. Nel corso degli anni per loro vivere con e per l’arte li ha portati verso quella situazione dove lo sguardo dell’uomo si spegne e si illumina quello dell’artista.
La grande tela dell’artista ucraina, punto di partenza dell’intero progetto fa emergere composizioni sontuosamente cariche d’allusioni con l’uso dolcemente desueto del riferimento alla grande pittura del passato. In quest’opera di Kabakov, carica di simboli e significati, lo specchio inteso come rimando all’immagine doppia, visibile da entrambe le parti, cioè di chi dipinge e di chi guarda, non è soltanto un trucco del mestiere, per le possibilità formali e figurative che consente e per le deformazioni, i ribaltamenti, ma anche un oggetto d’affezione. Lo schema è quello reso celebre da Velazquez nel suo capolavoro Las Meninas 1656, probabilmente uno dei dipinti più studiati di sempre, grazie al quale viene introdotta una nuova possibilità del vedere e dell’essere in dialogo con l’opera d’arte, facendo sì che il pubblico divenisse la figura sovrana nel rapporto con l’opera.
Nel dipinto At the studio variation n.3 Ilya Kabakow mescola l’allusione alla tradizione classica della figura dell’artista con la presenza della bambina in azione – in attesa, inattiva, come in Velzquez – che con la sua acerba e istintiva propensione alla creazione infrange qualsiasi regola.
In mostra convivono opere molto diverse tra loro come il mosaico settecentesco, destinato ad una visione privata e rimasto in tale condizione per molti secoli, sorgente di devozione papale, fino a quella di un prelato molto importante come Rosmini, passando poi agli avi del collezionista, con quelle di artisti perfettamente aderenti al nostro tempo, contemporanei, attuali.
L’attraversamento di uno studio d’artista vuol dire incontrare qualcosa che forse ci aspettiamo ma che non conosciamo. La mostra si svolge in un susseguirsi di stanze nelle quali artisti di differenti epoche convivono in un dialogo ricco di assonanze e rimandi visivi, concettuali e sentimentali nei quali si incrociano livelli di pensiero differenti. Pietro Roccasalva che ben dialoga con i due fratelli più inafferrabili, disgreganti, del ‘900 italiano e non solo, De Chirico e quel genio di Savinio. A seguire una riuscita combine che vede assieme Rachel Whitered con i suoi pieni del vuoto, in questo caso espressione di un sentimento di morandiano sapore, che ben si armonizzano con la natura morta di Severini affiancata dagli oggetti biomorfi presentati in fotografia da Nairy Baghramian. Questa immagine ci porta verso la regina di un surrealismo al femminile: Luoise Burgeoise presente in mostra con la scultura Petit Object VII 1966, della quale viene presentata una carta dal disegno labirintico e spiraliforme, ben ci introduce alla gioia di vivere, di esistere, alla musicalità di un maestro come Melotti.
 Questa stanza appare come un regalo da parte dei collezionisti al pubblico. Una serie di sculture fino ad oggi custodite e godute solamente in ambito privato sono presenti in mostra: Tempo felice del 1983, Lager del 1972, Mediterraneo 1975, New Orleans phantasise 1979 e i Centauri 1969. A seguire la presenza fantasmatica, dolce e conturbante di Marisa Merz e la pacatezza classica, piena di significati delle Notti Bianche di Giulio Paolini, felicemente affiancato da delle perle vere, rosa, di Paola Pivi.
Questa stanza appare come un regalo da parte dei collezionisti al pubblico. Una serie di sculture fino ad oggi custodite e godute solamente in ambito privato sono presenti in mostra: Tempo felice del 1983, Lager del 1972, Mediterraneo 1975, New Orleans phantasise 1979 e i Centauri 1969. A seguire la presenza fantasmatica, dolce e conturbante di Marisa Merz e la pacatezza classica, piena di significati delle Notti Bianche di Giulio Paolini, felicemente affiancato da delle perle vere, rosa, di Paola Pivi.
Poi Il sogno e colto riferimento di Emilio Isgrò con il suo Jhoanna Ghiuditta (la veglia di Bach) 1985 ci immette nell’ambito dell’onirico, dove realtà e immaginazione convivono creando una nuova dimensione esemplificata da campi di colore, ambienti e architetture effimere, mentali, e viaggi interiori all’interno del corpo umano grazie a Pamela Rosenkranz e Henrik Olesen. Architetture che trovano compimento nelle visioni e nella scultura di Tatiana Trouvé, che con la sua luminescenza definisce lo spazio fisico e mentale della nostra presenza fisica. Lo spazio fisico innestato dall’artista franco italiana serve anche a ritrovare un sentimento necessario, quello dell’amicizia, della condivisione, del fare assieme. Ugo Mulas con le sue fotografie ce lo mostra. Le immagini che vediamo nascono dallo speciale rapporto di amicizia che si era stabilito tra lui e un gigante del ‘900 come Calder. Gli scatti vennero fatti durante uno dei soggiorni di Mulas presso la casa studio di Calder e a seguire l’intimità delle immagini di Cy Twombly nelle quali la predominante estetica compositiva trasmette un sentimento di grazia e piacere visivo assoluto.
Camminando nella mostra appare il Violoncellista del 1931 del più grande scultore italiano dell’epoca Arturo Martini. La passeggiata finisce incontrando due camei, una foto graffia di Vincenzo Agnetti, irriverente, caustico, poetico, apodittico e profondamente colto e l’altro prezioso inserto è il senza titolo di Franco Vimercati; una zuppiera fotografata nella sua fissità atemporale e quintessenza del concetto di natura morta o piuttosto di still life, che restituisce al meglio la sua vita interiore. Questo è l’attraversamento di uno studio, pensato e costruito tra lo scrittoio dello studiolo e la pratica quotidiana di condivisone con gli artisti e con le loro opere, al fine di poter vivere una vita piena di significati. Tornando ai Kabakov, artisti concettuali per eccellenza, sanno benissimo che il quadro non è uno specchio che riflette tutto quanto essi hanno vissuto ma hanno la consapevolezza che è un oggetto potente, espressivo.