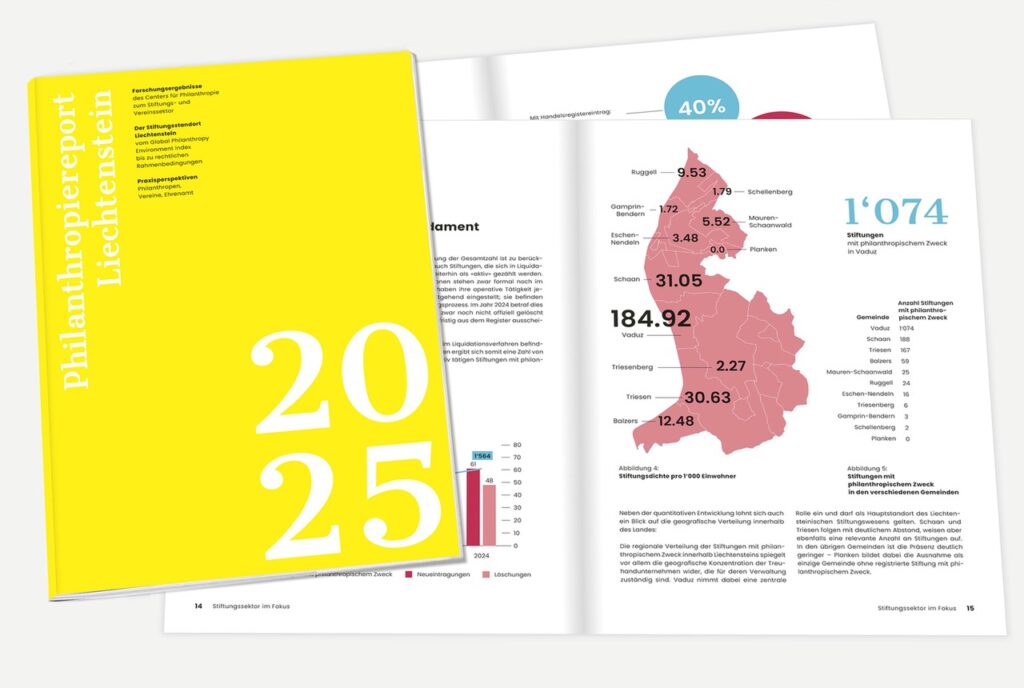Lei è il nipote dell’ultima principessa Esterházy, appartenente ad una delle più antiche e gloriose casate d’Ungheria. I suoi membri sono stati conti e principi, sportivi e anche scrittori. Vuole raccontarci qualche aspetto meno noto della storia della sua famiglia?
«Sposando nel 1946 Melinda Ottrubay, di famiglia borghese, l’ultimo principe Paolo V Esterházy scelse molto presto di inaugurare un’era nuova nella storia della sua casata. Alla sua morte, nel 1989, lasciò in eredità alla moglie l’intero importante patrimonio storico, culturale e architettonico degli Esterházy. A partire dal 1994, Melinda lo trasferì a diverse fondazioni private austriache a carattere indissolubile. Oggi, nell’interesse della conservazione e salvaguardia di questo significativo patrimonio storico, manteniamo buoni rapporti con numerosi membri della famiglia Esterházy. A partire dalla fine del XVI secolo, dalla linea principesca austriaca originaria, sono nate nuove famiglie e discendenze, i cui membri oggi vivono in diverse parti del mondo.
Nel 1994 abbiamo trasformato un’istituzione locale sonnacchiosa e priva di strategie lungimiranti in un moderno gruppo di imprese. Nel 2002, l’amministrazione è stata riunita in una società di gestione e dotata di una moderna organizzazione. Siamo passati dai 147 collaboratori iniziali ai 500 di oggi. Questi ultimi sono attivi con molto successo in 12 divisioni fra loro indipendenti. Il fatturato totale è passato da poco meno di 17 milioni di euro a quasi 100 milioni, grazie anche all’inserimento di nuove aree di business».
Gli Esterházy sono stati anche grandi filantropi. In quali settori sono attive le fondazioni oggi e perchè?
«La casata Esterházy ha vissuto e operato in un’epoca in cui lo Stato, nell’odierna accezione, non esisteva. Non c’era nemmeno l’assistenza sociale come la intendiamo oggi, né l’istruzione pubblica e molto altro ancora. Queste attività erano nelle mani della Chiesa, dei grandi proprietari terrieri e dalla nobiltà. Solo nella seconda metà del XIX secolo, questi servizi furono gradualmente assunti dallo Stato o dai mecenati borghesi. Insieme alla Chiesa, gli Esterházy erano i maggiori proprietari terrieri dell’Ungheria storica, ed era naturale che questi compiti fossero centrali nell’attività della famiglia.
Trecentocinquanta anni fa l’imperatrice Maria Teresa aveva posto l’alta nobiltà sotto un forte controllo politico e militare. In questo modo nacque una prima forma di Stato costituzionale, grazie al quale furono arginati i conflitti aperti contro il potere centrale. Così, le grandi famiglie nobili cominciarono a concentrarsi sull’istruzione, la musica e la promozione culturale e anche su compiti sociali ed educativi.
Erano in forte competizione fra di loro, ed erano soliti mostrare al mondo esterno il proprio potere e influsso. La casata Esterházy si distinse molto presto nelle attività a sostegno di arte e cultura. Nel XVI e nel XVII secolo furono eretti magnifici edifici, che ancora oggi sono monumenti e punti di riferimento della regione pannonica e del Burgenland. Furono istituiti archivi, tenuti registri pubblici e molto altro ancora. Grazie alla grande attività di collezionismo dei miei antenati è nato anche il «Tesoro e il Gabinetto delle Curiosità dei principi Esterházy», famoso a livello internazionale. Non esiste nulla di paragonabile al mondo. La musica era già di grande importanza intorno al 1650. Non sorprende quindi che, cento anni dopo, Franz Joseph Haydn abbia scelto la corte principesca degli Esterházy come luogo in cui operare e comporre, e sia diventato ben presto famoso in tutto il mondo».
Come è nato il suo interesse personale per la filantropia?
«Sono nato in una famiglia borghese in cui era scontato avere ampi interessi per la res pubblica e per la politica. Durante la mia frequentazione del ginnasio a Lucerna, la mia città natale, ho maturato un interesse per le materie culturali classiche.
Grazie ai contatti più stretti in Svizzera con l’ultima coppia di principi, Melinda e Paul, da adolescente mi sono interessato alla storia dell’Austria e dell’Ungheria. Il primo compito della Fondazione è di studiare le importanti collezioni della famiglia, restaurare gli oggetti, catalogarli e renderli disponibili al pubblico. Questo lavoro ha avuto inizio nel 1955, dopo che i russi hanno lasciato l’Austria.
Dal mio arrivo in Austria nel 2022, abbiamo dato a queste attività una dimensione professionale. Da allora, le nostre collezioni e i nostri pezzi sono stati esposti in prestigiose mostre a Villa Borghese, al Louvre, nel Palazzo di Compiègne vicino a Parigi, ma anche al Metropolitan Museum di New York, al Museo Nazionale di Dresda, eccetera. Nel 2010 abbiamo iniziato a occuparci di musica classica e anche del St. Margarethen Opera Festival (con 90.000 spettatori all’anno). All’epoca non eravamo soddisfatti della qualità dimostrata in passato e vedevamo la possibilità di un sicuro miglioramento. Da allora il nostro obiettivo è stato quello di uscire dal provincialismo e raggiungere una visibilità nazionale e internazionale. Possiamo dire di esserci riusciti. Insieme ai nostri dirigenti siamo fermamente convinti di doverlo al grande nome della famiglia Esterházy».
Cosa significa per lei essere un mecenate oggi?
«I mecenati devono sforzarsi di colmare le lacune dell’offerta statale nella cultura, nel settore sociale oppure nell’istruzione. Ci siamo anche posti l’obiettivo di migliorare la regione pannonica su entrambi i lati del confine, motivando le persone in modo positivo. Con la sponsorizzazione e le attività di mecenatismo, cerchiamo una stretta relazione con la comunità imprenditoriale, ma anche con i privati, attraverso i circoli degli sponsor e degli amici delle varie istituzioni. L’attività pro bono dei mecenati non deve a mio parere semplicemente sfociare in un piacevole sentimento privato, ma quest’ultimo deve sempre analizzare gli obiettivi e gli effetti a lungo termine per la società civile».
Di che cosa si occupa la Fondazione Melinda Esterházy de Galantha con sede a Zurigo?
«Promuoviamo in particolare la formazione di giovani musicisti e di artisti professionisti di danza classica. A questo scopo, manteniamo una stretta relazione con il Teatro dell’Opera di Zurigo e con il Festival di Lucerna, famoso in tutto il mondo».
Lei è noto per il suo entusiasmo per l’arte: come è nata la sua passione per la musica? È anche un fautore della filantropia strategica: come vive questa sfida?
«Sono una persona che pensa razionalmente. Per me l’arte e la cultura sono un importante livello di comunicazione nella comunità umana. Il primo livello è la lingua parlata, il secondo è la scrittura, con la sua ricca storia di oltre 4.000 anni. Il terzo livello sono l’arte e la cultura vere e proprie. Rappresentano una dimensione attraverso la quale le persone e le società comunicano tra loro. Ma ci sono stati anche dei lati oscuri: attraverso l’arte e la cultura si sono glorificate le guerre, si è sostenuta l’oppressione, si sono rappresentati popoli, generi e razze come inferiori. Abbiamo bisogno di arte e cultura perché molti contenuti e messaggi possono essere trasmessi rapidamente, in modo differenziato e duraturo, attraverso le generazioni.
Purtroppo, nella società odierna arte e cultura sono talora impiegate anche per separare le cosiddette élite dal resto della popolazione e per formare delle cosiddette “bolle”. In passato, il latino ecclesiastico svolgeva un ruolo simile, e l’adesione a certi generi musicali può avvenire con l’intento di creare una “bolla per l’élite”. Mi sono sempre opposto a questo tipo di atteggiamenti. Per me, l’arte e la cultura di alta qualità devono essere presentate, per quanto possibile, in un modo accessibile a tutta la socità civile. L’arte ha sempre qualcosa di educativo. Abbiamo sperimentato di persona quanto questo modo di porsi sia accolto con gratitudine dai fruitori delle manifestazioni culturali».
L’ex ministro della cultura italiano Dario Franceschini ha pubblicato un libro intitolato “Con la cultura non si mangia?”, che analizza il motivo per cui gli Stati a volte fanno così poco per sostenere le rispettive industrie culturali, compresa la moda, sebbene queste generino posti di lavoro, esportazioni e anche felicità. Perché è così a suo parere?
«Come ho già ricordato in precedenza, sono dell’opinione che i mecenati debbano intervenire in aree che lo Stato non riesce a coprire. Sono convinto che in questo processo ci debba essere una stretta comunicazione. Per due ragioni: in primo luogo per evitare doppioni, in secondo luogo per creare sinergie. Ecco perché sono contrario ai “programmi segreti”. Il filantropo o il mecenate deve comunicare con il pubblico il più regolarmente possibile e presentare relazioni sulle proprie attività. Da un lato, questo serve a promuovere la comprensione per le attività avviate, dall’altro a ricevere critiche positive e costruttive. Sono convinto che si impari da ogni critica, anche quella più insignificante. Perciò seguiamo questo principio in ogni attività delle Fondazioni Esterházy».
Qual è la sua visione per il futuro della filantropia in Svizzera, Austria ed Europa?
«Molti mecenati utilizzano i beni acquisiti o ereditati per la loro attività filantropica. È quindi importante il rispetto della tradizione famigliare. Nei Paesi europei, i filantropi per le loro attività sono spesso soggetti a tasse aggiuntive. Dovrebbe invece valere il contrario!
La società dovrebbe alleggerirli dagli oneri fiscali, soprattutto se svolgono compiti importanti per il bene comune. In tempi quali quelli attuali, in cui la ricchezza è stata creata rapidamente, in un momento storico in cui anche grazie alla digitaliazzazione si sono creati velocemente enormi patrimoni, è importante che i filantropi agiscano con grande trasparenza.
Considero un preciso compito di noi mecenati quello di spiegare come vengono impiegati i fondi, in modo che l’opinione pubblica comprenda immediatamente se sono utilizzati in modo sensato. Dobbiamo considerare che, se non si agisce in modo trasparente, si accendono invidie, si eleva la voglia di tasse e oneri speciali che finiscono per ostacolare l’imprendorialità, chiave importante per la filantropia del futuro».