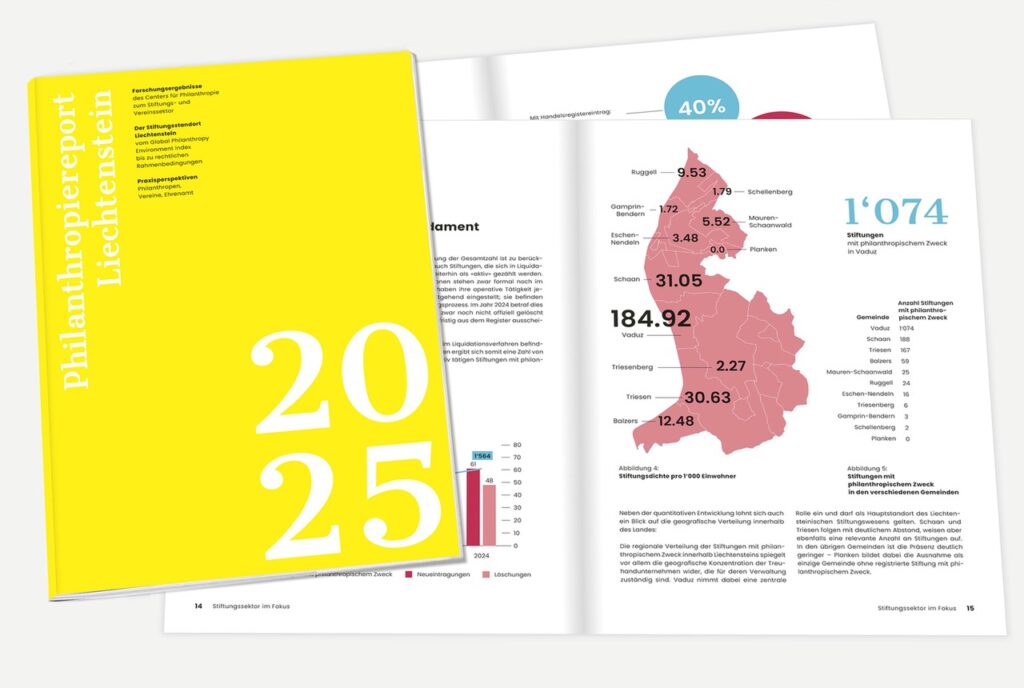Nei primi 10 anni dalla nascita della Fondazione Agire, lei ha rivestito la carica di Presidente, dalla costituzione (2011) fino al 2019. Quali sono state le tappe più importanti nel tempo e perché?
«Il periodo antecedente l’istituzione di Fondazione Agire è stato caratterizzato da numerose discussioni e iniziative, soprattutto con AITI e DFE, riguardo a quale fosse il modo migliore per assicurare che le attività universitarie di ricerca avessero una ricaduta economica sul tessuto produttivo ticinese. In quest’ottica era stato costituito Ticino Transfer che aveva proprio il compito di assicurare questo trasferimento di tecnologia verso le start up. All’epoca emerse tuttavia una volontà politica più lungimirante, con l’obbiettivo di provvedere, oltre che al trasferimento di tecnologia, anche al finanziamento delle start-up, grazie all’istituzione di un apposito fondo da parte della Banca Nazionale Svizzera. La decisione non fu semplice per la necessità di garantire autonomia e trasparenza e al tempo stesso dare adeguata rappresentanza alla politica, alle università e agli attori economici coinvolti nel progetto. Alla fine, parteciparono come soci fondatori USI, SUPSI, Camera di Commercio, AITI e, naturalmente, il Cantone. Nel tempo poi sono entrati a far parte di Fondazione Agire altre istituzioni, come la Città di Lugano, l’ABT, Enti regionali di sviluppo e il Centro di competenza sulla mobilità che ha determinato anche l’ingresso della città di Bellinzona. Nel corso del mio mandato sono state numerose le iniziative prese a supporto di progetti di innovazione, fino agli sforzi compiuti e coronati dal successo di associarsi a Switzerland Innovation (SI) che dischiude nuove prospettive di sviluppo futuro per Fondazione Agire».
Quale è stato l’impatto di questa scelta di estendere la presenza in Fondazione Agire a tutti i principali attori economici del Cantone?
«In teoria avremmo dovuto costituire un sistema fortemente coeso sui temi in agenda. Di fatto, non sempre i partner sono stati in grado di mettersi d’accordo su tutte le questioni da affrontare. Ciò era naturalmente comprensibile tenendo conto dell’eterogeneità dei soggetti coinvolti, ma comunque abbiamo potuto discutere anche informalmente riguardo alle scelte che il Cantone e le altre istituzioni coinvolte dovevano di volta in volta operare sul tema dell’innovazione. Un grande successo è stato senza dubbio quello di essere riusciti, pur nel rispetto delle differenze, a mettere intorno allo stesso tavolo istituzioni che difficilmente, tutte insieme, si sarebbero confrontate, arrivando molto spesso a prendere decisioni importanti».
In che modo il lavoro svolto da Agire ha influito sull’evoluzione del tessuto imprenditoriale ticinese, in particolar modo per quanto riguarda la nascita di start up innovative e lo sviluppo dell’innovazione nelle PMI?
«Ritengo che Fondazione Agire abbia contribuito a dare una prospettiva nuova, più dinamica, al tessuto produttivo locale e abbia concorso a rendere l’attività delle università più vicina all’economia reale del Cantone. Una questione quest’ultima molto discussa e dibattuta, al punto che talvolta ci siamo posti il problema di come rapportarci per rappresentare al meglio il settore dell’economia in generale e quello delle imprese in particolare. Nel mio periodo di presidenza questo equilibrio è restato ancora instabile, ma ciò costituiva un presupposto necessario per la crescita dell’intero sistema. La definizione dell’esistenza di un quadro di riferimento coerente, all’interno della regione, ha certamente aiutato chi voleva fare impresa partendo proprio dall’inizio: un supporto forse più culturale e morale che non in termini esclusivamente economici. Per fare buona impresa bisogna infatti sentirsi soprattutto accettati dalla società. Il fatto che le nuove imprese, con i loro successi e insuccessi che fanno parte della vita di un’organizzazione, siano ora più accettate nel panorama economico e sociale di questa comunità, penso che rappresenti un obbiettivo e anche un merito che la Fondazione Agire ha perseguito e raggiunto attraverso tutte le sue attività nel corso degli anni».
Quale ritiene essere stato il suo personale contributo al successo del progetto Agire e quale, per contro, il rimpianto per non essere riuscito a realizzare qualcosa che avrebbe voluto si concretizzasse?
«Parlare di me stesso non mi è mai piaciuto, se non in un ambito familiare, ma capisco che in questa occasione sia doveroso. Ho fatto parte della comunità delle scuole universitarie svizzere con orgoglio e passione, ma sono stato a lungo e sono ancora un imprenditore. La speranza di essere riuscito a coniugare lo spirito che anima il ricercatore e il docente universitario con quello che guida la missione imprenditoriale rappresenta probabilmente il miglior contributo che sia riuscito a dare alla Fondazione. In altre parole, ho cercato di esprimermi attingendo alle due distinte competenze derivanti dalle mie professioni, coniugando e portando negli obiettivi della Fondazione lo spirito imprenditoriale e la curiosità del ricercatore. Le due cose possono coesistere e possono insieme partecipare a creare benessere e progresso. Nella quotidianità del lavoro pratico è stata poi la volontà di mettere in discussione tutti i temi più importanti a contraddistinguere il mio impegno negli anni e sul cui risultato lascio i posteri a giudicare.
Il rimpianto maggiore è costituito dalle difficoltà che ho avuto nel raggiungere il consenso e da quelle incontrate nel discutere con la politica. Probabilmente non sono un politico e rifuggo dalla logica legata al consenso a tutti i costi, anche se rispetto questo atteggiamento. Malgrado questa mia manchevolezza credo di aver conferito all’azione e al prestigio di Fondazione Agire la necessaria “autorevolezza”, nella consapevolezza che la maggiore coesione possibile del sistema è sempre necessaria per produrre i migliori risultati».
Quali ricordi la legano più profondamente alla storia dell’agenzia per l’innovazione che festeggia i suoi primi dieci anni di vita?
«A costo di apparire un po’ “deamicisiano” devo dire che per me l’amicizia con i membri e i collaboratori rappresenta un valore che poi genera risultati e che sta al di sopra di tutti i ricordi. Proprio per questo non voglio citare nomi e cognomi, si farebbe ingiustizia rispetto a molti. Però chi mi ha affiancato nelle mansioni di Presidente e che ha dato un supporto alla persona oltre che alla funzione non potrà mai essere da me dimenticato».
Dal suo osservatorio privilegiato, come sono cambiate, anche prima della pandemia, l’economia e la società ticinesi, soprattutto per quanto riguarda la voglia di innovare e fare impresa?
«Economia e società sembrano essere in Ticino un po’ più internazionali, più votati alla produzione di beni e servizi e anche più coesi nella realizzazione di certi obiettivi. Provo orgoglio nell’osservare che la Fondazione è stato il luogo di concertazione di molte strategie, per esempio di USI e SUPSI che spesso si confrontano e sono antagoniste, di AITI e CC-TI che sono associazioni talvolta con obiettivi concorrenti, della città di Lugano e di Bellinzona che hanno entrambe l’ambizione di prevalere».
Qual è il suo auspicio per il futuro dell’agenzia dell’innovazione e, in generale, per la cultura dell’innovazione in Ticino?
«Le azioni che vogliono innovare e rinnovare necessitano di coraggio, unità ed escludono i personalismi, che sono alcuni degli elementi in grado di frenare e vanificare talvolta lo sforzo della sfida. L’auspicio è che si sia sempre più in grado di essere coerenti rispetto a questo atteggiamento».
Infine, quale consiglio si sentirebbe di dare a coloro che ritengono di avere una “buona idea” imprenditoriale?
«Non avere paura e fare affidamento soprattutto sulle proprie forze. La Fondazione Agire può dare un sostegno molto utile rappresentando una realtà che le appoggia e le aiuta. La propria capacità personale è poi quella che fa la differenza tra riuscita e non riuscita di una impresa».