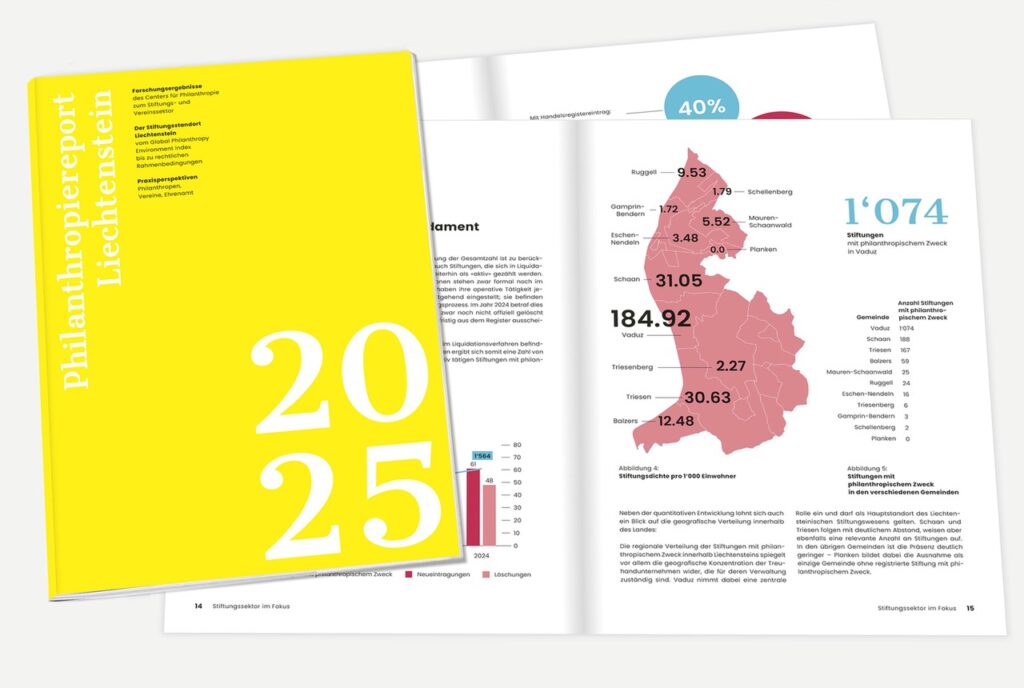Tanto potere, mancanza di controlli, defiscalizzazione: che cosa ne pensa delle critiche alla filantropia?
«Nell’ultimo anno siamo stati sottoposti a un vero bombardamento di informazioni spesso lacunose, quasi sempre unilaterali. Sono stati pubblicati libri, articoli, tenute conferenze e discorsi che hanno creato molta confusione. Da mesi il J’accuse contro la filantropia sembra non avere termine, mentre sempre più di rado si menziona quanto di buono e insostituibile quest’ultima abbia fatto da secoli. La critica ai filantropi americani per es. ignora i risultati conseguiti da alcune fondazioni filantropiche che hanno finanziato la cura di malattie importanti come la malaria, in molti Paesi emergenti. Il mio parere: la critica serve sempre, ma deve essere costruttiva, ben documentata e puntuale, la filantropia americana a titolo di esempio ha ben poche analogie con quella svizzera o italiana».
Come reagisce il settore non profit?
«In Svizzera, apparentemente, c’è calma piatta, ma solo in superficie. In realtà il settore non profit si preoccupa non poco, così come le istituzioni culturali, che hanno ricevuto e ricevono elargizioni importanti, quando non insostituibili, durante un periodo difficile come quello della pandemia. Temono a ragion veduta, che l’attacco mediatico ad alcuni mecenati interferisca con le donazioni. All’estero, invece, il libro di Beth Breeze In defence of philanthropy (Columbia University Press, New York, 2021), ha fatto molto discutere. L’autrice affronta le principali critiche mosse alla filantropia, e mette in discussione le ragioni per cui vengono screditati i gesti e gli investimenti filantropici».
Che cosa sostiene in particolare l’autrice?
«In una intervista con Phil Buchanan, Presidente del Center for Effective Philanthropy, pubblicata nel Philanthropy New York News, l’autrice sostiene che “In primo luogo c’è una critica accademica incentrata sull’indebito potere e influenza (della filantropia), e l’insinuazione che le grandi donazioni minino la democrazia. C’è stato uno slittamento dalla constatazione da che, in alcuni casi, la filantropia possa essere un modo di esercitare il potere, che è ovviamente vero, fino all’affermazione che tutta la filantropia è potere, una grossolana esagerazione. Vale anche la pena ricordare che gli organi eletti creano il quadro entro il quale la filantropia si verifica, compresa la definizione di ciò che si qualifica e non si qualifica per gli sgravi fiscali, la dimensione di questi sgravi e chi può richiederli.
L’incapacità di regolare adeguatamente il settore della filantropia – e, per questo, l’incapacità di finanziare adeguatamente i servizi pubblici, che poi hanno bisogno di cercare il sostegno privato – sono ovviamente esempi di fallimento dei governi, non di fallimento del settore filantropico. In secondo luogo, c’è quella che io chiamo la “critica degli addetti ai lavori”, che viene dall’interno del settore nonprofit e si concentra sulla distribuzione (o sulla cattiva distribuzione, come la vedono loro) dei finanziamenti filantropici”. La proposta che donare dovrebbe conseguire i migliori risultati possibili è del tutto incontestabile, perché ogni donatore vuole che il suo contributo sia usato bene. Ma tradurre questo sentimento incontestabile in linee guida specifiche su come condurre la filantropia, è meno semplice. La filantropia è profondamente personale, e spesso radicata in esperienze e problematiche autobiografiche, quindi sentirsi dire di eliminare le preoccupazioni soggettive e usare solo l’aritmetica altruistica per allocare le donazioni, può eliminare la passione e la gioia del donare, e farlo sembrare più come pagare una tassa obbligatoria che una generosità volontaria.
Diciamo che, se il prezzo di una minor gioia del donatore vale il miglioramento dell’impatto sociale, c’è anche una questione fondamentale sull’inadeguatezza delle metriche disponibili per guidare le scelte delle donazioni. L’attenzione delle critiche degli addetti ai lavori per gli approcci rigorosi, basati sui dati e sul business, spesso si incaglia quando si confronta con la realtà dei complessi obiettivi filantropici e con il modo in cui il cambiamento sociale avviene nella pratica. In terzo luogo, c’è una critica populista che incoraggia una comprensione semplicistica del ruolo complesso e della pratica variegata della filantropia.
I populisti – che spesso si trovano nei social media – liquidano tutte le donazioni private come una “farsa dell’élite” che maschera un’agenda di interessi personali. I grandi filantropi sono abitualmente rappresentati come ipocriti antipatici che usano le “buone azioni” per assicurarsi un buon affare per se stessi, mentre le spiegazioni auto-riferite per le donazioni – come la gratitudine, la preoccupazione per gli altri, o il piacere di fare un lavoro significativo – sono liquidate come falsità o falsa coscienza. Decenni di ricerche accademiche mostrano che le “motivazioni miste” sono la norma sia per i donatori facoltosi sia per quelli che non lo sono, eppure i populisti avanzano l’idea che coloro che hanno grandi conti in banca siano del tutto incapaci di altruismo. I grandi donatori si trovano a dover affrontare scenari perdenti come l’essere considerati loschi e poco trasparenti se donano segretamente, o come ego-driven, manipolatori dell’immagine se donano pubblicamente». Concordo profondamente con Beth Breeze e le sue tesi».
Chi è critico nei confronti della filantropia parla spesso di filantrocapitalismo. Che cosa significa questo termine?
«Di filantrocapitalismo negli ultimi anni si è parlato parecchio, tanto da accendere un dibattito sul suo significato, quello di applicare modelli di business al mondo della filantropia, favorendo nel comparto non profit, un orientamento al ritorno degli investimenti. L’obbiettivo è quello di riuscire ad amministrare i grandi patrimoni filantropici con lo stesso know-how e le stesse competenze con cui si gestiscono quelli finanziari. In questo modo, si garantirebbe un flusso continuo di risorse da destinare a quei progetti ritenuti di utilità sociale o culturale».
Quali sono gli interrogativi più frequenti negli ambienti critici verso la filantropia?
«Sono sulla natura stessa della filantropia. In questi ambienti, infatti, ci si domanda se questa sia un diritto individuale che deve essere esercitato nella piena libertà di azione, oppure un motore di trasformazione sociale, bisognoso di regole condivise, di un intervento di tipo pubblico a favore di una circolazione del denaro più equa e solidale. Sono quesiti legittimi, ma che non debbono minare l’importanza della filantropia e del partenariato virtuoso tra pubblico e privato, uniti nel realizzare il bene comune. La potenzialità benefica della filantropia è dimostrata da secoli di collaborazione tra filantropi, mecenati e artisti, dei cui risultati la società civile gode fino ad oggi».
Qual è la sua posizione al riguardo?
«È compito dell’Accademia riflettere sulle questioni politiche e di principio, degli Stati di assicurare le condizioni quadro adeguate, il mio è di riflettere sulla pratica. Alcuni argomenti dal mio punto di vista.
Analizzando i grandi numeri sappiamo che il 36% delle donazioni a livello mondiale sono di filantropi (Wealth X UHNW_Philanthropy 2022). Sappiamo anche che oggi la filantropia è al primo posto delle attività non professionali a cui si dedicano persone molto facoltose (Ultra High Net Worth Individual), di cui oltre 295.000 stimate al livello globale da Wealhx, una delle fonti di riferimento più accreditate del settore (World Ultra Wealth Report, Wealth-X, 2021).
I dati parlano chiaro: la filantropia non è un fenomeno di pochi ma di moltissime personalità impegnate a vario titolo in tutto il mondo. Pensiamo per esempio all’opera di John Sainsbury, delle famiglie Hoffmann, Oeri, Rotschild, a Marino Golinelli, a Jorge M. Pérez, a Eli Broad, ai Bodmer, ai Keller, ai Syz per citare un paio di famiglie zurighesi; all’opera preziosa di donne come MacKenzie Scott, Elsa Peretti, Delfina Entrecaneles, Graziella Lonardi Buontempo, Christine Cerletti-Sarasin, Denise Benedick, Carolina Müller-Möhl, a Mirjam Staub-Bisang che aiuta decine di donne meritevoli a studiare…l’elenco dei mecenati e filantropi è quasi infinito.
Gran parte delle organizzazioni non profit attive a livello internazionale come Unicef, Medici Senza Frontiere, WWF, lavorano con mecenati e filantropi che aiutano in modo significativo a realizzare progetti in tutto il mondo. Uno sguardo ai siti delle varie istituzioni basta per sincerarsene personalmente.
La filantropia può mettere a disposizione risorse in tempi veloci anche quando i progetti sono di nicchia o a rischio di fallimento. Per la cultura ad esempio, questo significa poter perseguire strade sperimentali senza essere costretta continuamente a porsi l’interrogativo del risultato immediato. Mi viene in mente l’esempio di Michael Pieper con il suo fondo per l’innovazione, destinato a favore dell’orchestra sinfonica di Lucerna.
Durante il periodo più difficile della pandemia, per fare un altro esempio, le fondazioni filantropiche nel Nord Italia e non solo hanno fatto un lavoro eccellente di accompagnamento e sostegno a migliaia di persone in stato di grave difficoltà. E numerose sono state le donazioni di filantropi individuali: Diego Della Valle (5 milioni di euro per i familiari del personale sanitario che ha perso la vita a causa della pandemia), la famiglia Zegna (3 milioni di euro alla Protezione Civile Italiana) Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti (1 milione di euro all’ospedale Columbus Covid 2/ Policlinico Agostino Gemelli di Roma), la famiglia Benetton, attraverso la holding Edizione (3 milioni agli ospedali Ca’ Foncello di Treviso, Sacco di Milano, Spallanzani e Policlinico Agostino Gemelli di Roma), Giuseppe Caprotti (10 milioni a sostegno di iniziative terapeutiche in Lombardia contro il coronavirus)…e potrei continuare.
Inoltre le associazioni di settore hanno promosso studi sugli effetti benefici della filantropia, studi disponibili per esempio nei siti di Assifero, SwissFoundations, Philea-Philanthropy Europe Association per citarne solo alcuni. Allo stato attuale molte iniziative non potrebbero sussistere senza l’aiuto dei filantropi.
Quello che mi sta a cuore dire è che non è possibile e non è corretto dal mio punto di vista, neanche nell’ottica di un’analisi scientifica di questo fenomeno, ignorare l’impatto sociale generato da queste iniziative.
È semplicistico generalizzare la critica ad alcuni dei filantropi più esposti mediaticamente e perdere di vista l’intero fenomeno. Occorre invece includere nell’analisi le centinaia di organizzazioni non profit beneficate, che dovrebbero essere messe in condizioni di esprimersi puntualmente al riguardo. È bene quindi che una discussione abbia luogo ma quest’ultima va contestualizzata in un discorso più ampio di relazione fra le istituzioni pubbliche e l’impegno dei privati».
Cosa occorre fare perché i settori della cultura e del sociale e quello filantropico lavorino bene insieme?
«Sono fermamente convinta che alla base di una buona relazione reciproca – vale anche per la partnership con le aziende e le istituzioni non profit – ci sia una chiara strategia, oltre che passione per il proprio lavoro e grande rispetto reciproco. Inoltre va valutata la compatibilità di storie, valori ed esperienze non solo reciprocamente, ma anche in relazione agli effetti sulla società civile.
Questo assessment deve essere bilaterale, perché l’esperienza insegna che anche un soggetto richiedente può avere un passato difficile e non solo il contrario. Se le situazioni presentano un elevato grado di complessità, occorre scegliere specialisti esterni con una consolidata esperienza, che accompagnino i processi con intelligenza, capacità, attenzione al dettaglio ed empatia. Fatte le debite valutazioni, se si decide di procedere con un accordo filantropico, è indispensabile avviare una comunicazione adeguata con gli stakeholder rilevanti, prima di prendere decisioni definitive, una comunicazione che sia tempestiva e veritiera, a maggior ragione se insorgono problemi.
Nel passato recente, i nostri predecessori sono stati capaci di governare questi processi senza problemi e con pieno successo: ricordo l’opera preziosa delle sorelle Vischer, che a Basilea idearono e finanziarono la prima clinica pediatrica svizzera, rimasta per molti anni anche un riferimento architettonico. E Ottavia Hill, inventrice dell’edilizia sociale, Abby Aldrich Rockefeller, Lillie Plummer Bliss e Mary Quinn Sullivan, tre donne mecenati e collezioniste che diedero vita a uno dei musei più importanti del mondo, il MoMa di New York. E Phyllis Lambert, per gli amici Joan of Architecture, figura centrale per la promozione dell’architettura contemporanea e potrei proseguire.
Allora cominciamo da qui: far tesoro delle esperienze del passato e guardare al futuro, chiarendo le condizioni-quadro del fenomeno. È davvero ora che ci sia una riflessione da parte degli Stati sulle condizioni quadro legali e fiscali della filantropia, che non faccia esplodere la burocrazia, ma risponda alle sfide sociali contemporanee e una maggior collaborazione tra filantropi, e tra filantropi e stakeholder della società civile, per ottimizzare gli investimenti ed evitare lo spreco di denaro filantropico.
In un mondo sempre più parcellizzato, dove accanto a enormi ricchezze esistono enormi povertà, questo deve essere l’obiettivo di chi oggi si occupa professionalmente di filantropia. Un obbiettivo da perseguire con passione, con coraggio e con infinita fiducia nella nostra capacità di crescere insieme».
La Dottoressa Elisa Bortoluzzi Dubach è consulente di Relazioni Pubbliche, Sponsorizzazioni e Fondazioni, autrice e docente presso varie università e istituti superiori in Svizzera e Italia.