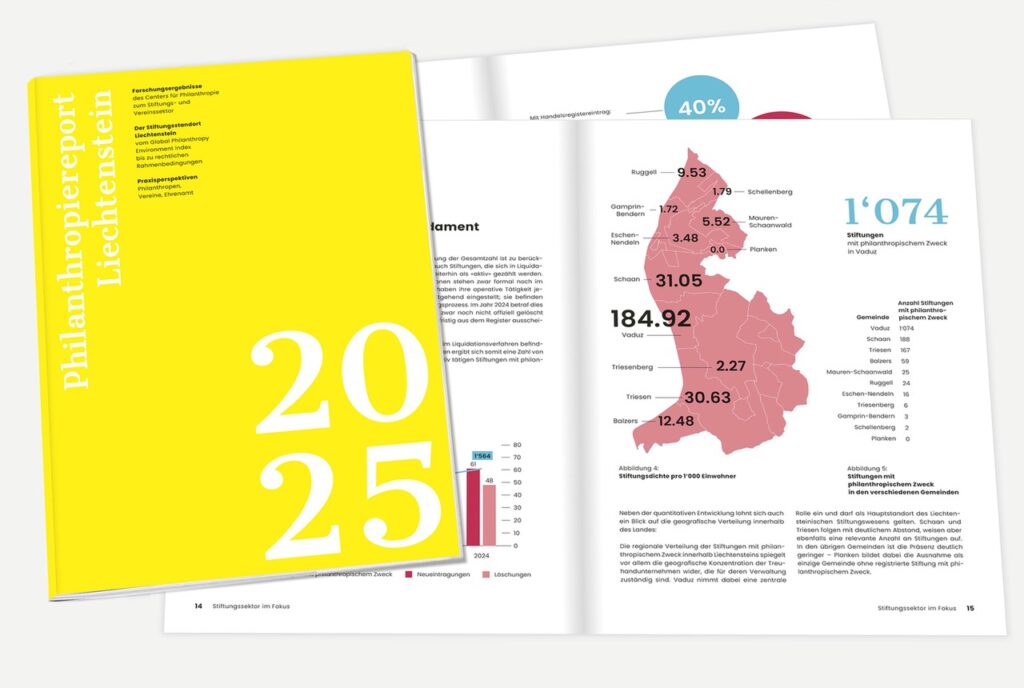Il nuovo libro di Elisa Bortoluzzi Dubach e Chiara Tinonin La relazione generosa. Guida alla collaborazione con filantropi e mecenati (FrancoAngeli, 2020) mette a sistema le traiettorie evolutive del settore del mecenatismo e, più in generale, della filantropia con i nuovi approcci di studio alla generosità e con le più avanzate tecniche di fundraising. Il risultato è un manuale agile per chi cerca una donazione filantropica, ma anche un saggio ricco di spunti utili per i mecenati e per chi desidera impegnarsi di più nel sostenere la crescita della propria comunità. Abbiamo incontrato le autrici per esplorare più da vicino un ambito – il donare agli altri e impegnarsi per uno sviluppo sostenibile – che è sempre più centrale nelle agende dei paesi avanzati.
In che modo il mecenatismo è cambiato negli ultimi anni?
EBD: «A partire dagli anni ’90 del secolo scorso il mecenatismo e la filantropia hanno avviato un percorso di grande espansione, sia in termini dimensionali (attori e investimenti) sia processuali (strategie e modelli di intervento). Questo è stato reso possibile da alcuni fattori chiave come la rivoluzione di internet, il cui flusso continuo di informazioni ha reso possibile una sensibilizzazione in tempo reale sui problemi e i progetti di utilità sociale, la globalizzazione con le sue grandi sfide e la creazione di reti internazionali, la digitalizzazione e le migliori e più veloci modalità di connessione di mecenati e filantropi con i progetti e le organizzazioni che decidono di sostenere. Oggi si aggiungono altri due elementi significativi: il massiccio trasferimento di ricchezza alle giovani generazioni che apre a nuove mentalità e quindi al cambiamento, e la straordinaria competenza strategica con cui vengono gestiti gli investimenti filantropici che si muovono verso l’applicazione di modelli sistemici, basati cioè sulla concertazione di tutti gli attori sociali per lavorare direttamente alle radici dei problemi».
In questo contesto, perché scrivere un libro come La relazione generosa?
CT: «All’interno del grande universo della filantropia, in questo libro ci siamo interessate alla dimensione del mecenatismo, a quella particolare condizione di generosità in cui un individuo sceglie di investire denaro, tempo o reti, a favore di un artista o di un’organizzazione non profit per favorirne l’andamento o per portare a termine progetti specifici. Oggi si avverte ancora troppa separazione tra chi cerca una donazione filantropica e chi dona, e questo è dovuto soprattutto a una serie di falsi miti, o modi rigidi di guardare al mecenatismo, che il libro scardina uno a uno. Secondo il nostro punto di vista, per esempio, l’artista che necessita di sostegno per realizzare la sua opera non sta chiedendo, ma sta soprattutto offrendo qualcosa al mecenate che, a sua volta, partecipa alla realizzazione del progetto non solo elargendo denaro, ma vivendo un’esperienza che potrà addirittura cambiarlo per sempre. L’atto generoso è estremamente generativo e gli studi sul cervello ci dicono che innalza i livelli di benessere fisiologico di chi lo esercita».
Nel libro citate neuroscienze, psicologia, economia comportamentale: sguardi diversi sullo stesso tema, quello della generosità. Perché secondo lei è necessario aprirsi a una visione pluridisciplinare della filantropia?
CT: «ll mecenatismo abbraccia contemporaneamente più dimensioni: è un fatto individuale, legato a valori e desideri personali, ed è anche un’attività con importanti risvolti sociali ed economici. Poter studiare il mecenatismo intersecando scienze diverse è una grande conquista e per noi è stato straordinario osservare quanto il tema della generosità sia oggi centrale in moltissime discipline, che spesso lavorano congiuntamente per esplorare scenari ancora ignoti. Ne è esempio lo studio dell’economista Ernst Fehr, dell’Università di Zurigo, che nella postfazione del libro spiega come ha condotto la sua importante ricerca sulla correlazione tra mecenatismo e felicità insieme a un team internazionale di neuroscienziati».
In quali aree mecenati e filantropi sono particolarmente attivi a livello nazionale e internazionale?
EBD: «Secondo l’ultimo rapporto ‘Spotlight on Major Giving’ di Wealth-X, a livello globale l’istruzione è il settore più importante, con circa un terzo dei filantropi che investono almeno una parte dei loro impegni filantropici in programmi come borse di studio, corsi di sensibilizzazione e formazione degli insegnanti. Altre aree privilegiate sono la salute e i servizi sociali, come la lotta alla povertà e alle disuguaglianze, l’arte e la cultura».
Come si individua un mecenate?
EBD: «Muovendosi in due direzioni: una esterna, analizzando e valutando gli studi di settore, le riviste specializzate, le banche dati per individuare chi esattamente può sviluppare un interesse reale per la tematica; e una interna, cioè conoscendo perfettamente gli aspetti distintivi della propria organizzazione o progetto. Troppo spesso si dà per scontata quest’ultima dimensione e ci si trova impreparati nel comunicare efficacemente visione e obiettivi di cosa si intende realizzare. Solo maturando la consapevolezza di ciò che si può offrire in una ‘relazione generosa’, si riuscirà a incontrare il mecenate giusto con cui collaborare. Questo è un ulteriore passo fondamentale e, in un certo senso, rivoluzionario del libro: trasformare un mecenate non solo in un ‘donatore’, ma soprattutto un ‘ricevente’».
Quando la relazione con un mecenate si trasforma in una ‘relazione generosa’?
CT: «Quando oltre alla bidirezionalità del legame tra beneficiario e mecenate si inserisce anche un terzo soggetto, cioè la comunità o porzioni di comunità che beneficiano della realizzazione del progetto. Le organizzazioni non profit, così come gli artisti e gli stessi mecenati, sono sempre più attente all’utilità sociale del loro agire e all’impatto positivo che possono esercitare sui loro territori. Lo sviluppo e la condivisione di obiettivi chiari e di una visione comune tra beneficiario e mecenate può favorire il cambiamento sostenibile e per questo realizzarsi, appunto, come una relazione generosa».
La pandemia di Covid-19 è in questo senso una grande sfida che ci riguarda tutti. Come hanno reagito i mecenati all’emergenza sanitaria?
EBD: «Filantropi e mecenati si sono fortemente impegnati fin dall’inizio della diffusione del virus e in diversi modi. Nell’estate 2020 si registrava già un significativo aumento delle donazioni filantropiche. Lo studio Billionaires Insights “Riding the Storm” condotto da PwC e UBS ha rilevato che un buon quinto dei miliardari del mondo si stava impegnando di più nel settore della salute. Le cifre complessive vedevano a luglio 2020 circa 209 miliardari donare un totale di 7,2 miliardi di dollari. Secondo lo stesso studio 5,5 miliardi di dollari sono stati donati a fondazioni, ospedali o altre organizzazioni in ambito sanitario. Ventiquattro filantropi hanno concentrato le loro attività sulla produzione di dispositivi di protezione individuale o ventilatori polmonari, investendo un totale di 1,4 miliardi di dollari. Altri 10 mecenati hanno sostenuto principalmente iniziative specifiche, come la costruzione di impianti per la produzione di vaccini. Altre donazioni hanno assunto la forma di contributi non monetari, come la fornitura di dispositivi di protezione individuale».
Qual è la vostra visione per il futuro, come si svilupperà la scena filantropica nei prossimi mesi?
EBD-CT: «La crisi che seguirà l’emergenza sanitaria ci imporrà un cambiamento che si manifesti non solo in nuovi comportamenti, pratiche e procedure, ma anche in un radicale rinnovamento di mentalità. In questo senso, ci chiediamo se non sia arrivato il momento di mettere in discussione le cause dei problemi in modo più radicale. Perché, ad esempio, il sistema del settore culturale e delle industrie creative e culturali si è rivelato così fragile durante la pandemia? Sarebbe sensato, ad esempio, mettersi al lavoro concertando operatori e professionisti del settore, con attori pubblici e mecenati per studiare interventi mirati per risolvere i problemi invece di finanziare solo singoli progetti e misure per contrastare l’emergenza? La crisi ci darà l’opportunità di costruire una nuova visione per la cultura e per la sua sostenibilità finanziaria, proprio grazie alla filantropia e al nuovo modo di guardare alla generosità come potente alleato per la nostra salute».
Le autrici
Elisa Bortoluzzi Dubach è docente universitario e consulente di relazioni pubbliche, sponsorizzazioni e fondazioni. È autrice di articoli e libri sullo sponsoring, le fondazioni erogative, il mecenatismo (www.elisabortoluzzi.com).
Chiara Tinonin è consulente di fondazioni e organizzazioni non profit in ambito artistico e culturale. Scrive di mecenatismo, filantropia e politiche culturali.
La relazione generosa. Guida alla collaborazione con filantropi e mecenati
FrancoAngeli Editore, 2020.
pp. 185, 23 euro.