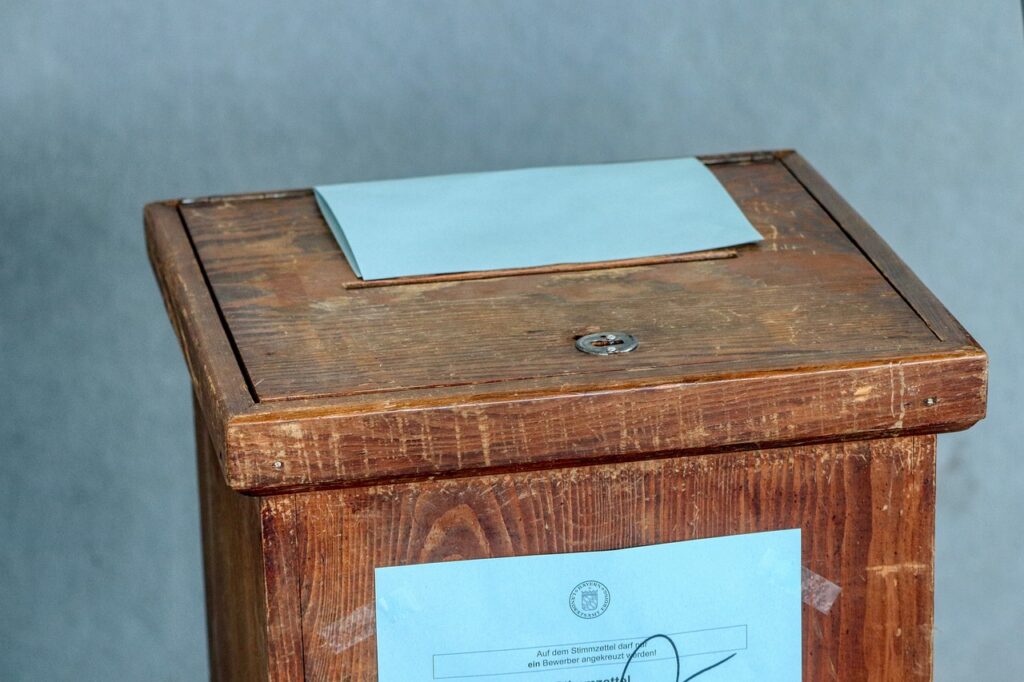Il blocco senza precedenti e su scala mondiale di buona parte delle attività collettive è una reazione di panico che tradisce la totale impreparazione dei politici del ventunesimo secolo di fronte agli effetti perversi della “irresponsabilità organizzata” che regge – come denuncia Ulrich Beck – le nostre società tanto tecnologicamente evolute quanto incapaci di prevenire e gestire i rischi.
Com’è possibile che l’Organizzazione mondiale della sanità non abbia visto venire il pericolo di una grave pandemia di dimensioni planetarie e/o non sia riuscita a prevenirlo o a contenerlo, vista la cascata di epidemie e pandemie degli ultimi vent’anni, alcune delle quali di un tipo simile a COVID-19? Il Coronavirus della sindrome respiratoria acuta severa SARS-COV 1 si era infatti manifestato già 2002 a Guandong, in Cina, e si suppone che sia stato trasmesso all’uomo nell’ambito del commercio di animali selvatici, segnatamente pipistrelli. Un’epidemia che ha toccato molti Paesi del mondo e, rispetto al numero di contagi, ha avuto una letalità molto elevata. Le istanze sanitarie mondiali non hanno ritenuto di dover investire le energie e i fondi necessari per giungere ad un vaccino che a tutt’oggi non esiste e neppure di dover proibire i cosiddetti “wet market”. Se è vero, come si suppone, che il virus SARS-COV 2 si è manifestato anch’esso in un mercato di animali selvatici cinese, a Wuhan, prima di diffondersi tragicamente in tutto il mondo, è legittimo chiedersi come l’OMS abbia potuto rimanere praticamente con le mani in mano per 17 anni (d’altronde la vendita di pipistrelli e animali selvatici in Cina ha potuto clamorosamente essere riaperta a Wuhan poche settimane dopo che il coronavirus SARS-COV 2 vi si era manifestato). A fortiori non si capisce l’inconcludenza dell’OMS, visto che nel 2012 era scoppiata una grave epidemia simile: la Sindrome respiratoria del Medio Oriente MERS-COV, una mutazione del coronavirus con una letalità elevatissima. Ma le zone d’ombra riguardano anche il comportamento dell’OMS nel lungo periodo che va dallo scoppio dell’epidemia COVID-19 a Wuhan – nel mese di dicembre 2019 – fino alla tardiva decisione di dichiararlo una pandemia l’11 marzo scorso. Che l’OMS abbia adottato una politica colpevolmente temporizzatrice (che faceva il gioco della disinformazione e del tentativo di insabbiamento di Pechino) appare ormai acquisito. Dichiarando troppo tardi che COVID-19 era una pandemia, l’OMS anziché contenere e bloccare sul nascere il contagio a livello mondiale, l’ha indirettamente favorito.
Anche se risultasse falsa l’accusa del Segretario di Stato americano Mike Pompeo che il virus è sfuggito ad un laboratorio di Wuhan – la cui sicurezza (visto che era “sub judice” da anni) avrebbe dovuto essere sottoposta a rigoroso controllo – le inadempienze dell’Organizzazione mondiale della sanità risultano essere gravi e tali da comprometterne l’affidabilità e da gettare discredito sull’ONU. Come se non bastasse, mentre il numero dei contagi e dei morti della pandemia dilagava, lo stesso Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non riusciva ad intendersi su una risoluzione e proporre soluzioni condivise per far fronte alla crisi mondiale che la pandemia ha innescato. Anche se la paralisi del Consiglio di Sicurezza va ricondotta alla guerra per l’egemonia fra Pechino e Washington, il triste spettacolo che è andato in scena al Palazzo di vetro è emblematico della disfatta delle organizzazioni internazionali di fronte a questa crisi senza precedenti che avrà pesanti conseguenze per l’umanità per parecchio tempo.
C’è un altro organismo sovranazionale che esce a pezzi da questa crisi: l’Unione europea. Alla prova dei fatti, la crisi ha purtroppo mostrato impietosamente quanto sia velleitaria la costruzione unitaria e incapace di una vera solidarietà fra gli Stati membri, segnatamente di un aiuto immediato e concreto ai Paesi più colpiti dal contagio. Credo che l’UE abbia perso un’occasione storica per mostrare e rinsaldare i propri vincoli di solidarietà. Ma c’è di più. La crisi della pandemia ha fatto venire al pettine un nodo fondamentale che rivela i limiti strutturali e costituzionali di un’Unione europea che resta una costruzione incompiuta. La bocciatura da parte della Corte costituzionale tedesca del PSPP (il programma di acquisto dei titoli si Stato) in concomitanza con il varo del programma miliardario di emergenza contro la pandemia PEPP, poggia su una connessione vincolante fra democrazia e Stato nazionale che fa a pugni con l’Unione come è concepita oggi. La Corte di Karlsruhe mette de facto in discussione il diritto dell’UE – in forza di legislazioni sovranazionali (o convenzioni di tipo economico) concluse fra Stati – di varare programmi finanziari considerati troppo penalizzanti per le imprese e i risparmiatori tedeschi e invece vantaggiosi per i partner europei meno virtuosi dal punto di vista della gestione della finanza pubblica e dell’economia. Uno strappo clamoroso che rischia di innescare una procedura di infrazione dei trattati europei rivolta contro la Germania (che però è la principale finanziatrice di un’UE ormai priva dei fondi fin qui versati dal Regno Unito e quindi in gravissima situazione finanziaria). Da slogan populistico scandito dai partiti nazionalisti, “Prima i nostri” rischia di diventare un nodo gordiano per la stessa impalcatura giuridica dell’Unione europea. Una questione estremamente seria che va ad aggiungersi al rischio reale che questa crisi faccia saltare in aria l’Euro o propizi l’uscita dall’Eurozona dei Paesi più in difficoltà. Agli occhi degli italiani, francesi, spagnoli, greci … qual è oggi l’immagine dell’Unione europea? Le frontiere fra gli Stati membri sono chiuse. Quando mancavano mascherine e apparecchiature sanitarie, sono arrivate dalla Cina e non dagli altri paesi europei… Al fronte, nella lotta al contagio, ci sono i Governi nazionali, legittimati a varare misure d’eccezione giustificate dalla protezione dei cittadini. E dotati di poteri come mai dai tempi della seconda guerra mondiale. Questa crisi segna il ritorno degli Stati nazionali. In una situazione di totale incertezza dal punto di vista epidemiologico e in una fase solo iniziale della profonda crisi economica che la pandemia ha innescato, non ci sono inoltre criteri di giudizio articolati per stabilire se questi Governi stiano facendo bene o male. Quando la curva dei contagi e dei morti ha cominciato a scendere, nei cittadini è prevalsa l’impressione che le misure di confinamento e la politica sanitaria attuata dai Governi (secondo modalità più o meno diverse a dipendenza delle situazioni) siano state positive. In un mare globale in tempesta, gli Stati nazionali appaiono come un salvagente, se non un porto sicuro. La solidarietà si riscopre vicina: nel quartiere, nella città, nel proprio Paese. Una diga locale eretta contro lo tsunami di una pandemia che viene vista come il frutto avvelenato della globalizzazione.