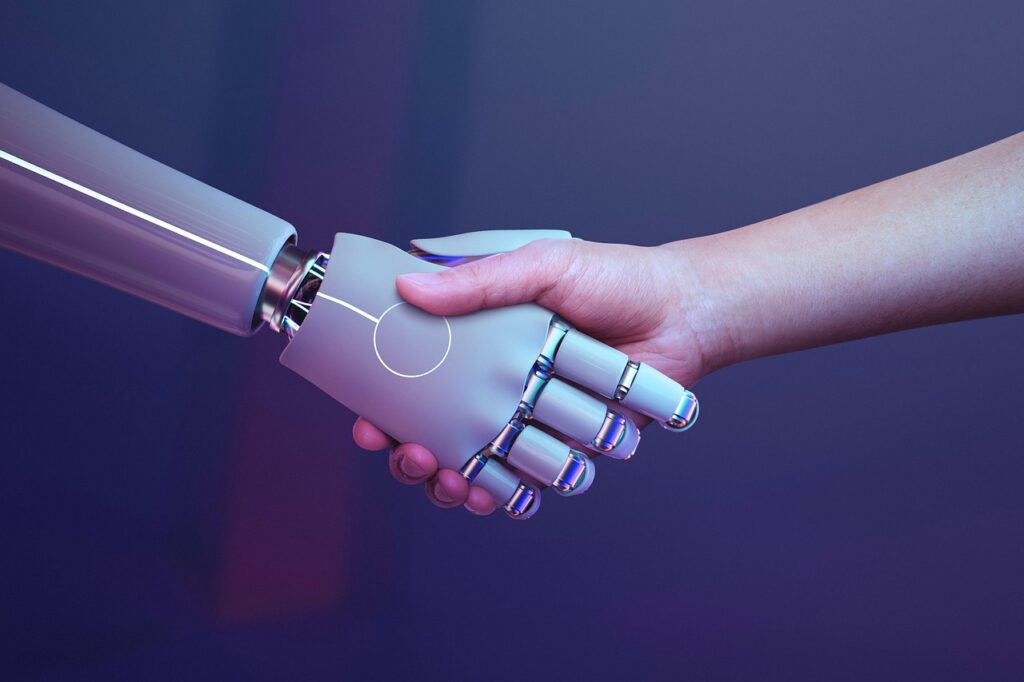Premessa: ieri – lunedì 4 luglio 2022 – si è aperta proprio a Lugano la Conferenza internazionale per la ricostruzione dell’Ucraina.
Gli attori, arrivati da tutto il mondo, si siedono allo stesso tavolo per elaborare “il Piano Marshall dell’est Europa”, in cui la ricostruzione passi attraverso un processo politico e diplomatico di ampio respiro.
Con il professor Jean-Patrick Villeneuve, di USI, cerchiamo di approfondire diversi aspetti della questione, tra i quali il ruolo che assume il mondo accademico in questo frangente.
Esperto sui temi della trasparenza, dell’anticorruzione e dell’accountability, Villeneuve ha approfondito in particolare proprio la questione delle sfide, delle limitazioni e dell’impatto di queste iniziative di governance.
Professor Jean-Patrick Villeneuve, qual è il ruolo del mondo accademico di fronte a una situazione come quella dell’Ucraina?
I ruoli sono molteplici. Innanzitutto, ogni disciplina accademica deve applicare le proprie griglie analitiche, teorie e metodologie per cercare di dare un senso alla situazione. Nel caso dell’Istituto di comunicazione e politiche pubbliche (ICPP), ciò significa utilizzare la pubblica amministrazione, le scienze politiche, le relazioni internazionali e la comunicazione interculturale per analizzare e comprendere il presente da diverse angolature, ma anche per cercare di dare forma e prepararsi al futuro.
Un secondo elemento, oggi altrettanto importante, è il sostegno ai ricercatori ucraini. Attraverso il programma Scholar at Risk e il Servizio relazioni internazionali e mobilità dell’USI, l’Istituto ha accolto due studiosi ucraini. In questo modo, potranno continuare il loro lavoro di ricerca, temporaneamente, dall’USI.
Grazie a questa iniziativa, siamo in grado di portare avanti progetti di ricerca e attività che affrontano la situazione ucraina, esplorando e preparando un percorso per il futuro, proprio nello stesso spirito della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell’Ucraina.
Come può aiutare la pubblica amministrazione nella situazione attuale?
La pubblica amministrazione è una disciplina relativamente “pratica”, con un forte legame con le istituzioni. Analizza lo sviluppo, la diffusione e l’impatto delle politiche pubbliche e la gestione delle istituzioni pubbliche. Di conseguenza, non analizziamo tanto i “perché” della situazione attuale, né le strategie per raggiungere una pace duratura, quanto piuttosto le condizioni in cui l’Ucraina può “rimettersi in piedi” e ad andare avanti.
Quello su cui ci stiamo focalizzando, in linea con i progetti di ricerca in corso, ha due dinamiche distinte:
Con l’aiuto di un nuovo studioso, il dottor Demyan Belyaev, estenderemo le nostre ricerche sulle dinamiche della corruzione al contesto ucraino. Riteniamo che questo sia un aspetto essenziale da considerare per arrivare ad un processo di ricostruzione che sia efficace, impattante e supportato a livello politico. Questo è fondamentale per l’Ucraina. Una migliore struttura governativa sarà, infatti, una condizione imprescindibile posta dai finanziatori di tutto il mondo. Questo tipo di ricerca costituirà un’estensione dei progetti in corso all’interno dell’ICPP finanziati dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS), dal Social Science and Humanities Research Council of Canada (SSHRC) e da altri enti come Transparency International (TI).
In linea con un altro progetto finanziato dalla Swiss Network for International Studies (SNIS), affronteremo anche la questione della partecipazione degli stakeholder nei vari processi di good governance, in particolare quelli legati alla ricostruzione post-conflitto. Chi deve avere voce in capitolo e come queste voci debbano essere ascoltate.
Prima della guerra, l’Ucraina stava affrontando realtà difficili in termini di governance, ma dal 2011 è diventata paese membro dell’Open Government Partnership. Quindi, indubbiamente, c’è il desiderio e la volontà di progredire in questo ambito. Dobbiamo assicurarci che questo processo non si blocchi di fronte alle sfide attuali e contribuire, come accademici, a fornire soluzioni e a individuare potenziali insidie.
Cosa è successo finora?
Nei mesi scorsi abbiamo organizzato una conferenza, con la partecipazione di ASIS Svizzera Italiana e START InSight. “Da Washington alla guerra in Ucraina, la dimensione della disinformazione”. È stata l’occasione per discutere di disinformazione, cybersecurity, e i nuovi orizzonti della radicalizzazione e dell’estremismo. Tutti temi che riguardano direttamente l’attuale situazione in Ucraina, e che si ricollegano anche ad altre iniziative dell’USI come il MEM o i cicli di conferenze del PEN.
Durante l’ultimo anno, anche l’Afghanistan, un altro paese che sta affrontando una situazione problematica, è stato al centro delle attività dell’Istituto, in particolare con l’arrivo di un altro studioso a rischio, Parwiz Mosamim, che sta analizzando la condizione delle donne nelle amministrazioni pubbliche afghane.
Cosa chiedereste?
Che si cominci adesso a pianificare il “dopo”. La conferenza di Lugano è un passo significativo in questa direzione. Che nella ricostruzione si ascolti una diversità di voci. Che vengano mobilitate tutte le potenzialità degli ucraini, dentro e fuori il Paese. Che la scienza, la ricerca, il know-how, e non solo la politica e le relazioni di potere, entrino a far parte parte dell’equazione. Per il momento? Per il momento, questo significa migliorare meccanismi di finanziamenti come Scholars at Risk. Significa definire e lanciare nuovi meccanismi di finanziamento per la ricerca in modo da avere le risorse necessarie ad affrontare la miriade di sfide che ci attendono. Se vogliamo essere pronti, il lavoro deve iniziare adesso!