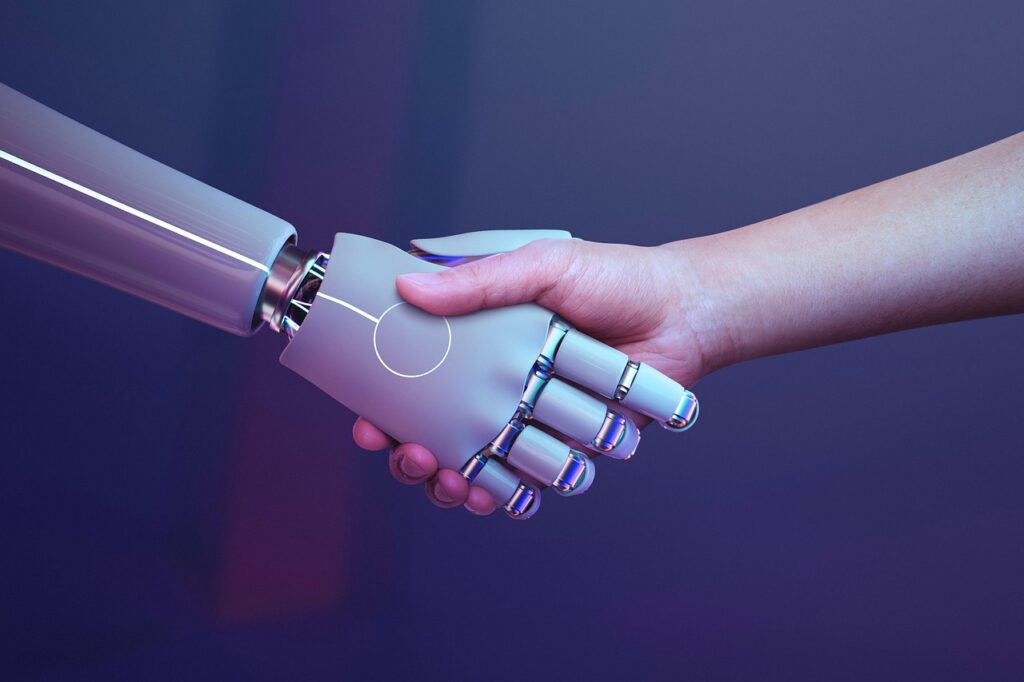In un momento come quello attuale, il mondo intero ripone grandi speranze nella comunità scientifica, al lavoro per cercare soluzioni alle numerose problematiche, sanitarie e derivanti, legate alla pandemia di coronavirus. Anche la ricerca svolta a livello di scuole universitarie professionali – orientata, per vocazione, ai reali bisogni del territorio e alle esigenze di una società in continua evoluzione – si sta attivando per fornire il proprio contributo.
Di fronte all’epidemia di COVID-19, quali sono i compiti della ricerca?
«La ricerca scientifica fondamentale ha come obiettivo quello di scoprire perché e come avvengono i fenomeni naturali, mentre il ruolo di quella applicata è invece quello di proporre soluzioni innovative volte a favorire lo sviluppo e il benessere – sociale, culturale, economico o tecnico – dell’essere umano. Una definizione molto stringata che, se applicata alla situazione che stiamo vivendo, affida alla ricerca applicata il compito di cercare di risolvere i molteplici problemi generati dall’epidemia. Perlomeno a livello europeo, oltre all’attivazione immediata di sforzi nella direzione di assicurare rimedi sanitari e medici, le sfide si concentrano attorno alle svariate emergenze derivate quali, ad esempio, quelle economiche e sociali».
Quali sono i principali bisogni emergenti?
«Al di là dei bisogni sanitari e medici – che, seppur complessi e confrontati a enormi sfide, sono facilmente riconducibili alla ricerca di un vaccino, al controllo dell’epidemia e alla cura dei malati – vi sono molte altre sfide dal non immediato discernimento. Sul fronte dell’economia, interi settori e servizi si troveranno in condizione di dover cambiare modalità di produzione e di distribuzione, ciò che comporta una rivoluzione della catena logistica e un adattamento del modello di business. Il modo di lavorare sarà, inoltre, confrontato a ulteriori cambiamenti: se le modifiche indotte dalla frammentazione dei servizi e dai modelli differenziati della “new economy” avevano già reso diverso il panorama della figura professionale del dipendente e quella dell’imprenditore, con l’emergenza questa tendenza sarà ulteriormente accelerata e porterà a riconsiderare la definizione stessa di lavoro, tempo di lavoro, impegno e remunerazione. Tutto il settore che si occupa di protezione dell’ambiente dovrà assumere diverse nuove responsabilità: dal consumo energetico alla gestione delle abitazioni, dagli spostamenti all’uso e consumo di beni.
Un altro tema molto impellente riguarda la valutazione e le misure relative allo stato di salute psichico, nonché la riorganizzazione sociale indotta da questa e dalle possibili future pandemie. L’elenco degli ambiti che necessitano di soluzioni è davvero molto lungo: dalla risposta dei governi all’epidemia agli impatti sulla forza lavoro; dall’evitare l’infezione e lo sviluppo di una pandemia, agli impatti sui viaggi, i mercati finanziari, i commerci, la formazione, ecc. Elementi che, a loro volta, si suddividono in una miriade di sotto capitoli ancor più dettagliati, ciò che rende difficile, se non impossibile, riprodurre una lista di bisogni esaustiva. Bisogni per i quali si attendono nuove idee e stimoli da parte della ricerca, e per i quali le scuole universitarie professionali (SUP) potranno contribuire ad attivare le innovazioni necessarie».
In questo contesto, qual è il ruolo delle SUP?
«Le SUP associano la loro esistenza al mandato applicativo della loro ricerca; il loro ruolo è quindi quello di trovare soluzioni in grado di dar sollievo e accrescere lo stato di benessere dell’essere umano. La chiave della loro attività è da ricercare nello stretto rapporto esistente con gli attori della società, beneficiari dei risultati: partner economici e sociali, aziende, case per anziani, strutture ospedaliere, scuole, piccole e medie imprese».
Il coronavirus ha cambiato e condizionato lo stile di vita e le abitudini delle persone, il nostro modo di lavorare e ha conseguenze tangibili anche sui settori della formazione, della ricerca e dell’innovazione in Svizzera. In questa situazione particolare, com’è organizzato il lavoro di ricerca delle SUP?
«In gran parte esso può avvenire sfruttando i mezzi di collaborazione virtuali ma, laddove necessita di laboratori fisici, il lavoro ha subito importanti modifiche. Lo sforzo messo in atto per utilizzare modalità di contatto virtuale ha accelerato la capacità di relazionarsi con persone distanti: un aspetto positivo che, nonostante le negatività del periodo, ha facilitato alcune interazioni e, di conseguenza, alcuni progetti».
Esistono progetti condivisi tra università e istituti a livello svizzero ed internazionale?
«Le comunità svizzere, europee e mondiali si sono mosse immediatamente per aprire cantieri di ricerca negli ambiti della medicina e della sanità, come pure su temi correlati (crisi economica, riorganizzazione, formazione ecc.). Dare una panoramica completa non è semplice, ma ritengo utile citare l’azione dell’Unione Europea e del Fondo nazionale svizzero per la ricerca (FNS)».
Il lavoro del ricercatore è diverso rispetto a prima?
«La distanza ha sicuramente penalizzato la relazione personale con i colleghi della stessa istituzione e gli incontri necessari a coltivare le relazioni e le conoscenze, penso ad esempio alle riunioni di progetto e alle conferenze. Come tutti, quindi, anche i ricercatori soffrono moltissimo della mancanza di contatti personali, modalità privilegiata in questo tipo di attività. Come accennato in precedenza però, c’è stato uno stimolo alle comunicazioni a distanza che, di per sé, potrebbe avere accelerato scambi positivi per la conoscenza dei temi e lo stato dei progetti».
Per far fronte all’emergenza, sono stati stanziati fondi speciali di ricerca?
«Titoli di ricerca che trattano il virus e le sue conseguenze possono beneficiare di fondi appositamente reindirizzati da parte, ad esempio, del FNS e dell’Unione europea citati in precedenza. Sono inoltre convinto che un adattamento dei programmi di ricerca avverrà in tempi brevi».
Per quanto riguarda la SUPSI, sono attivi progetti di ricerca legati al coronavirus?
«La SUPSI dedica ogni anno una parte del suo bilancio alla ricerca strategica che, quest’anno, sarà orientata anche a risolvere problemi nati dalla pandemia e affronterà programmi di ricerca per i prossimi quattro anni. Per questo periodo, abbiamo già alcune iniziative in atto, frutto di richieste specifiche, che trattano i cambiamenti indotti dall’epidemia. Diversi gruppi di ricerca hanno inoltre partecipato e ottenuto fondi nell’ambito di iniziative federali, essenzialmente su temi sanitari. Entro poche settimane potremo, a mio parere, delineare linee di ricerca coerenti su un periodo di medio termine».
Si sente spesso dire, per voce di svariati esperti, che la vita dopo il coronavirus non sarà più la stessa e che questa esperienza condizionerà il nostro quotidiano da più punti di vista. Secondo lei, cambierà il modo di fare ricerca applicata? Cambierà l’approccio alle sfide future?
«Il modo di fare ricerca cambierà, proprio come cambieranno le abitudini generali delle persone. Sarà modificata la sensibilità sui temi relativi alla sostenibilità sociale, economica ed ecologica. Le sfide avranno obiettivi meglio definiti, così come la ricerca che le vuole affrontare. Le ricercatrici e i ricercatori orienteranno maggiormente la propria attività verso risultati capaci di mettere in risalto, come valore primario, il benessere degli individui.
L’impatto economico di questo periodo di crisi avrà risvolti anche sulla ricerca che sarà confrontata ad un restringimento dei finanziamenti. A compensare minori risorse finanziarie, vi saranno però maggiori risorse mentali e una spinta più intensa nella ricerca di soluzioni. Alcune attività diminuiranno forse di quantità ma, in contropartita, assisteremo probabilmente ad un’accelerazione delle idee e alla loro trasformazione. La storia è testimone di come molte scoperte e cambiamenti siano nati da momenti di crisi e sono convinto che questa lezione della storia troverà la sua conferma anche in questo caso».