Lei ha attraversato da protagonista oltre settant’anni di storia Ticino. Ma quali opportunità il Cantone poteva offrire alla metà del secolo scorso ad un giovane che, come nel caso suo o di Geo Mantegazza, si affacciava al mondo del lavoro?

«Siamo stati per lungo tempo un territorio povero che storicamente ha sofferto di una mancanza d’iniziativa da parte delle sue classi dirigenti. Bisogna considerare che per tre secoli il Ticino e la sua gente furono soggetti al volere di balivi e giudici confederati, godendo di una relativa sicurezza ma al tempo stesso subendo la stagnazione della propria economia. Solo nel 1803 divenne un Cantone politicamente indipendente. L’economia restò tuttavia a lungo arretrata, quasi esclusivamente agricola e con una produttività abbastanza ridotta. Ogni anno migliaia di persone erano costrette a emigrare. La borghesia ticinese è sempre stata debole e le poche città relativamente piccole. Un processo d’industrializzazione prese avvio solo alla fine del XIX secolo e dipese da un lato dalla costruzione della ferrovia del Gottardo e dal turismo che ne derivò, dall’altro lato in forte misura dal capitale straniero, proveniente dalla Svizzera tedesca e dall’Italia o alimentato dalle rimesse degli emigrati arricchitisi in tutti gli angoli del mondo. In ogni caso, i ceti più abbienti rivolgevano i propri investimenti soprattutto al settore immobiliare o acquistavano obbligazioni».
Gli anni successivi alla seconda guerra mondiale hanno tuttavia visto anche in Ticino un fiorire di iniziative…
«Devo dire che i primi trent’anni del dopoguerra sono stati da un punto di vista lavorativo un periodo meraviglioso. La necessità di una ricostruzione dell’Europa dopo i disastri della guerra coinvolgeva anche la Svizzera e quindi il Ticino, ma in quel periodo, nonostante tutte le difficoltà, era predominante uno spirito nuovo che risultava essere premiante per chi aveva voglia di fare ed era pronto ad avviare nuove iniziative. Chi aveva talento veniva incoraggiato e favorito e non frenato dalla burocrazia. Da questo punto di vista il caso dei fratelli Mantegazza è emblematico: la loro capacità di intuire per tempo verso quali settori si sarebbe orientato lo sviluppo futuro, cioè il turismo e l’edilizia, è stata una delle ragioni del loro successo imprenditoriale. In sintesi, sono tre le condizioni che hanno reso possibile nell’immediato dopoguerra di ripartire con uno slancio prima sconosciuto: una grande voglia di lavorare, un contesto normativo più agile e non opprimente e, da non trascurare, il peso di una società, per certi aspetti “patriarcale”, ma che consentiva comunque il mantenimento di uno spirito di comunità e la trasmissione di tutta una serie di valori fondanti condivisi».
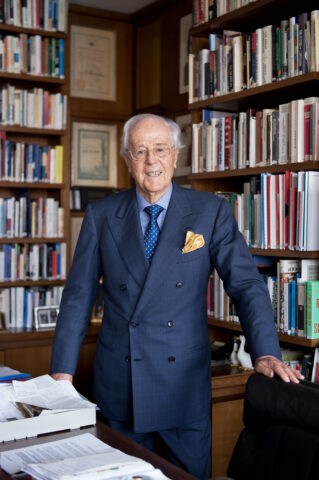 Quando e perché, a suo giudizio, questa spinta propulsiva a cominciato a venire meno?
Quando e perché, a suo giudizio, questa spinta propulsiva a cominciato a venire meno?
«Probabilmente nella prima metà degli anni ’80, quando purtroppo il ruolo della politica è diventato preponderante nel governo dell’economia e della società anche in un territorio di ridotte dimensioni qual è appunto quello ticinese. Un’evoluzione lunga, complessa e contradditoria che ha contraddistinto tutti i raggruppamenti e che ho cercato di riassumere in un mio recente volumetto, Confessioni di un conservatore, da cui mi permetto di trarre una breve citazione: “sono il primo a non idealizzare la politica… Ho l’impressione che molto spesso la politica si riduca sostanzialmente a uno scontro di interessi per ottenere ed esercitare il potere… io penso che lo spartiacque, ciò che fa la differenza vera nella natura della politica, sia proprio la questione volta a sapere se lo scontro sia espressione tattica di una pura lotta di potere, o se per contro le divergenze sono frutto del contrasto tra valori, tra opposte visioni della società, tra concezioni diverse relative al progresso… In altre parole, o la politica ha un fondamento culturale, che purtroppo viene spesso dimenticato per convenienza e interessi, oppure diventa un puro scontro tra bande” (pp. 21-23). Non credo sia necessario aggiungere altro».
Tornando alla mancanza di imprenditorialità dei ticinesi, lei parla spesso di scarsa propensione al rischio…
«È vero, il Ticino ha scontato a lungo la sua condizione di arretratezza, e i suoi abitanti sono sempre stati costretti a emigrare e confrontarsi con contesti economici più avanzati e dinamici. Le loro fortune sono state per lo più realizzate all’estero, dove hanno trovato situazioni più favorevoli e stimolanti. Per contro, è significativo il fatto che in un settore come quello alberghiero, dove il Ticino avrebbe avuto molte possibilità di sviluppo, i primi importanti passi siano stati mossi per iniziativa di imprenditori provenienti quasi tutti dalla Svizzera tedesca. Un discorso a parte dovrebbe poi riguardare la particolare situazione che si è venuta a creare in seguito alla crescita del settore finanziario che ha consentito per lungo tempo di godere di una sorta di “ombrello” che se ci ha garantito un certo benessere e protetto da crisi economiche, dall’altro non ha favorito la nascita e lo sviluppo di nuove attività in altri settori. Le buone idee non nascono confezionate e pronte per l’uso. Sono come un germoglio che va messo nella terra adatta, assistito e alimentato. Vale a dire che per crescere necessitano di rivisitazioni critiche, approfondimenti, analisi empiriche, scontri dialettici. In altre parole, il Ticino deve imparare a fare decantare le idee per giudicare se e come realizzarle. Un processo impegnativo che esige non solo lo studio ma anche il coraggio di giungere anche a conclusioni che sono in contraste con le originarie convinzioni».
Guardando al futuro, quali dovrebbero essere le principali risorse da valorizzare per continuare ad assicurare al Ticino le condizioni di benessere di cui attualmente gode?
«Si fa un gran parlare di globalizzazione e poi si stenta ancora a comprendere un’evidenza che la geografia, la storia e il consolidarsi di una moderna economia ci hanno senza equivoci consegnato. Lugano, e di conseguenza il Ticino, godono di una posizione di equidistanza tra due poli di assoluto rilievo europeo quali sono Zurigo e Milano. Con l’apertura del Gottardo queste due città distano qualche ora di treno, cioè circa quanto separa un quartiere periferico dal centro di una grande metropoli del mondo. Perché allora non si focalizzano tutti gli sforzi affinché questa città diventi, ben più di quanto lo sia già oggi, un centro attrattivo di livello internazionale. Per fare questo occorre però concorrere a determinare, con il contributo di tutte le risorse politiche ed economiche cantonali, quattro condizioni dalle quali non è assolutamente possibile prescindere. Innanzitutto, garantire livelli di sicurezza tali da rendere effettivamente attrattiva l’opportunità di vivere in una città ben governata, pulita e ordinata, senza alcun di rischio per ogni persona e per la sua famiglia. È poi necessario consolidare un sistema formativo, in tutti i gradi di istruzione, che permetta alle nuove generazioni di godere di una qualità di studi competitivi rispetto all’offerta proveniente da altre città estere. Un problema importante da risolvere riguarda poi il sistema della viabilità, oggi altamente insoddisfacente che deve essere senza dubbio migliorato per evitare che qualsivoglia incidente possa interrompere o gravemente rallentare, come oggi non di rado accade, le comunicazioni tra le diverse parti del Cantone. Infine, occorre arrivare a determinare un atteggiamento fiscale “intelligente”, in grado cioè di stabilire un equilibrio tra le necessità pubbliche e il rispetto, e non il soffocamento, delle potenzialità di una platea internazionale di contribuenti qualificati e abbienti».
A proposito di intuizione e capacità di dare corso a idee innovative, come ha deciso di fondare Fidinam?
«Ho cominciato a lavorare nel 1953, a 23 anni, dopo che, per necessità economiche, avevo dovuto conseguire il Dottorato in legge in breve tempo, e poi due anni dopo ho conseguito la patente cantonale di avvocato e notaio. Mi sono dapprima dedicato all’attività politica, con l’elezione al Gran Consiglio nel 1955 e al Consiglio di Stato nel febbraio 1959, per poi essere obbligato a chiudere definitivamente con la politica attiva. Successivamente, ho optato per il mestiere di avvocato d’affari in un periodo in cui questa figura ancora non esisteva. Non era chiaro che ruolo potesse avere e anche per me si trattava di un concetto un po’ nebuloso ma avvertivo che c’era un vuoto relativo all’assistenza legale per gli aspetti affaristici, contabili, amministrativi e fiscali. Non c’erano le fiduciarie, bensì i ragionieri, ma io avevo bisogno di una figura professionale che mi accompagnasse quotidianamente, con tempestività: da questa esigenza nacque l’idea di fondare la Fidinam, assieme ai colleghi Avv. Giangiorgio Spiess e Avv. Orazio Dotta, società fiduciaria operante anche sul mercato immobiliare, che già alla fine degli anni Sessanta diede inizio alla sua espansione all’estero.
Più tardi, avendo fatto mentalmente il giro del mondo ho concluso che i tre Paesi in cui si potevano fare affari immobiliari erano l’Australia, gli Stati Uniti e il Canada: quest’ultimo, in particolare si è dimostrato un mercato molto interessante grazie anche all’intuizione di operare a Toronto, nel momento in cui quella città si andava rapidamente sviluppando. Oggi Fidinam, sotto la direzione dell’avvocato Massimo Pedrazzini, ha uffici e sedi anche in Oriente, a Hong Kong, Shanghai, Singapore, Vietnam e Australia.
Con il 60% dell’azionariato in mano alla Charity Foundation, per attività di filantropia, e il 40% in mano ai dirigenti, la Holding mantiene tuttavia una sua significativa presenza in Ticino perché sono convinto dell’importanza del riconoscimento e della conservazione delle proprie radici. Le mie tre figlie poi tempo fa mi hanno fatto capire che la cosa peggiore che potesse loro capitare era lavorare con me. Ho dunque creato il Charity Fund, che permette di restituire alla società quelle risorse che il sistema di mercato mi ha permesso nel tempo di realizzare. Le mie figlie hanno accettato questa idea di buon grado e con molta intelligenza».
Nel corso della sua lunga attività professionale lei ha ricoperto molti ruoli assai impegnativi, ma ha anche trovato il tempo per dedicarsi alla scrittura e all’analisi critica di vicende che possono avere una dimensione globale così come riguardare la porta accanto. Come nasce questa sua passione per la critica giornalistica e per la riflessione sui grandi temi contemporanei?
«Potrei rispondere che questo mio interesse nasce probabilmente da una forma di vanità. Ho sempre provato un grandissimo gusto nel reinventarmi professionalmente, cosa che fatto, anche se non obbligato, più volte nella vita. Come ho detto, dopo essermi dedicato alla politica, all’avvocatura, aver creato la Fidinam, in veste di imprenditore e operatore immobiliare e nella finanza mi sono dedicato nel 1986 alla scalata della Sulzer di Winterthur e al controllo della Saurer. Mi sono occupato tra l’altro di editoria acquisendo con amici nel 2002 la casa editrice Jean Frey AG, che controllava importanti testate giornalistiche, a cui si è aggiunta nel 2010 l’acquisizione della Basler Zeitung. In tutti questi anni mi sono reso conto che la mia passione, e in fondo il mio maggiore interesse, è stato quello di concludere affari, ma, scherzosamente, ho compreso che per ottenere un reale riconoscimento all’interno della nostra società occorre soprattutto essere intellettuali, ciò che io non sono. Perciò ho accolto con piacere la proposta di collaborare con testate giornalistiche e ho cercato di affidare ad alcuni libri le mie riflessioni sulla politica e l’economia».
Nelle sue analisi non sembra tuttavia prevalere uno spirito polemico, quanto piuttosto un invito alla riflessione e a un pacato dibattito…
«Mi fa piacere questa osservazione perché in effetti non credo che sia più il tempo di estenuanti quanto inutili contrapposizioni verbali quanto piuttosto sia necessario analizzare le questioni nella loro complessità tenendo conto di una pluralità di possibili approcci. Negli anni ho appreso che negli affari, così come nella gestione della res publica è indispensabile valutare con estrema attenzione tutti i pro e i contro di ogni azione e questa esperienza rappresenta il patrimonio che vorrei contribuire a trasmettere anche alle prossime generazioni».
Nel corso di questa nostra conversazione lei ha citato alcuni personaggi della politica e della finanza che in passato hanno operato in Ticino, attribuendo loro, con un certo rimpianto, la definizione di “vero gentiluomo”. Perché non ci sono più queste autorevoli figure?
«Credo di poter rispondere che la ragione sta nel fatto che si è perso il rispetto per la forma. Approfondendo il concetto arrivo a dire che sempre più spesso ci vergogniamo del passato. L’eccessiva influenza del politicamente corretto e del fenomeno del wokismo nella società occidentale contemporanea ha avuto come conseguenza che queste tendenze stanno permeando ogni aspetto della nostra vita, dall’educazione ai media, dalla politica alla cultura, portando quasi ad una nuova forma di barbarie. Mi piace definirmi un uomo del Novecento e un conservatore, nel senso di una persona che, citando ancora me stesso, ha rinunciato “alla pericolosa confusione tra evoluzione e rivoluzione, con la nefasta conseguenza di imporre altrettanto nefaste ideologie per mezzo di rivoluzioni cruente oppure di lenti rivolgimenti destabilizzanti volti a distruggere la società esistente (come purtroppo si sta facendo oggi) per seguire fallaci utopie”. Con una piccola chiosa finale: “chi si sente autenticamente conservatore ha il sacrosanto diritto di valutare lui stesso, in scienza e coscienza, tutta questa complessa e affascinante materia. E di decidere come giudicare, comportarsi e dunque vivere, di conseguenza”».
Il mio ricordo di Geo Mantegazza
Ho conosciuto tardi Geo. Aveva qualche anno più di me, ha fatto il Liceo (premiato, perché miglior allievo) e poi ha conseguito la laurea di ingegnere al Politecnico di Zurigo. Io, per contro, ho fatto la Commercio a Bellinzona e mi sono laureato in diritto a Berna.
Il nostro incontro è dovuto al Rapid, società calcistica nella cui squadra lui era il centravanti ed il capocannoniere. Era un ottimo giocatore ed è stato chiamato a far parte della squadra degli universitari svizzeri e, se ben ricordo, del Chiasso. L’animatore della società Rapid a quei tempi, metà anni ’50, era Renato Fontana che, con entusiasmo, si occupava di tutto e di tutti. Io ero Vicepresidente del Consiglio ed il Presidente era “ul sciur Togn”, il papà di Geo. Indispensabile il suo appoggio, perché la sua firma dava valore alle cambiali che dovevamo emettere per ottenere il sostegno bancario per le nostre magre finanze.
Ho avuto contatti più tardi con il Geo professionista lavorando con lui quale ingegnere e devo dire che quella era la sua vera passione, un professionista competente ma anche un innovatore progettualmente.
È passato facilmente, grazie anche al vantaggio della sua professione, all’immobiliare, dove ha lasciato opere importanti a Lugano, la città alla quale era intimamente e con passione legato. Se avesse voluto, ne avrebbe potuto, data la popolarità, diventare il Sindaco.
La sua passione per lo sport ed il suo attaccamento alla società hanno portato l’Hockey Club Lugano a quei successi che conosciamo.
In quei decenni però ci siamo visti poco, io vivevo spesso all’estero come suo fratello Sergio, con il quale per questa ragione avevo maggiori occasioni di frequentazioni e viaggi comuni.
Più avanti negli anni, con alcuni ticinesi, tra i quali Geo, con i quali ci incontravamo nel Sud della Francia, abbiamo costituito il Club Juventus. Un inno alla gioventù, infatti per potervi aderire bisognava aver superato gli ottanta. Erano incontri un po’ da “Amarcord”, con comuni pranzi e pure per lunghi “scontri” agli Jass. A questo proposito mi è d’obbligo precisare che era molto più bravo quale ingegnere che non al gioco delle carte. Geo, un amico che ricordo e che Lugano non può dimenticare.














