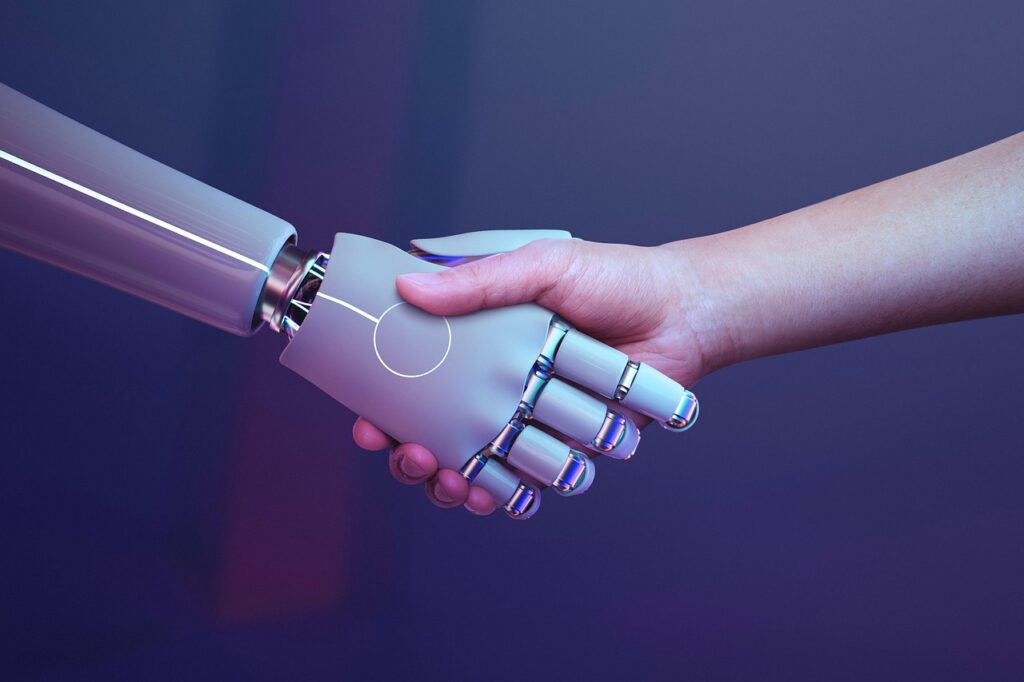Organizzare una discussione nell’ambito di una serata pubblica su un argomento così importante – la scuola ticinese -, in grado di raggiungere e stimolare le persone per la sua trasversalità sensibilità e aspettative molto diverse, significa soprattutto tentare di allestire una formazione di ospiti che rappresentino il più ampio spettro di competenze, ruoli e opinioni all’interno di un universo estremamente variegato come quello scolastico, che di fatto tocca appunto tutte le componenti – e dunque le problematiche – della nostra struttura sociale.
Organizzare una discussione nell’ambito di una serata pubblica su un argomento così importante – la scuola ticinese -, in grado di raggiungere e stimolare le persone per la sua trasversalità sensibilità e aspettative molto diverse, significa soprattutto tentare di allestire una formazione di ospiti che rappresentino il più ampio spettro di competenze, ruoli e opinioni all’interno di un universo estremamente variegato come quello scolastico, che di fatto tocca appunto tutte le componenti – e dunque le problematiche – della nostra struttura sociale.
Chi deve fare la scuola, come e per chi? In questa domanda, che potrebbe sembrare banale, è racchiusa in fondo la traccia imprescindibile di qualsiasi tentativo di analisi: di certo la politica, evidentemente chiamata a regolamentarne il funzionamento, idealmente affiancata e sostenuta dai principi della didattica, che attraverso le modalità di insegnamento ne garantisce la dinamica verso la costante evoluzione, il mondo del lavoro, che ne è il maggior beneficiario, e poi gli allievi e le loro famiglie. Tutti, insomma, senza eccezioni e senza la possibilità per alcuno di chiamarsi fuori da un gioco che gioco non è.
 Per provare ad abbozzare delle risposte – generali in merito all’argomento ma anche precise sulla base delle prevedibili sollecitazioni da parte del pubblico – in quella che non si voleva assolutamente trasformare in una tribuna politica abbiamo perciò invitato alcuni protagonisti del mondo della scuola ticinese, concentrando la nostra attenzione sul livello medio, professionale e medio superiore: due alti funzionari del DECS (Tiziana Zaninelli, Caposezione Insegnamento medio e Paolo Colombo, Direttore Formazione professionale), un ex Direttore di Liceo (Aurelio Sargenti, già alla guida della sede Lugano 2) e il Vicepresidente dell’associazione La scuola (Matteo Mozzini, Vicedirettore Arti&Mestieri), affiancati da Pierfranco Longo, Presidente della Conferenza cantonale dei Genitori e da Gianni Righinetti, Vicedirettore del Corriere del Ticino, attento osservatore della realtà ticinese.
Per provare ad abbozzare delle risposte – generali in merito all’argomento ma anche precise sulla base delle prevedibili sollecitazioni da parte del pubblico – in quella che non si voleva assolutamente trasformare in una tribuna politica abbiamo perciò invitato alcuni protagonisti del mondo della scuola ticinese, concentrando la nostra attenzione sul livello medio, professionale e medio superiore: due alti funzionari del DECS (Tiziana Zaninelli, Caposezione Insegnamento medio e Paolo Colombo, Direttore Formazione professionale), un ex Direttore di Liceo (Aurelio Sargenti, già alla guida della sede Lugano 2) e il Vicepresidente dell’associazione La scuola (Matteo Mozzini, Vicedirettore Arti&Mestieri), affiancati da Pierfranco Longo, Presidente della Conferenza cantonale dei Genitori e da Gianni Righinetti, Vicedirettore del Corriere del Ticino, attento osservatore della realtà ticinese.
Se l’entrata in materia del dibattito è risultata piuttosto positiva e incoraggiante sulla qualità della nostra scuola nel suo insieme, con i giudizi espressi dalle rispettive prospettive confortati da dati oggettivi che hanno permesso di sottolinearne il buon posizionamento a livello nazionale, la completezza e l’affidabilità del sistema, sul tavolo sono poi rapidamente scivolati i due soggetti cui sono stati dedicati i successivi interventi dei relatori: il primo, quello dell’inclusione, più teorico e ideologico, che sta trovando terreno fertile nell’agenda di alcuni partiti politici svizzeri, e il secondo, molto più concreto, che scaturisce da una proposta di riforma della scuola media ticinese presentata dall’associazione La scuola, animata da diversi professionisti nell’ambito dell’educazione.
 La discussione che si è sviluppata seguendo questa duplice matrice, solo in apparenza destinata a non poter convergere in una sintesi globale sulle possibilità tecniche ma soprattutto sulle responsabilità sociali della scuola, ha inevitabilmente portato in superficie approcci di fondo diversi sulla funzione stessa della delicata fase dell’istruzione dell’obbligo: da una parte quella di inclusione e di accoglienza – termine che è stato utilizzato in diverse occasioni – che riesca a non sfavorire gli allievi più dotati, senza cioè che essi abbiano a subire conseguenze o ritardi di sorta nonostante l’eterogeneità delle varie classi stimolando la condivisione e il supporto reciproco, dall’altra quella fortemente indirizzata verso il mantenimento delle migliori condizioni per permettere ai giovani con più risorse di poter performare al meglio, scongiurando il rischio di un livellamento generale verso il basso.
La discussione che si è sviluppata seguendo questa duplice matrice, solo in apparenza destinata a non poter convergere in una sintesi globale sulle possibilità tecniche ma soprattutto sulle responsabilità sociali della scuola, ha inevitabilmente portato in superficie approcci di fondo diversi sulla funzione stessa della delicata fase dell’istruzione dell’obbligo: da una parte quella di inclusione e di accoglienza – termine che è stato utilizzato in diverse occasioni – che riesca a non sfavorire gli allievi più dotati, senza cioè che essi abbiano a subire conseguenze o ritardi di sorta nonostante l’eterogeneità delle varie classi stimolando la condivisione e il supporto reciproco, dall’altra quella fortemente indirizzata verso il mantenimento delle migliori condizioni per permettere ai giovani con più risorse di poter performare al meglio, scongiurando il rischio di un livellamento generale verso il basso.
Estremamente interessanti, proprio da questo punto di vista, le divergenze affiorate in particolare nei contributi del Presidente della Conferenza cantonale dei Genitori, che ha auspicato l’importanza del sostegno verso i casi di maggior fragilità evocando spesso le problematiche legate alle difficoltà di molte famiglie e il crescente disagio di alcune fasce giovanili, e del commentatore giornalistico, portavoce di perplessità e preoccupazioni su un paventato impoverimento della qualità forse meno circostanziate ma altrettanto plausibili, anche se forse più sul piano assolutamente legittimo delle sensazioni e dei dubbi che su quello dei riscontri concreti.
 I rappresentanti del mondo scolastico, dal canto loro, hanno ribadito la capillarità e l’efficacia di un’organizzazione che è in grado di interagire all’interno della sua stessa struttura e di offrire molteplici opportunità a ogni studente ma anche la necessità di una miglior comunicazione che consenta alle famiglie di conoscere meglio i diversi percorsi percorribili a livello individuale. Di fronte alla proposta dell’associazione La scuola – che vorrebbe ridurre da 33 a 30 le ore di insegnamento settimanali per permettere l’introduzione di spazi pomeridiani da dedicare alla ricerca e allo sviluppo delle peculiarità di ciascuno in campo professionale, artistico o sportivo – non hanno poi mancato di esprimere le loro inquietudini in merito alla sostenibilità pratica della medesima, che ridurrebbe l’entità della presa a carico da parte dell’istituzione scolastica.
I rappresentanti del mondo scolastico, dal canto loro, hanno ribadito la capillarità e l’efficacia di un’organizzazione che è in grado di interagire all’interno della sua stessa struttura e di offrire molteplici opportunità a ogni studente ma anche la necessità di una miglior comunicazione che consenta alle famiglie di conoscere meglio i diversi percorsi percorribili a livello individuale. Di fronte alla proposta dell’associazione La scuola – che vorrebbe ridurre da 33 a 30 le ore di insegnamento settimanali per permettere l’introduzione di spazi pomeridiani da dedicare alla ricerca e allo sviluppo delle peculiarità di ciascuno in campo professionale, artistico o sportivo – non hanno poi mancato di esprimere le loro inquietudini in merito alla sostenibilità pratica della medesima, che ridurrebbe l’entità della presa a carico da parte dell’istituzione scolastica.
Un punto, questo, che unitamente ai malumori per i tagli previsti dal preventivo cantonale nell’ambito della formazione e ai carichi sempre più gravosi per i docenti è spesso affiorato nei numerosi interventi del pubblico a conclusione di una tavola rotonda che pur senza l’ambizione di individuare risposte definitive a un problema di grande impatto sociale come quello della scuola ha certamente avuto il merito di contribuire al confronto pubblico e libero da qualsiasi condizionamento politico tra tutti gli attori del delicatissimo ecosistema educativo del Cantone.