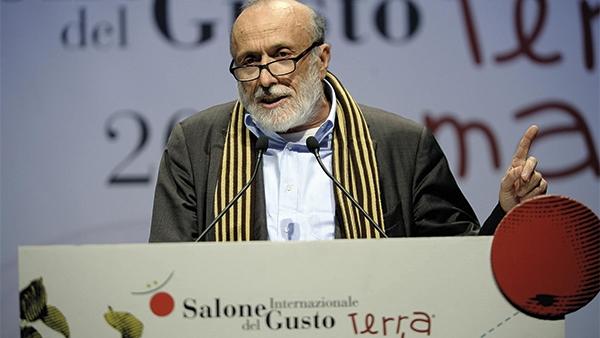Lei è un convinto sostenitore della centralità di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e del paesaggio: che cosa concretamente significa?
«Promuovere un nuovo modello alimentare, rispettoso dell’ambiente, delle tradizioni e delle identità culturali, capace di avvicinare i consumatori al mondo della produzione. Perché l’attuale modello agricolo non è in grado di far fronte alle grandi sfide globali che ormai non possiamo più non permetterci di affrontare come il cambiamento climatico, l’aumento della popolazione, la crescente necessità di consumo nei Paesi emergenti, ecc. Il modello produttivo dominante nella filiera agroalimentare si basa su uno sfruttamento intensivo dei terreni, una distribuzione di massa dei prodotti e il tentativo di introdurre sementi OGM».
Quali sono nello specifico le conseguenze negative di questo modello di sviluppo?
«Innanzitutto è fondamentale restituire centralità al cibo, e per farlo è necessario occuparsi di agricoltura. Anche perché l’attuale situazione del mondo non è altro che il risultato della storia dell’agricoltura occidentale che ha perso di vista alcuni tra i più importanti obiettivi per chi ha a cuore la centralità del cibo. Non si può pensare che se da un lato si incrementa la produttività e lo sfruttamento oltre misura dei terreni e dall’altra non si pone fine alla cementificazione dei suoli fertili, si possa garantire un futuro a noi e al nostro pianeta. È fondamentale quindi un drastico cambio di mentalità, anche perché non dobbiamo dimenticarci che noi siamo ciò che mangiamo. Il discorso si complica se parliamo di OGM: se non si deve infatti essere contrari allo sviluppo di nuove tecnologie, è fondamentale adottare un approccio che prenda in considerazione la tutela della biodiversità e le conseguenze socio-economiche. L’agricoltura transgenica non è sostenibile né conveniente. Insomma, occorre che le scelte tecnologiche in campo agricolo non contrastino con l’interesse dei popoli e con un sano sistema economico».
Quindi servirebbe un cambio di mentalità che ci permetta di cancellare la vera piaga di questa nostra società: lo spreco alimentare…
«Si calcola infatti che per ogni europeo si producono quasi 1000 kg di cibo all’anno, sprecandone però circa 280, 200 dei quali già nei campi, nelle aziende di trasformazione e nei supermercati, prima ancora che arrivino al consumatore».
Le grandi aziende agroalimentari potrebbero essere inserite in un nuovo modello più responsabile verso la biodiversità, la cultura locale, la salute del consumatore e la riduzione degli sprechi?
«Alcune grandi aziende lo fanno già. Il loro coinvolgimento è essenziale per l’agricoltura. Ma anche per loro perché più sono vicine ai produttori e meglio possono offrire prodotti sicuri e buoni. Quando i prodotti fanno tanti chilometri, quando non c’è una filiera ben tracciata, nascono problemi sia per il buon nome dell’azienda sia per il consumatore».
Nel mondo ci sono Paesi sviluppati, emergenti, in via di sviluppo e poveri. Dove occorre maggiormente insistere al fine di far affermare un modello agroalimentare più sostenibile?
«Non si può fare una distinzione tra i vari Paesi, serve che tutti si impegnino per affermare un nuovo modello agroalimentare sostenibile: sicuramente però sono i paesi sviluppati ad avere una responsabilità maggiore in questo processo e a poter guidare il Sud del mondo in un percorso nuovo. In primis lottando contro fenomeni di colonizzazione e land grabbing. Ci sono moltissime comunità del cibo che portano avanti progetti importanti per il loro territorio, di cui troppo spesso non siamo a conoscenza. Impariamo da loro, condividiamo esperienze e tradizioni».
Quale è il mezzo migliore per cambiare i criteri dell’agricoltura moderna? In particolare, occorre fare maggiormente leva sull’educazione del consumatore oppure delle istituzioni nei loro processi di stimolo all’attività agricola?
«Sicuramente c’è bisogno di fare leva su entrambi gli attori. Noi da sempre puntiamo sulle attività di educazione per grandi e piccoli, fondamentali per cambiare i paradigmi, le abitudini e far quindi leva sulle istituzioni. Per far questo occorre mettere in campo una serie di azioni combinate a partire dal progetto Terra Madre: una grande rete di comunità del cibo, uomini e donne che lavorano a un progetto comune, pur conservando le loro differenze e tradizioni. È un modo nuovo di intendere la produzione, la trasformazione e consumo del cibo, che trae origine dal passato e dalla storia, ma allo stesso tempo con uno sguardo proiettato in avanti. Gli incontri delle comunità sono fondamentali per ridare vita alla rete, per rinsaldare il senso di appartenenza, condividere nuove idee che attraversano oceani e continenti. La rete di Terra Madre e i suoi protagonisti sono attivi ogni giorno in ogni parte del mondo. Dobbiamo partire dal cibo come ricchezza, come scambio, come cultura. Solo proteggendo il nostro cibo possiamo pensare di salvaguardare le nostre risorse e il pianeta che ci ospita. La produzione, la distribuzione e il consumo di cibo ci coinvolge in maniera totale».