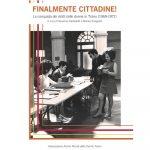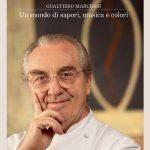Lei ha attraversato il mondo del giornalismo e dei media in Ticino nel corso degli ultimi quarant’anni. Dal suo osservatorio privilegiato, come si è andata trasformando la società ticinese?
«Ho mosso i primi passi da giornalista nel 1981, quando in tipografia c’erano ancora le linotype e il piombo e in redazione le telescriventi e rudimentali, lentissimi fax. I partiti governativi avevano tutti il loro quotidiano: Il Dovere per il PLRT, Popolo e Libertà per il PPD, Libera Stampa per il PST. La Lega dei Ticinesi era di là da venire, la sinistra era divisa tra PST, appunto, e PSA. Il Ticino era caratterizzato da una granitica stabilità politica (lo spostamento di un seggio in Parlamento da un partito all’altro era considerato un mezzo terremoto). C’erano 90mila abitanti in meno, era stata aperta da pochissimo la galleria autostradale del San Gottardo, i veicoli erano solo 140mila, non avevamo né l’Università né la SUPSI, né il LAC né il Palacinema, il ginnasio e la scuola maggiore erano stati pensionati non molto tempo prima, i disoccupati erano meno di mille, c’erano già più di 30mila frontalieri (si chiamavano ufficialmente confinanti) e anche quasi 5000 stagionali (categoria oggi sparita). Due procuratori pubblici dovevano confrontarsi con i giudici istruttori, carica poi inopportunamente soppressa. Alle Assise criminali si celebrava una trentina di processi all’anno. Di fusioni bancarie nemmeno si parlava, c’era ancora, ben salda, la Monteforno. Si dibatteva animatamente tra i fautori del più Stato e quelli del meno Stato, il populismo era un lemma nei dizionari della politica, la progettata nuova centrale nucleare di Kaiseraugst era al centro dello scontro politico, nella Costituzione federale venne inserito l’articolo sulla parità uomo-donna. Si potrebbe continuare. Questa fotografia di allora dà bene l’idea di come la società ticinese sia cambiata. Non sono tra coloro che credono nel bel tempo che fu. Oggi il Ticino sta meglio, il Ceresio è più pulito e perfino l’aria è meno inquinata. Abbiamo seguito, tra alti e bassi e tra aperture e chiusure, la traiettoria di progresso della società occidentale in generale. Con un punto negativo: il Ticino è diventato più brontolone e rancoroso».
In questi decenni editoria e giornalismo hanno attraversato un radicale cambiamento determinato dalla rivoluzione digitale. Come ha vissuto questo processo?
«Con passione, curiosità, voglia di esserne partecipe. Da un’epoca all’altra. È stata proprio una rivoluzione. Anzi, una doppia rivoluzione. Prima con l’introduzione dei computer, dell’impaginazione su schermo, della stampa offset. Poi con l’avvento di Internet. Se penso alle proteste dei tassisti contro Uber e confronto questo cambiamento con lo tsunami che ha investito la stampa con il web, i blog, i social network, l’informazione gratuita – altro che a basso prezzo – sorrido. Processi così innovativi e imprevedibili nei loro sbocchi e nelle loro implicazioni vanno affrontati con spirito positivo, accettando la sfida, con creatività, non con l’illusione di potersi ritagliare una zona off limits, protetta dalle correnti d’aria e dalle bufere».
Come è cambiato il mestiere del giornalista e quali sono le competenze oggi indispensabili per svolgere questa attività?
«La missione del giornalista non è cambiata. Compito fondamentale del giornalista è dare conto dei fatti che accadono qui e intorno a noi, nel mondo, nel modo più fedele possibile, e fornire delle chiavi di lettura. Sempre separando rigorosamente i fatti dalle opinioni. Sono invece radicalmente cambiati gli strumenti di lavoro e il contesto. Nella cassetta degli attrezzi ci sono le nuove tecnologie che offrono possibilità un tempo inimmaginabili per cercare notizie, documentazione, materiali, per verificare l’attendibilità di quanto si viene a sapere. Il contesto è una galassia immensa e densissima di fonti di informazione e di soggetti che fanno informazione, moltissimi scavalcando il ruolo del giornalista come mediatore tra il fatto e il pubblico. Il giornalista dell’era digitale deve avere tutte le competenze che erano richieste al giornalista dell’era pre-digitale con in più competenze tecniche di molto accresciute e una velocità di lavoro superiore. Il rischio dell’errore è in agguato dietro ogni frase scritta o pronunciata: e se sbagli, oggi sei sbugiardato in pochi istanti e messo alla berlina nella Rete».
Il Corriere del Ticino è stato in passato ed è attualmente la sua “casa”, all’interno della quale ha ricoperto ruoli diversi fino alla direzione del quotidiano. Quali sono le sfide che attendono oggi un gruppo presente in tutti i settori dei media ticinesi?
«Sono entrato al Corriere del Ticino nel 1991 con Sergio Caratti, quando il quotidiano compiva il secolo di vita. Ci sono tornato nel 2007 con Giancarlo Dillena, dopo una parentesi di sette anni al Dipartimento delle finanze e dell’economia a Bellinzona. Sono direttore dal 1 gennaio 2016, l’anno in cui il Corriere ha festeggiato i 125 anni di esistenza. Il Corriere era una testata, oggi è un gruppo editoriale, con giornali, siti online, radio e televisione. La sfida è affrontare e superare gli scombussolamenti portati dalla rivoluzione digitale. Per l’industria dell’informazione è come essere sopravvissuti in una località di mare dopo uno tsunami. In tutti i Paesi avanzati è stato compiuto un errore di fondo: riversare gratuitamente nella Rete le notizie. Nessun ramo economico, con l’avvento di Internet, si è messo a regalare i suoi prodotti. L’editoria giornalistica sì. È stata una follia collettiva, inconsapevole. Poi ci si è illusi che valesse, quale modello di business, l’equazione “tanti clic = tanti lettori e abbonati = tanta pubblicità”. Non è stato così. Si è ora, ovunque, nella seconda fase, con l’introduzione di varie forme di pagamento. La terza fase sarà il ritorno al pieno pagamento dell’informazione, perché l’industria della notizia regalata è un non senso economico e perché pubblicare notizie costa».
Come si costruisce l’autorevolezza di un giornale e come la si mantiene nel tempo, soprattutto in un’epoca in cui l’accertamento delle verità diventa sempre più difficile?
«Con una scrupolosa professionalità, con l’umiltà di essere e sentirsi al servizio del lettore e con l’indipendenza. È la ricetta vincente del Corriere del Ticino da 127 anni. Essere indipendenti non vuol dire essere neutrali. A volte si cade nell’equivoco. Vuole invece dire darsi una linea politico-editoriale in totale autonomia, senza farsela dettare da partiti, enti, associazioni, e poi perseguirla e applicarla con coerenza e libertà».
Lei è profondamente legato al Ticino. Quali sono gli aspetti della società ticinese che più condivide e quelli che vorrebbe vedere modificati?
«Il Ticino è la mia terra. Qui sono nato, ho studiato, messo su famiglia, ho gli amici, qui lavoro. È una terra che ti lascia “un güst da pan da segra”, come direbbe il grande poeta dialettale Giovanni Bianconi. Lo si gusta così com’è, nella sua genuinità».