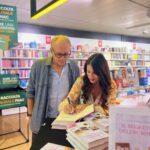Parliamo di Jonas Marti. La storia ha due protagonisti. Da un lato, c’è chi il passato e chi lo ha vissuto. Dall’altro, troviamo chi ne descrive gli ambienti, i corsi ed i ricorsi. Sono due lati della stessa medaglia, ma che pochi riescono a interpretare secondo una visione coordinata. Ancor meno sono coloro che riescono a fuggire alla tentazione di riferirne il significato come un prodotto di facile consumo.
Parliamo di Jonas Marti. La storia ha due protagonisti. Da un lato, c’è chi il passato e chi lo ha vissuto. Dall’altro, troviamo chi ne descrive gli ambienti, i corsi ed i ricorsi. Sono due lati della stessa medaglia, ma che pochi riescono a interpretare secondo una visione coordinata. Ancor meno sono coloro che riescono a fuggire alla tentazione di riferirne il significato come un prodotto di facile consumo.
Invece è proprio grazie ad un esercizio di ricerca documentato, approfondito e rigoroso, facile solo a dirsi, che il pubblico non solo apprezza il valore della cronaca storica, ma ne promuove il divulgatore ad interprete autorevole di fatti cui non ha partecipato.
Jonas Marti, con il tuo lavoro hai ribaltato un facile stereotipo: nella città dove vivo non c’è niente di interessante. Come nasce la tua passione per la storia?
«Ho una formazione umanistica, con studi di latino e greco. Questo mi predispone a capire che il passato attende di solo essere riscoperto, e la storia oltre che dalle interazioni fra popoli, è fatta anche da individui, ciascuno con esperienze che inevitabilmente condizionano le nostre collettività. Inoltre, che dove ci troviamo a vivere in fondo non ci sia niente di interessante é un malinteso da cui mi sono ricreduto studiando i trascorsi del nostro territorio. In questo lavoro, di grande aiuto è stata la mia esperienza giornalistica nell’attualità internazionale, dove ho imparato che i fatti, contemporanei o storici, sono da interpretare come una sequenza di eventi in continua evoluzione».
Come è possibile parlare di storia evitando il nozionismo, senza annoiare il pubblico?
«La progressione dei fatti storici si sviluppa come un romanzo. La mia ricerca parte dalle piccole storie, spesso curiose, e da quelle inizio a raccontare i fatti. In particolare, è nella quotidianità storica, con i suoi problemi e difficoltà, che trovo personaggi del passato in cui anche il pubblico di oggi riesce ad identificarsi, e che allo stesso tempo ci convincono che quanto accaduto secoli fa non è poi così diverso da quello che noi viviamo oggi, anzi ancor più interessante quando ci rendiamo conto che abitiamo nello stesso territorio. Per esempio, già ad inizio Cinquecento il profilo montuoso del San Salvatore per gli assediati nel castello di Lugano era identico a come oggi lo vediamo noi. Nella rievocazione delle cronache storiche, dicevo, sono aiutato dal mio passato di giornalista. In particolare, la tecnica narrativa ha bisogno di “effetti sorpresa”, per creare pause, ed alleggerire il racconto di fatti. Insomma, per sceneggiarli, come si dice in linguaggio tecnico, oltre a concatenare le informazioni storiche in modo logico e pertinente, devo anche studiare dove è necessario concedere una pausa al pubblico. Quindi, spesso mi domando: dove iniziare? Come, dove, quando creare un intervallo tra gli eventi e mantenere l’attenzione del pubblico? Facciamo un esempio: piuttosto che dilungarmi nella presentazione di un evento storico, invece preferisco commentare un dipinto che lo rievoca, magari scegliendo un affresco conservato in una chiesa. In tal modo il pubblico viene informato sui fatti, ma in modo diversificato, con informazioni che riguardano anche l’architettura, la tecnica figurativa e gli artisti di uno specifico periodo, l’abbigliamento dei nobili, dei guerrieri, e della gente comune. Tutti protagonisti di un passato cui oggi noi comprendiamo di appartenere».
Quanto la storia ha influenzato il carattere della gente che vive nel nostro cantone?
«È sempre difficile individuare “l’anima” di un territorio. Perché con il succedersi delle epoche, cui negli ultimi decenni è aggiunta una straordinaria globalizzazione il Ticino è diventato progressivamente un melting pot, una combinazione di caratteri sociali differenti fra loro. Basti pensare alla sequenza delle popolazioni che nel corso dei millenni hanno occupato le nostre terre. Hanno iniziato i Celti, i guerrieri indoeuropei che hanno occupato il Ticino in epoca pre-cristiana; poi i Romani; quindi i Longobardi, i Comaschi, i Milanesi, cui sono seguiti gli Svizzeri. Sono tutti gruppi che si sono stratificati sull’identità ticinese, che di base è lombarda. Questi arrivi nel nostro territorio hanno favorito una contaminazione straordinaria: culturale, sociale, persino gastronomica, come ci ricordano i nostri menu dove ormai convivono la pasta ed il rösti. Anche questi semplici elementi confermano che una caratteristica del nostro territorio resta il confronto costante tra differenti culture, destinate ad arricchirsi reciprocamente. Con il mio lavoro quindi mi propongo non solo di migliorare la conoscenza del nostro passato, ma anche richiamare quegli elementi identitari che agevolano la interpretazione di tutte quelle novità che il futuro, come già accaduto nel passato, è destinato a portarci. Questo, ancora una volta, testimonia che il Ticino resta un luogo di accoglienza, particolarmente in una prospettiva sociale-culturale, come per esempio è accaduto nell’Ottocento, con gli esuli arrivati nel nostro cantone durante il Risorgimento italiano».
Come può un giornalista organizzare le sue ricerche con la autorevolezza e la attendibilità di uno storico? Il tuo volume, “Lugano la bella sconosciuta”, elenca una importante sequenza di fatti, tutti documentatissimi, ed è stato premiato dal pubblico con oltre 10.000 copie vendute e ben quattro edizioni….
«Il mio lavoro segue le regole della professione giornalistica, come sempre: parto dai fatti, e da una costante verifica delle fonti. Nella mia libreria ho moltissimi libri sulla storia del nostro territorio, frutto delle infinite ricerche compiute in epoche lontane dagli studiosi. Mi ritengo “un nano sulle spalle dei giganti”, come il filosofo francese Bernardo di Chartres già nel dodicesimo secolo presentava il suo lavoro. Non sono uno storico, sono solo un divulgatore, ma mi nutro costantemente delle ricerche degli storici per poi riproporle al pubblico. Il mio metodo supera una ricostruzione storica che elenca date e luoghi proposti in modo orizzontale. Al contrario, preferisco descriverli come una sequenza verticale, cioè spiegando i motivi che trasformano il semplice fatto di cronaca in un evento importante in ottica sociale, umana e quindi storica. In tal modo riesco a liberarmi dalle interpretazioni di giornata, dall’ansia delle breaking news, ed interpreto la storia secondo una prospettiva di lungo periodo. È bene ricordarlo: chiunque giudica l’epoca in cui vive, inevitabilmente la considera peggiore delle precedenti. Invece la progressione delle relazioni sociali è fatta di cicli altalenanti, sorprendenti, che oggi comprendono anche rivoluzioni tecnologiche come la digitalizzazione. Ecco perché credo sia giusto ricordare che, nella storia del mondo, è dall’inizio del genere umano che le innovazioni si presentano in modo continuo. Ma anche oggi, come in passato, fanno parte della nostra vita e sono convinto che anche nella nostra epoca globalizzata riusciremo sempre a metterle al nostro servizio».