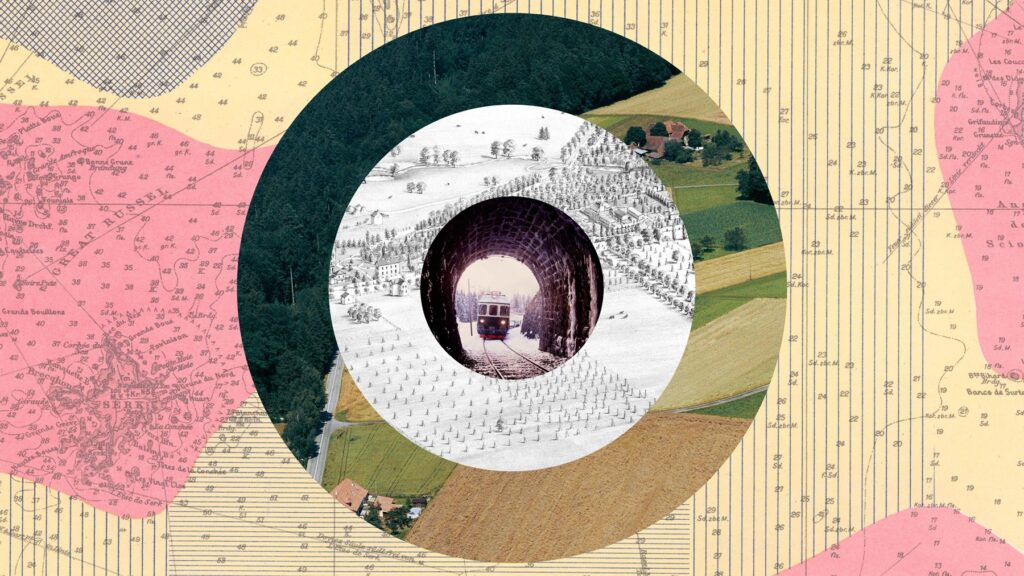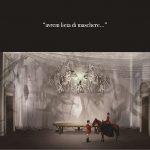Il 12 maggio il MASI, al pari delle altre istituzioni museali, ha potuto riaprire i battenti. Con quali prospettive?
«Questo periodo di forzata chiusura è stato tuttavia molto intenso perché ci siamo trovati ad affrontare una situazione totalmente inedita: quella della gestione di un museo all’epoca del distanziamento sociale e della sicurezza per tutti, personale, collaboratori e visitatori, che dopo la riapertura sono tornati a frequentare le sale del MASI. La prima preoccupazione è stata dunque quella di ottemperare a tutte le disposizioni previste, garantendo i necessari dispositivi di protezione individuale e attuando tutte le procedure necessarie per consentire l’accesso alla struttura in condizioni di massima sicurezza».
E dal punto di vista della programmazione culturale?
«A questo proposito occorre fare una necessaria premessa. La vita e l’attività espositiva di un museo come il nostro necessita di una programmazione pluriennale, occorre cioè stabilire con largo anticipo quali saranno le mostre future perché ogni progetto richiede, per la sua realizzazione, il coinvolgimento, tra gli altri, di artisti, istituzioni museali, collezioni private, conservatori, curatori, operatori specializzati in logistica, assicuratori ed esperti d’arte. Nel momento in cui questo ben collaudato meccanismo si inceppa, si genera una sorta di “effetto domino” con ricadute pesanti sulla possibilità di recuperare progetti già programmati da lungo tempo e inseriti in un fitto calendario di eventi culturali su scala internazionale».
Nello specifico, quali ripercussioni si sono avute nella programmazione del MASI?
«Abbiamo purtroppo e con grande dispiacere dovuto annullare la mostra dedicata a Monet, Cézanne e Van Gogh e altri grandi artisti, la cui apertura era prevista per il 15 marzo e che avrebbe dovuto portare a Lugano capolavori provenienti da una delle collezioni private più prestigiose al mondo: la collezione Emil Bührle. Questa collezione custodisce infatti dipinti dei più importanti artisti del XIX e XX secolo, in particolare dei principali rappresentanti dell’impressionismo e del post-impressionismo. Secondo l’originario programma il pubblico avrebbe potuto ammirare la bellezza dei dipinti raccolti da Emil Bührle prima del loro ritorno a Zurigo, nella nuova estensione del Kunsthaus, sede a cui la collezione è definitivamente destinata».
Cosa è dunque possibile visitare in seguito alla riapertura?
«Abbiamo deciso di prolungare, nella sede di Palazzo Reali, la mostra “Shunk-Kender. L’arte attraverso l’obiettivo (1957-1983)”. A partire dagli anni ‘50 il fotografo tedesco Harry Shunk e quello ungherese János Kender diedero avvio a una duratura e fruttuosa collaborazione. Il duo documentò, principalmente a Parigi e New York, inaugurazioni, biennali, artisti all’opera nei loro atelier o impegnati in performance pubbliche. Il loro lavoro restituisce, quindi, un’inestimabile testimonianza del mondo dell’arte d’avanguardia e dei suoi più celebri rappresentanti: Andy Wahrol, Christo e Jeanne-Claude, Yves Klein, Daniel Spoerri, Niki de Saint Phalle e Jean Tinguely. Il percorso espositivo si compone di 450 scatti e documenti originali, selezionati tra i più di 10’000 donati dalla Roy Lichtenstein Foundation nel 2014 e conservati presso il Centre Pompidou di Parigi. Le fotografie esposte immergono il pubblico nella scena artistica tra la fine degli anni ‘50 e l’inizio degli anni ’70, costantemente alla ricerca di spazi alternativi in cui creare e diffondere il loro lavoro».
E per quanto riguarda i prossimi mesi?
«Per fine agosto abbiamo previsto l’apertura di una mostra dedicata a PAM Paolo Mazzuchelli, con una selezione di opere che spaziano dagli esordi negli anni Settanta fino ai giorni nostri. L’allestimento, che si compone prevalentemente di opere di grande formato, evidenzia, inoltre, le varie tecniche impiegate da Mazzuchelli: oli su tela, disegni a carboncino o china e incisioni. Il percorso espositivo non segue un itinerario cronologico, ma si sviluppa in nuclei di opere accomunate da tematiche e soggetti ricorrenti. Tra questi emergono elementi legati al mondo vegetale, figure mistiche e paesaggi visionari e apocalittici che, sin dagli esordi, hanno accompagnato Mazzuchelli nella sua opera. Tra le opere in mostra sarò esposto il monumentale ciclo di disegni grazie al quale Mazzuchelli si aggiudicò la Borsa federale delle belle arti nel 1992 e nel 1993. Inoltre, a inizio settembre, è prevista l’esposizione dal titolo “Vincenzo Vicari. Fotografo del Ticino che cambia”. Si tratta di una mostra monografica dedicata al fotografo ticinese Vincenzo Vicari, attivo a Lugano dal 1936. La mostra permette di ripercorrere oltre cinquant’anni di attività dell’artista, durante la quale ha documentato la trasformazione del territorio ticinese e della sua gente. Per valorizzare la varietà della sua produzione artistica e di documentazione – dal ritratto in studio alla fotografia di cronaca, dalle riprese aeree alla rappresentazione delle attività industriali – la mostra si sviluppa coinvolgendo diverse altre istituzioni nelle loro sedi. Tra queste Palazzo Franscini a Bellinzona, il Museo della Pesca a Caslano, la Sala del Torchio a Sonvico e la Casa Rotonda – Fondazione Roberto Donetta a Corzoneso. L’esposizione, coordinata dall’Ufficio patrimonio della Divisione cultura della Città di Lugano e curata da Damiano Robbiani, sancisce la prima tappa di valorizzazione del fondo fotografico Vincenzo Vicari conservato all’Archivio storico di Lugano, che ha permesso la catalogazione, il restauro e la digitalizzazione di quasi 5.000 negativi».
Da ultimo, quali conseguenze avrà l’esperienza vissuta in questi mesi sulla futura attività museale e sull’organizzazione delle manifestazioni culturali?
«È molto difficile dirlo oggi perché non siamo ancora definitivamente fuori dalla pandemia e non sappiamo quando potremo ritenere del tutto superata l’emergenza. In ogni caso, oltre alla necessità del mantenimento costante di elevate misure di sicurezza, la situazione di questi mesi ha dimostrato come sia complesso organizzare eventi quali una grande mostra di dimensioni internazionali, con tutte le implicazioni nel campo della sicurezza, della logistica, dei trasporti, ecc. Se si considera poi che per mesi, o forse anni, è facile prevedere una drastica riduzione anche dei flussi di viaggiatori per motivi culturali, è probabile che per qualche tempo l’attività si orienterà sempre più verso la valorizzazione delle risorse artistiche e culturali di ogni territorio. E da questo punto di vista il Ticino ha, per sua fortuna, davvero molto da offrire».