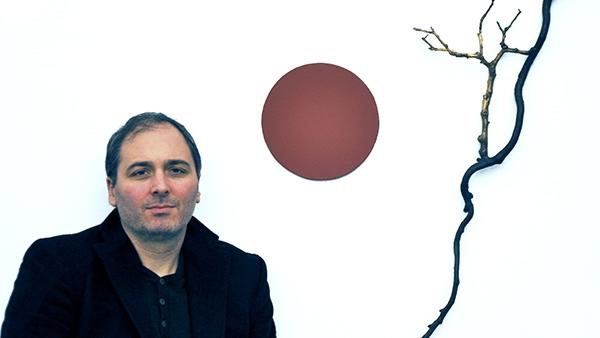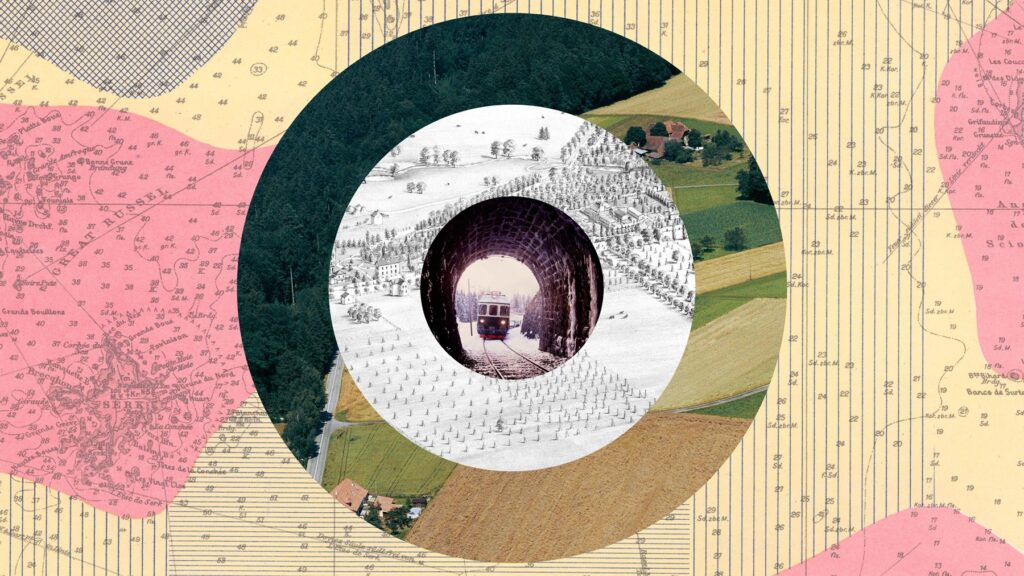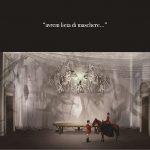Come nasce l’idea di dare vita ad una serie di iniziative, in vari settori artistici, tutte focalizzate su aspetti diversi della cultura indiana?
«Già prima dell’apertura del LAC si era ragionato intorno all’ipotesi di concentrare, in talune occasioni, gli sforzi delle diverse discipline su un unico Paese, al fine di offrire un quadro più esauriente e articolato possibile di quella cultura. Dopo l’esperienza Nippon è nato così il progetto Focus India, un’ampia e inedita programmazione pensata per abbracciare in maniera interdisciplinare l’arte visiva, la musica, la danza e il cinema, oltre alle altre numerose sfaccettature della cultura indiana, quali la medicina, la meditazione e la cucina. Durante tutto il corso dell’autunno si sono quindi succeduti numerosi appuntamenti dedicati alla musica e alla danza, oltre ad un’ampia programmazione di eventi e attività, fra workshop sulla danza narrativa indiana, laboratori per bambini, conferenze sull’ayurveda, sessioni di yoga, letture, master class con gli artisti presenti e un’inedita rassegna cinematografica curata da Marco Müller».
Venendo allo specifico delle arti visive, la mostra “Sulle vie dell’illuminazione” lungo quali principali direttrici di sviluppo si articola?
«Il tema su cui si incardina la mostra riguarda il modo in cui il mondo indiano ha esercitato la sua influenza e fascinazione nei confronti della cultura occidentale. Il percorso espositivo, esteso sui due piani del Museo, mostra dunque attraverso 400 opere e una molteplicità di materiali, la profonda influenza che l’India ha esercitato sull’arte e sulla cultura occidentale negli ultimi due secoli: dalle riflessioni sull’induismo e sul buddismo di Schopenhauer, cui si rifarà negli anni a venire anche la letteratura di Herman Hesse, divenuta un riferimento per intere generazioni con Siddhartha, alle analisi antropologiche di Carl Gustav Jung; dai romanzi popolari di Kipling ed Emilio Salgari, al cinema di Rossellini e Pasolini. E poi ancora i Beatles che contribuirono a rendere l’India di moda tra la gioventù occidentale, come testimonia il connubio tra musica, spiritualità orientale e sperimentazione psichedelica della controcultura giovanile tra gli anni Sessanta e Settanta. Senza dimenticare, infine, gli scatti “indiani” di Henri Cartier-Bresson e di Werner Bischof, la città ideale immaginata a Chandigarh da Le Corbusier e i tanti artisti che negli ultimi decenni hanno tratto ispirazione e influenze dal subcontinente indiano: da Robert Rauschenberg a Frank Stella, da Richard Long a Luigi Ontani da Francesco Clemente ad Anselm Kiefer, per citarne solo alcuni».
Ma perché l’India e le sue tradizioni millenarie hanno sedotto una moltitudine così ampia di intellettuali ed esponenti della cultura europea?
«Credo che una risposta vada innanzitutto ricercata nel fatto che la cultura di questo grande Paese, in virtù soprattutto dei presupposti spirituali che ne stanno alla base, sia diventato quell’altrove mitico cui il mondo Occidentale, soprattutto a partire dagli anni Sessanta, ha guardato come alternativa a un contesto sempre più rigidamente sottomesso alle logiche materiali della produzione e del consumo. Cosa rimanga di questo mito oggi, di fronte a una realtà sempre più globalizzata, è la domanda con cui l’ultima sezione della mostra ci proietta dentro l’attualità del nostro tempo, cercando di offrire uno sguardo sull’India di oggi attraverso gli scatti di grandi fotografi contemporanei come Sabastião Salgado, Ferdinando Scianna, Michael Ackerman, Steve McCurry e Martin Parr».