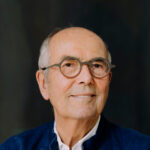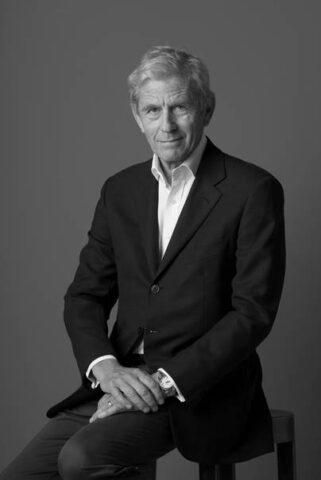 Gianluca Bonetti, lei è nato in una famiglia dedita alla filantropia da generazioni. Che significato ha avuto per lei crescere in un ambiente in cui la generosità e sempre stato uno dei valori portanti?
Gianluca Bonetti, lei è nato in una famiglia dedita alla filantropia da generazioni. Che significato ha avuto per lei crescere in un ambiente in cui la generosità e sempre stato uno dei valori portanti?
«La famiglia di mia madre, Soldati, partecipa sin dalla fine dell’Ottocento all’evoluzione della società ticinese. Animati da un forte spirito imprenditoriale alcuni membri hanno vissuto in prima persona la stagione dell’emigrazione. Lasciato alle spalle il povero Ticino contadino, sono emigrati in Argentina dove hanno fatto fortuna. Mossi da spirito filantropico, dopo essere tornati nella terra natia hanno contribuito alla modernizzazione del paese sostenendo progetti come la Ferrovia Lugano Ponte Tresa e la costruzione della strada cantonale Magliaso-Neggio. Nel 1891 un membro della nostra famiglia, il giudice Federale Agostino Soldati, ha fondato il Corriere del Ticino con l’intento di aiutare il giovane Governo ticinese a far collaborare le due principali forze politiche del paese, che allora si scontravano anche con le armi. Per volontà del fondatore nel 1941 il Corriere è diventato una Fondazione di diritto privato e di interesse pubblico, avente come scopo di contribuire alla crescita sociale, economica e culturale del Territorio.
Da allora, per statuto, la famiglia rinuncia ai dividendi. Gli utili vengono lasciati nell’azienda per finanziare lo sviluppo e soprattutto al fine di alimentare le riserve per i tempi difficili, come quelli che l’editoria quotidiana sta attraversando ora, garantendo in tale modo la continuità della Fondazione. Considero un privilegio poter partecipare alla vita di questa significativa realtà perché, in particolare, considero l’informazione una conoscenza basilare per la crescita degli individui e della società civile».
Si può dire che c’è un sapere famigliare che grazie alla tradizione filantropica si tramanda di generazione in generazione, e come?
«Nel caso della nostra famiglia assolutamente si. Da cinque generazioni infatti, membri della famiglia Soldati, i cui diversi rami portano ora anche altri cognomi – Guasti, Foglia, Bonetti – dedicano una parte anche significativa del proprio tempo alla Fondazione Corriere del Ticino portando le proprie competenze professionali nei Consigli d’Amministrazione delle varie società e partecipando a gruppi di lavoro dedicati a tematiche strategiche».
Parliamo del nuovo contesto degli ultimi anni (guerra, pandemia, crisi climatica). In che modo questo contesto ha cambiato a suo parere il quadro della filantropia?
«Credo che le crisi e le emergenze costringano il settore pubblico, la politica, a focalizzarsi sul breve periodo, sulla ricerca di soluzioni che riportino a una certa normalità. ll privato può in questi periodi contribuire invece ad alimentare una visione di più ampio respiro sulle grandi questioni e sfide con le quali la polis si trova e si troverà confrontata, come le crisi da lei accennate».
Nel corso di diversi dibattiti e occasioni pubbliche lei ha insistito sulla necessità di riposizionare la cultura come valore portante della società civile. Cosa intende concretamente?
«Spesso la cultura viene vista come un accessorio, un qualcosa di non indispensabile, quasi un lusso che in certe situazioni la società civile non si può permettere, come durante i periodi congiunturali difficili. Io vedo invece la cultura come un insieme di ingredienti indispensabili di una ricetta atta a promuovere una società civile equilibrata e costruttiva. La cultura ai miei occhi nutre lo sviluppo dell’individuo, favorisce l’espressione dei talenti e facilita infine anche la creazione di valore economico. La cultura sedimenta terreno propizio alla crescita umana. Homo e Humus hanno d’altronde la stessa radice etimologica».
Quale può essere il ruolo dei filantropi in questo riposizionamento?
«Sicuramente attraverso iniziative che sensibilizzino le nuove generazioni all’area umanistica, come la storia, la storia dell’arte, la filosofia, le arti visive, la musica ecc. In Svizzera e in particolare in Ticino, a mio modo di vedere, la scuola dà troppo poco spazio a questo tipo di conoscenze rispetto a quanto avviene per le discipline tecniche. I filantropi nella cultura possono inoltre contribuire al suo riposizionamento agendo come dei contemporanei influencer, rendendo in questo modo trendy le discipline umanistiche». Inoltre, anche finanziando attività di divulgazione con un taglio pop. Penso ad esempio all’attività divulgativa di Alessandro Barbero, uno storico che riesce ad appassionare più generazioni a una materia troppo spesso vissuta come accademica, distante e polverosa».
Che cosa possono fare le istituzioni culturali ticinesi per favorire la collaborazione con i filantropi?
«Il Ticino gode di una importante densità di istituzioni e di iniziative culturali pubbliche e private anche di elevata qualità rispetto alla sua popolazione. Il limite attuale di questa offerta culturale è la sua frammentazione, la mancanza di una visione e di una azione sistemica. Ognuna porta avanti il suo programma senza interessarsi al programma delle altre. Una collaborazione tra istituzioni pubbliche e private nella programmazione sarebbe di grande utilità per le stesse e di grande interesse per il pubblico. Oltre a incrementare la visibilità delle iniziative permetterebbe al nostro territorio di posizionarsi come una terra della cultura».
In che modo le istituzioni pubbliche e i filantropi ticinesi possono adoperarsi per dare una risposta efficace e sostenibile alle grandi sfide a cui è chiamato a rispondere il Ticino della cultura?
«Promuovendo una visione sistemica dei vari settori culturali. Porto qui un esempio concreto di un affascinante visione che si sta concretizzando in questo senso: La Città della Musica. A Lugano nei prossimi anni nascerà infatti un intero quartiere dedicato alle attività musicali. La città ha trovato un accordo con SSR per l’acquisto di tutta la proprietà dove oggi ci sono gli studi della RSI. Vi si insedierà il Conservatorio della Svizzera italiana, che lascerà la sua sede di Moncucco, la Fonoteca Nazionale, l’OSI, il Coro e i Barocchisti. Si intende anche sviluppare una sorta di Campus, soprattutto per la componente universitaria del Conservatorio e per i musicisti professionisti. Una grande visione del settore pubblico che permetterà interessanti progettualità anche per il settore privato.
Vorrei anche spendere una parola sulla potenzialità della cultura come settore economico, soprattutto se vista come calamita per un certo tipo di turismo di qualità: il turismo culturale. La nostra regione ha infatti tutte le carte in regola per posizionarsi come destinazione del turismo culturale. Bisogna solo mettere a sistema le principali offerte culturali del territorio».
Qual’è la sua personale visione della filantropia del futuro?
«Oltre a focalizzarsi su progetti specifici, vicini alla propria sensibilità e ai propri interessi culturali, i filantropi dovrebbero anche cercare di contribuire a promuovere, come detto prima, la visione sistemica, un modo di vedere la realtà che fa tanto fatica a farsi strada. Vedo inoltre la filantropia come una componente sempre più necessaria alla crescita sociale e culturale della Società. Perché lo stato non è in grado di finanziare tutto. Ritengo che il privato possa contribuire enormemente nella diffusione dei contenuti umanistici e anche della cultura scientifica».