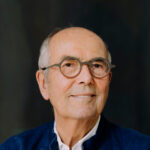Dottoressa Ellen Ringier, Lei ha un dottorato in giurisprudenza, è una filantropa impegnata e una combattente instancabile: tre caratteristiche che la descrivono come persona?
«Amante dell’umanità, sostenitrice della giustizia, in cerca della verità».
Dove è cresciuta e quali personalità l’hanno influenzata da bambina e da giovane donna?
«Sono cresciuta a Lucerna e mia madre e le mie due nonne, che provenivano da contesti culturali diversi, hanno senza dubbio avuto su di me un’influenza maggiore di quella dei loro mariti. Sono stati inoltre gli studi umanistici fatti al liceo, le esperienze in numerosi gruppi sportivi e con gli scout, nonché gli studi di giurisprudenza che mi hanno aiutata a diventare quella che sono».
In che modo il suo background personale e la sua educazione hanno influenzato la sua percezione dei problemi sociali e la sua volontà di agire?
«Il mantra del mio nonno inglese era: “L’unica cosa che conta nella vita è dare una possibilità agli altri”. È diventato un motto anche per me, e di fatto il senso della mia vita. Cosa volevo e voglio ottenere dalla mia vita? Non fare del male (intenzionalmente) a nessuno e, laddove possibile, sostenere le persone in difficoltà fisica o psicologica (ad esempio in crisi personale o economica) e aiutarle a trovare una via d’uscita».
Quando ha deciso di dedicarsi alla filantropia e come è nata questa passione?
«Ho lasciato la professione forense all’età di quarant’anni e, grazie alle risorse finanziarie per le quali devo ringraziare mio nonno, ho aperto un mio ufficio con l’obiettivo di realizzare ciò che avevo sempre avuto in mente, ovvero aiutare altre persone in difficoltà. A scanso di equivoci, questo non ha nulla a che vedere con l’essere una “benefattrice”, ma con un’idea, se così si può dire “egoistica” del senso che voglio dare alla mia vita».
Quali valori e convinzioni la guidano come filantropa?
«Si potrebbe dire che soffro di fronte all’ingiustizia che colpisce alcune persone. Come potrei io, che senza dubbio sono dalla parte dei fortunati a cui non manca nulla, limitarmi a guardare o addirittura girare la testa dall’altra parte?».
C’è qualche incontro che l’ha particolarmente ispirata?
«Ricordo un episodio, un canto di Natale intonato dal mio gruppo scout, poco prima della Vigilia, nel reparto maschile dell’ospedale cantonale di Lucerna. C’era un anziano che non mi lasciava la mano mentre mi porgeva un mandarino con una candela su un ramo d’abete e io, che all’epoca avevo circa dodici anni, fissavo con crescente paura la mano vecchia e ossuta di quell’uomo sulla mia. Ma che cosa mi ha detto? Ero il suo angelo che gli toglieva ogni paura… Da allora ho provato una profonda empatia per le persone che vengono lasciate sole dalle loro famiglie, anche a Natale. E da allora ho anche capito che spesso basta poco per aiutare gli altri».
Lei si occupa di cultura, di lotta al razzismo, di donne e bambini in difficoltà. Perché questi temi le stanno particolarmente a cuore e cosa fa nello specifico?
«Il mio impegno culturale ha più a che fare con le mie radici familiari che con una conoscenza approfondita. Ho interiorizzato la frase dell’avanguardia russa dell’inizio del XX secolo, secondo cui la cultura è di tutti e deve quindi essere resa accessibile a tutti.
L’antirazzismo, invece, fa parte di quello che ho appreso dalla mia esperienza: mia madre non era cattolica e nemmeno protestante, una posizione del tutto anomala negli anni Cinquanta e Sessanta. In casa parlavamo anche inglese e i miei genitori erano molto cosmopoliti, un’altra caratteristica che in quel periodo non era comune a Lucerna. All’epoca agli italiani si gridava il termine dispregiativo “Tschingge” per strada; allo stesso tempo la Svizzera è stata risparmiata dalla Seconda Guerra Mondiale anche grazie al suo eccezionale esercito, alla strategia di dissuasione del “Réduit” e alla rettitudine degli svizzeri. Gli stranieri dovrebbero sentirsi felici di poter vivere in un Paese così privilegiato (che pure ha vietato il ricongiungimento familiare, in violazione del diritto internazionale)! C’era un termine per definire questo atteggiamento: sentirsi “migliori” degli altri».
I bambini sono un tema particolarmente importante per lei: come è nata la Fondazione Elternsein? Qual è il suo scopo e quali progetti sta portando avanti oggi?
«Ad oggi, il mio obiettivo con la Fondazione Elternsein e con la rivista per genitori “Fritz+Fränzi”, nonché con le nostre diverse offerte digitali, è quello di contribuire al successo della genitorialità, di sostenere gli educatori e rafforzare il triangolo genitore – alunno – insegnante.
Crediamo che questo lavoro possa anche sostenere il tessuto democratico della nostra società attraverso la catena di relazioni reciproche tra le generazioni. Finché i nostri lettori cresceranno come hanno fatto costantemente, fra l’altro in assoluta controtendenza, continueremo a puntare sulla carta stampata, in particolare sulla nostra rivista per genitori. Allo stesso tempo, di recente siamo riusciti ad ampliare notevolmente la nostra offerta audiovisiva e i nostri canali di social media. Tutti gli editori cartacei del mondo vi diranno che la digitalizzazione è una sfida importante e finanziariamente significativa».
Quali nuovi impulsi possono contribuire a ripensare la filantropia, soprattutto in relazione al tema dell’infanzia?
«Chi si impegna nella filantropia di solito sceglie una causa vicina ai propri interessi personali, e un numero sorprendente di fondazioni cita l’educazione nei propri scopi statutari. Se tutte fossero collegate in rete e collaborassero più intensamente, potrebbe nascere una vera e propria “force de frappe”. Pro Familia e altre istituzioni stanno dando un contributo in tal senso, anche se con finanziamenti federali minimi. Spesso mi chiedo se la persona in carica presso il Ministero dell’Interno sappia di essere anche il Ministro delle Politiche Familiari. Data l’importanza del compito, credo che sarebbe auspicabile avere un Ministero delle Politiche Familiari a sé stante».
Quale può essere l’apporto della filantropia nell’affrontare le sfide sociali e ambientali sul lungo termine?
«Presumo che in futuro le ragioni politiche e l’economia continueranno ad avere la precedenza sulle necessità sociali ed ecologiche. Non si ottengono voti con richieste che sembrano andare contro i bisogni della gente! In economia, sopravviverà solo chi saprà conquistare il mercato. La linea che separa l’essere socialmente ed ecologicamente intelligenti e giusti e la ricerca del profitto è terribilmente sottile! Oggi la filantropia riesce almeno a dare impulsi importanti ai politici e al mercato, come si può vedere ad esempio dal marchio di qualità ecologica».
Che ruolo ha la filantropia nel promuovere la giustizia sociale e la tutela dell’ambiente nella società?
«Ho l’impressione che la filantropia stia diventando un fattore sempre più importante nel tessuto sociale nel suo complesso. Vorrei citare come esempio il WWF, perché credo che abbia svolto un ruolo fondamentale nel radicare la questione della tutela ambientale nella mente di quasi tutti, il che ha portato al fatto che oggi nessun partito può permettersi di evitare le questioni “verdi”».
Quando ripensa ai suoi impegni filantropici, di cosa è particolarmente orgogliosa?
«Nel corso di quarant’anni di attività filantropica, sono stata impegnata in innumerevoli iniziative. Con l’associazione Openair Lengnau e “Rock gegen Hass”, alla fine degli anni Novanta ho cercato di far incontrare i giovani ebrei e musulmani attraverso la musica. Nella Fondazione Scout Svizzera (PBS), è stato importante per me fornire più campeggi per gli scout. Alla Fondazione contro il razzismo e l’antisemitismo (GRA) e alla Società svizzera per le minoranze (GMS), sognavo che un giorno le persone in questo Paese si sarebbero capite a vicenda attraverso le religioni e le culture. L’associazione Domicilio fornisce alloggi a persone in condizioni precarie.
Il Centro delle donne di Zurigo ha risvegliato la mia consapevolezza rispetto alle lotte portate avanti dalle donne, allora per la parità di diritti e ancora oggi per un giusto equilibrio tra lavoro e vita privata, è perché venga riconosciuta l’importanza della famiglia per la società nel suo complesso.
Per non parlare dei numerosi interventi culturali intrapresi a lungo termine a favore dello Schauspielhaus di Zurigo, del Kunst- und Kongresshaus di Lucerna e del Museo Haus Konstruktiv. E infine, ma non per questo meno importante, l’istituzione della Fondazione Elternsein, il cui impatto su genitori e insegnanti continua e addirittura cresce dopo ventidue anni.
Ma “orgogliosa” sono del mio personalissimo impegno a favore di persone e famiglie che ho potuto aiutare a uscire da una situazione di emergenza. Perché? Non si tratta solo di dare un sostegno finanziario, ma di un impegno che mi mette alla prova fisicamente e mentalmente, come persona nel suo complesso, per così dire. Niente nella vita mi è costato più energia, e sono state piccole vittorie rispetto alla mia vita comoda e agiata; di questo sì che sono orgogliosa».