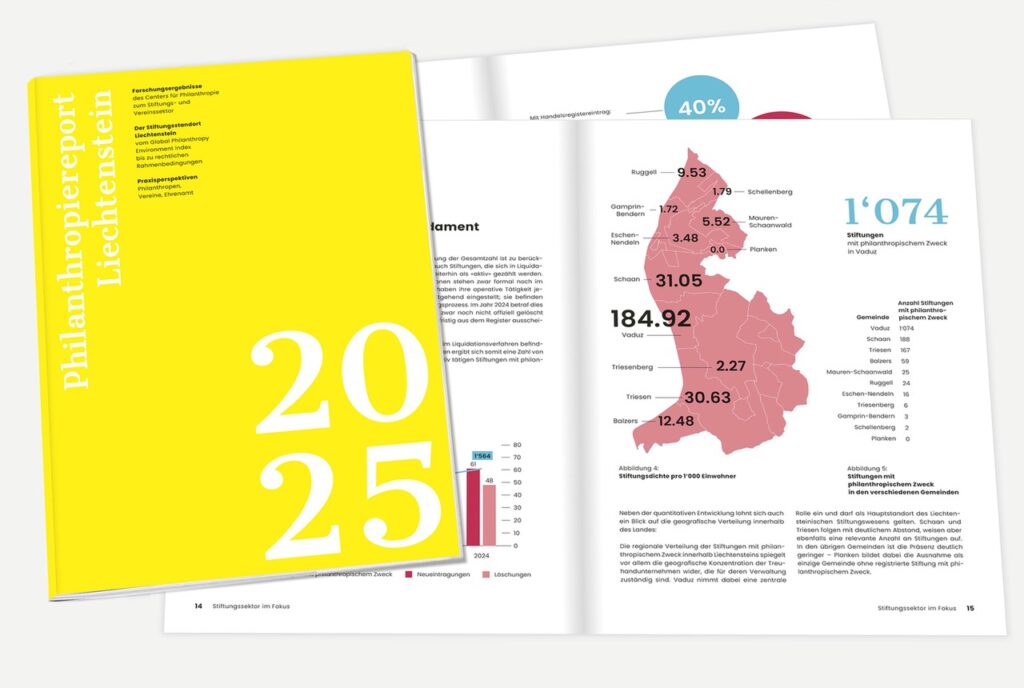Darren Walker, presidente della Ford Foundation, una delle più grandi fondazioni d’America, nel suo recente libro From Generosity to Justice, sostiene che in parecchie situazioni la filantropia emergenziale fa più male che bene. Quando si parla di mecenati l’istinto, la spontaneità non sono più richiesti?
«Al contrario: molti sondaggi e studi di settore indicano che il cuore, la passione per un tema e il credo religioso sono i principali fattori che spingono un mecenate a donare. La pandemia ci ha dimostrato che, oggi più che mai, il mondo ha bisogno di filantropi capaci di attivarsi senza esitazione quando si ha più bisogno di loro. Alcune grandi famiglie hanno risposto in ritardo ai bisogni scatenati dall’emergenza sanitaria, proprio perché già impegnate in attività di filantropia strategica. Io penso che occorra usare il buon senso: quando ci sono migliaia di persone che rischiano la vita, c’è bisogno di donatori che agiscano subito e con generosità. Per fortuna gran parte dei filantropi non ha esitato: in Italia per esempio, ricordo fra i molti: Diego Della Valle (5 milioni di euro per i familiari del personale sanitario che ha perso la vita a causa della pandemia), Giorgio Armani (1 milione e 250 mila euro agli ospedali Luigi Sacco, San Raffaele e Istituto dei Tumori di Milano, allo Spallanzani di Roma e a supporto dell’attività della Protezione Civile per l’emergenza Coronavirus), Diana Bracco (1 milione di euro per le strutture sanitarie lombarde), Donatella Versace, e sua figlia, Allegra Versace Beck (200mila euro al dipartimento di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano in supporto alla lotta contro il Coronavirus). In Svizzera, fra gli altri Roger Federer con la moglie Mirka (1 milione di franchi in favore delle famiglie in difficoltà), Sergio Ermotti (1 milione di franchi per i ticinesi in difficoltà) e potrei continuare a lungo».
Lei non crede alla filantropia strategica?
«Io sono una fautrice della filantropia strategica. Tuttavia, bisogna tenere a mente che la filantropia è tanto varia quanto le personalità dei mecenati, ed è condizionata dai contesti socio-culturali dei Paesi di provenienza, dalle leggi, dalle relazioni fra Stato, mercato e società civile. In questa immensa varietà, vanno lette anche le diverse forme di filantropia. Perché non sempre la filantropia strategica, o quella sistemica, sono le risposte giuste. Dipende dall’ordine di grandezza degli investimenti filantropici, dalla situazione contingente dei mecenati e degli individui che chiedono una donazione, delle organizzazioni coinvolte. Ogni situazione è unica e irripetibile, e richiede un intervento che va calibrato ad hoc e che deve tener conto non solo delle dinamiche di contesto, ma di un bisogno fondamentale: la libertà del filantropo nelle sue scelte di donazione! La filantropia non è un diritto civile, è una certificazione di cittadinanza».
Quali sono i vantaggi della filantropia sistemica?
«La filantropia sistemica non si concentra tanto sui sintomi di un problema, quanto sulle sue cause. Per farlo in modo efficiente, applica un approccio a lungo termine e multidisciplinare alla risoluzione dei problemi e coinvolge tutti gli stakeholder interessati nell’analisi, nella definizione degli obiettivi e nella risoluzione dei problemi. La filantropia può fornire capitale di rischio, competenze e risorse umane per questo scopo. Anziché risolvere i singoli problemi, le aree problematiche vengono analizzate in modo olistico e viene trovata una soluzione insieme a tutte le parti interessate. Quindi questo approccio si rivela più sostenibile sul lungo periodo. Un esempio è il lavoro di Hansjörg Wyss, nativo di Berna ma naturalizzato statunitense, che una volta ceduta la sua impresa attiva nel settore delle tecnologie mediche, si è dedicato completamente a un progetto di filantropia ambientale a tutela della protezione della biodiversità sul territorio degli Stati Uniti occidentali, mettendo in gioco le sue abilità manageriali e seguendo un approccio sistemico. Lavorando di concerto con partner locali, in cinque anni Wyss ha protetto 8 milioni di ettari di terreno e investito oltre 1 miliardo e mezzo di dollari. (cfr. https://www.tio.ch/dal-mondo/economia/1414696/buffett-i-gates-soros-ecco-i-maggiori-filantropi-a-stelle-e-strisce)».
Torniamo alla pandemia, che cosa ne dice del problema del cosiddetto “crowding out” (o spiazzamento) e dei problemi legati a questo fenomeno?
«Vorrei ricordare quanto l’economista Stefano Zamagni ha dichiarato in un’intervista: “Quando si segue la logica emergenziale succede che, una volta scoppiata l’emergenza, è ovvio che tutte le donazioni vengano incanalate in quella data direzione. Questo provoca il fenomeno del crowding out, dello spiazzamento, cioè i donatori che fino ad allora donavano, ad esempio, a una cooperativa sociale, a un’associazione di volontariato o a una ONG, a un certo punto indirizzano le donazioni verso le organizzazioni del settore più colpito dell’emergenza, a scapito degli altri. E questo è pericolosissimo, perché per chiudere un buco ne apriamo altri. Dobbiamo essere avvertiti del fatto che, quando tra qualche mese la pandemia sarà finita, ci troveremo con un mondo del Terzo Settore indebolito e avvilito” (cfr. Stefano Zamagni, La filantropia deve uscire da una logica emergenziale e adottare un approccio strategico”, in “Fondazioni di impresa nell’era del Covid-19”, promosso da Fondazione Bracco, https://www.secondowelfare.it). Per rispondere alla domanda, sicuramente esiste un rischio di “crowding out“, ma poiché fondazioni, filantropi e specialisti ne hanno consapevolezza, spetta a loro, alla scena filantropica, creare dei tavoli di lavoro per affrontare il problema di concerto. D’altra parte, mi sembra che di fronte a una tragedia delle dimensioni del Covid-19 il mondo filantropico abbia ben reagito donando a supporto di quanti ne avevano bisogno. Aspettarsi che le fondazioni agissero prima dello scoppio della pandemia, non tiene conto né dell’effetto sorpresa e delle dimensioni dei problemi del Covid-19 (nessuno si aspettava una catastrofe umanitaria di queste dimensioni), né delle abitudini e dei ritmi del settore filantropico».
Tocchiamo la cultura, un settore fra i più colpiti: quali misure sono state adottate per sostenere gli operatori culturali a livello europeo?
«In Europa sono state lanciate diverse iniziative a sostegno degli operatori culturali: La Commissione europea sta coordinando la risposta congiunta alla crisi indotta dal Covid-19. Per garantire che i fondi dell’UE raggiungano le persone colpite, gli eurodeputati hanno chiesto alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di aumentare lo strumento di garanzia per il settore culturale e creativo (programma “Europa creativa”, https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_de). Ciò significa che il Fondo europeo per gli investimenti fungerebbe da garante nei confronti delle banche, ecc. che, ad esempio, offrono prestiti al settore culturale e creativo. L’obiettivo è quello di aumentare la performance finanziaria e la competitività (https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/cross-sector/guarantee-facility_de). La Commissione ha inoltre sostenuto la creazione della nuova piattaforma “Creatives Unite”, che offre al settore culturale e creativo uno spazio di scambio di informazioni. L’iniziativa è guidata, tra gli altri, dal Goethe-Institut e dall’European Creative Hubs Network. “Creatives Unite” raccoglie in un’unica piattaforma tutte le iniziative e le informazioni sul settore culturale e creativo professionale volte ad attenuare gli effetti del Coronavirus. Anche gli attori al di fuori dell’UE possono utilizzare questo progetto. https://creativesunite.eu/Europa. Per quanto riguarda la Svizzera rimando all’interessante intervista con il Direttore di Pro Helvetia che in questa circostanza, una volta in più, ha fatto un lavoro eccellente. Le misure statali non sono tuttavia sufficienti a rispondere tutte le questioni impellenti della cultura e alle perdite causate dalla pandemia».
Se le misure di sostegno statale non sono sufficienti, come possono essere d’aiuto le fondazioni?
«Le fondazioni non possono sostituire lo Stato, ma possono agire come motori di innovazione complementari. Nel breve periodo, le fondazioni possono aiutare fornendo risorse finanziarie in modo semplificato e facilitando l’accesso a nuovi fondi. Possono anche favorire la creazione di nuovi formati culturali. Vedo anche il loro contributo essenziale nel supporto alle forme di auto-aiuto: l’istituzione di corsi e altre possibilità di formazione che permettono ai vari attori di acquisire know-how specifico. A medio termine trovo interessanti le proposte del rapporto di recente pubblicazione Reimagining European Philanthropy Report (https://www.mckinsey.com/industries/social-sector/our-insights/reimagining-european-philanthropy#), in particolare su tre dimensioni:
- Le fondazioni filantropiche dovrebbero ripensare il loro modo di lavorare: le fondazioni hanno bisogno di un maggior grado di flessibilità e velocità per rispondere ai cambiamenti in corso e alle sfide nelle loro aree programmatiche. La nuova situazione richiede maggiore trasparenza sul contenuto dei finanziamenti, processi più rapidi, decisioni più celeri e sostanziali semplificazioni per i richiedenti.
- In quanto attori chiave del finanziamento nel settore culturale, le fondazioni dovrebbero condividere e aggiornare know-how e buone pratiche più ancora di quanto non si faccia oggi. Un risultato che si ottiene fra l‘altro rafforzando la cooperazione nelle reti nazionali e internazionali.
- A lungo termine, credo che sia utile affrontare alla radice i problemi del finanziamento privato della cultura. Utilizzando le risorse messe a disposizione dalla cosiddetta “filantropia sistemica” di cui abbiamo già parlato, fermo restando che i finanziamenti privati e l’apporto progettuale di filantropi e fondazioni siano rispettosi di tutte le regole che animano il confronto democratico».
Quali sono i trend emergenti nella filantropia?
«Istruzione e formazione, salute, affari sociali e cultura sono da anni le cinque aree di progetto più importanti per i filantropi di tutto il mondo. Le attività nate per combattere il Covid-19 e per affrontare le conseguenze della pandemia, a mio parere, avranno un impatto duraturo sulla scena filantropica. Data la velocità con cui il contesto sta evolvendo, è difficile prevedere cosa cambierà in dettaglio nel panorama della filantropia internazionale, ma mi sento di affermare che la pandemia stia già modificando sostanzialmente il modo di lavorare del settore (penso per esempio all’incredibile sviluppo della digitalizzazione). Sono comunque fiduciosa e ottimista: le dure esperienze dei mesi passati possono produrre una vera e propria rivoluzione positiva del sistema filantropico».