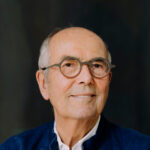«ChatGPT è solo una delle molte tecnologie attualmente presenti sul mercato e che sicuramente ha avuto un grande risonanza mediatica per la modalità conversazionale del suo approccio. Oltre agli strumenti di AI generativa, vediamo tuttavia il proliferare di vari progetti pilota legati all’apprendimento automatico, alla visione artificiale, ai sistemi di raccomandazione e all’analisi predittiva. Questi vengono utilizzate per ottimizzare i processi aziendali, personalizzare l’esperienza degli utenti, aumentare l’affidabilità delle decisioni strategiche e creare soluzioni innovative per risolvere sfide complesse».
La Fondazione Agire ha lo scopo di promuovere e diffondere l’innovazione e lo sviluppo tecnologico delle attività economiche esistenti o delle nuove startup, mirando a incrementare la competitività regionale e a creare posti di lavoro altamente qualificati: evidente come l’AI sia ormai «chiaramente uno dei temi centrali per la nostra fondazione e le aziende», prosegue. «Il nostro approccio è principalmente guidato dalla curiosità e dall’innovazione, ma cerchiamo di avere aprirci alla comprensione delle implicazioni etiche e sociali dell’AI. Crediamo fortemente nel suo potenziale per migliorare la qualità della vita e i processi lavorativi, ma siamo anche consapevoli delle sue sfide, come la sicurezza dei dati e le perturbazioni del mercato del lavoro».
Quando chiediamo a Barni in quali settori e con che scopi viene usata al momento l’intelligenza artificiale in Ticino, porta numerosi esempi. Viene impiegata, sostanzialmente, nel mondo bancario per l’analisi del rischio, la prevenzione delle frodi e l’automazione del servizio clienti; in quello aziendale per ottimizzare la catena di approvvigionamento, migliorare il servizio clienti e personalizzare le offerte; in quello medico per aiutare nella diagnosi, personalizzare i trattamenti e analizzare grandi quantità di dati sanitari; in quello industriale per aumentare l’efficienza delle linee di produzione, prevedere la manutenzione e ottimizzare la gestione energetica; in quello educativo per personalizzare l’apprendimento, automatizzare l’amministrazione e analizzare le prestazioni degli studenti. Per ogni ramo, servono inevitabilmente competenze nuove e crescenti.
Come stanno implementando le competenze le aziende ticinesi, grazie a esperti verticalizzati oppure formando figure interne, che aggiungeranno le applicazioni relative all’AI ai loro compiti attuali? Prima di poter rispondere a questa domanda, Barni vuole partire da una premessa, ovvero che prima di agire sull’intelligenza artificiale, ogni realtà deve lavorare su un altro processo: «Molte delle aziende con cui abbiamo a che fare oggi sono immerse in un profondo processo di digitalizzazione, che rappresenta il passo fondamentale per abilitare l’implementazione di future soluzioni di intelligenza artificiale (AI). Questo cammino verso la digitalizzazione è la via che rende possibile modernizzare le infrastrutture, introdurre l’ottimizzazione aziendale e, in ultima analisi, sfruttare le emozionanti opportunità legate all’AI. La digitalizzazione è spesso una necessità preliminare all’adozione dell’AI». Dunque, «una volta impostate le basi digitali che permettono quindi di avere a disposizione i dati tramite i quali gli algoritmi di AI lavorano, le aziende iniziano a mettere in moto iniziative puntuali nel campo dell’AI, in cui vengono adottate applicazioni di intelligenza artificiale specifiche a supporto di particolari aree o funzioni aziendali».
La situazione è variegata: «Alcune aziende stanno comprendendo l’importanza e la necessità di avere dei ruoli specifici dedicati a queste attività. E tuttavia, molto dipendente dalla tipologia dell’azienda e dalla quantità di risorse che essa può mettere in campo», sottolinea Barni, che precisa con orgoglio come «a livello istituzionale c’è sicuramente un certo movimento nell’andare a colmare le necessità formative in tale ambito. La SUPSI offre varie opportunità di formazione specialistica, come il Master of Science in Engineering in Data Science e il Bachelor of Science in Data Science e Intelligenza Artificiale, mentre all’USI c’è il primo Master in Intelligenza Artificiale, un programma interdisciplinare che preparerà gli studenti a risolvere problemi complessi in molti campi applicativi dell’intelligenza artificiale. L’ATED infine collabora con Formati academy per offrire corsi professionalizzanti in Cyber Security Specialist e Digital collaboration Specialist».
Al di là delle possibilità che essa spalancherà, ci si chiede quali saranno le eventuali ripercussioni a livello di posti di lavoro. «L’intelligenza artificiale è vista infatti da molti come un’arma a doppio taglio: da un lato, offre il potenziale per portare benefici significativi, migliorando l’efficienza, ottimizzando i processi e creando nuove opportunità di lavoro in settori emergenti. Dall’altro lato, però, esiste la preoccupazione che possa sostituire i lavoratori in determinati compiti, specialmente quelli ripetitivi o di routine, il che potrebbe portare alla perdita di posti di lavoro», conferma l’esperto, che vede «benefici vasti e multidimensionali. Ad esempio, l’AI può assistere nella sanità, migliorando la diagnosi e la personalizzazione delle cure; nel settore manifatturiero, può aumentare l’efficienza e ridurre gli sprechi; nel settore dei servizi, può migliorare l’esperienza del cliente attraverso servizi personalizzati. Inoltre, può contribuire a risolvere problemi complessi, come il cambiamento climatico e la gestione delle risorse, attraverso analisi e modellazioni avanzate».
Ma d’altro canto, Andrea Barni cita un report di Goldman Sachs secondo cui potrebbe, nei prossimi anni, sostituire l’equivalente di 300 milioni di lavori a tempo pieno e influenzare circa un quarto dei compiti lavorativi negli Stati Uniti e in Europa. Vuole però evidenziare ancora un altro lato della medaglia: «Tuttavia, questo cambiamento è strettamente collegato alla creazione di nuovi lavori. È evidente come, per poter integrare e gestire la nuova complessità dei sistemi e degli strumenti di AI, sia necessaria l’integrazione di una nuova classe di lavoratori con competenze digitali aggiornate alle sfide attuali, ed un’attività di formazione continua per le figure già esistenti. Personalmente sono convinto che, come è già accaduto in altri periodi storici, saremo in grado di cogliere le opportunità ed adattare il contesto socio-economico all’ingresso di queste nuove dirompenti tecnologie, evolvendo il modello lavorativo e di consumo». Una sfida cruciale, per il Ticino e non solo, dei prossimi decenni.