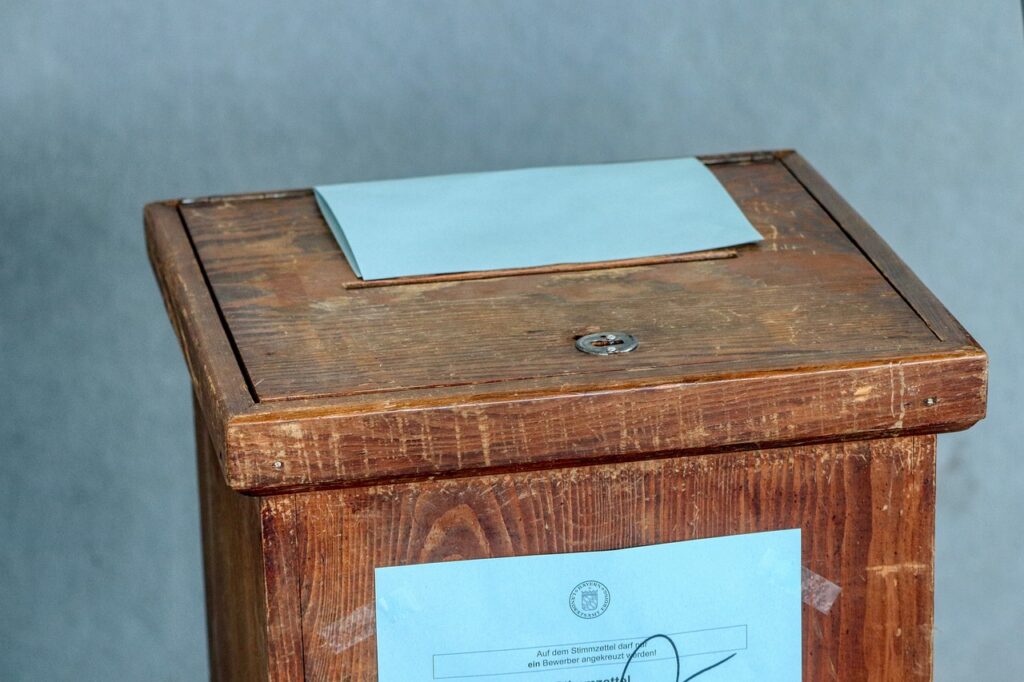La nascita delle Nazioni Unite e di un’Europa unita, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e il “Trentennio glorioso” di boom economico che hanno contraddistinto la ricostruzione dopo il secondo conflitto mondiale non dovevano forse decretare – come profetizzava ingenuamente Francis Fukujama – “La fine della storia”, ovvero l’avvento di una nuova e ormai definitiva Età dell’Oro?
Il risveglio dalle illusioni (quelle del Sessantotto ma anche quelle suscitate dalla fine della Guerra fredda e dalla caduta del muro di Berlino) è brutale. E a causa di un abbaglio ci ritroviamo in larga parte sprovvisti di strumenti validi per rispondere ad una situazione socio-politica che sembra riportarci indietro di cent’anni. Quale abbaglio? Semplicemente quello di aver creduto, sulla base dell’euforia provocata da una crescita economica e da una rivoluzione tecnologica senza precedenti, che quei trent’anni fossero l’inizio di un’era nuova e non semplicemente un caso forse unico nella storia, prodotto da una serie felice di cause concomitanti e da circostanze straordinarie e irripetibili. Dopo la brutalità del risveglio, con meno illusioni e più pragmatismo i tempi chiedono di por mano rapidamente a soluzioni sociopolitiche che non si limitino ad intervenire sui sintomi ma affrontino le cause. Semplificando all’osso (visto che stiamo parlando di cose complesse) il nocciolo della questione è la rottura del contratto sociale su cui poggiano le moderne democrazie e come ricucirlo o ripensarlo. Per intenderci, non intervenire sui sintomi significa ad esempio che per ripristinare la legittimazione perduta dei governanti e degli apparati che li sorreggono non basta fare una coalizione contro. Contro lo spauracchio dei populismi di destra e di sinistra. Faccio un esempio. Se all’inizio degli Anni Novanta gli antiglobalisti erano di sinistra e oggi di destra; se i lavoratori precari e meno abbienti di ieri votavano socialista o comunista e oggi votano e scendono in piazza con i movimenti populisti e sovranisti, il problema non è la destra ma gli effetti perversi di un certo tipo di globalizzazione che accrescono incertezza e timori. O prendiamo la questione dei Gilet gialli francesi. Se il problema della Francia fosse Marine Le Pen, la coalizione antifrontista di Macron per impedirle di andare al potere sarebbe bastata a ripristinare un clima di fiducia presso la maggioranza dei francesi. I Gilet gialli indicano invece semplicemente – ed è emblematico che ciò accada nella patria della Rivoluzione francese che ha dato la stura alla democrazia moderna – che il problema è a monte. Un problema che riguarda le basi stesse su cui poggia il Contratto sociale moderno ormai boccheggiante rispetto ai problemi posti dalla globalizzazione socio-economica e dalla rivoluzione tecnologica in corso. Sintetizzando al massimo si potrebbe dire che il contratto sociale moderno poggia su uno scambio conveniente fra il Cittadino e lo Stato: il primo rinuncia ad una porzione della propria libertà e il secondo gli garantisce in cambio condizioni quadro di giustizia individuale e socio-economica. Questo contratto si sviluppa in un contesto di cittadinanza nazionale. In un contesto di globalizzazione a tutti i livelli, lo Stato nazionale non appare manifestamente più in grado di garantire in proprio al cittadino l’insieme delle prestazioni in termini di diritti individuali e socio-economici su cui poggiava il contratto. Un problema esacerbato dalle nuove migrazioni su scala globale che – in assenza di adeguate regolamentazioni – mettono de facto in concorrenza diritti civili (universali) e diritti garantiti al cittadino in forza dell’appartenenza ad una determinata nazione e degli obblighi che egli si assume. Paradossalmente, l’epoca tumultuosa presente rappresenta un’opportunità per ripensare la cittadinanza e il contratto sociale adeguandoli alle nuove condizioni quadro. Per farlo occorre ovviamente collocarsi in un’ottica realistica e non idealistica (che tanti danni ha fatto durante gli ultimi cent’anni). Fatico a dar credito a chi – sulla base di proclami ideologici passatisti e semplicistici di destra o di sinistra – propone di risolvere il problema eliminando la globalizzazione e il capitalismo mondiale oppure tornando all’età delle Nazioni. Più pragmaticamente sono convinto che è tempo di dotarsi di strumenti politico-istituzionali che non temano la complessità ma siano in grado di gestirla. Poiché come la natura è complessa così è la scienza che la studia seriamente e così non può che essere la convivenza umana. La miriade di lingue, culture e popolazioni diverse che la globalizzazione pone in contatto quotidiano secondo tempi e modalità che non hanno precedenti nella storia rende necessario adottare strutture di governo e di partecipazione politica all’altezza delle nuove condizioni. Non è pensabile in un simile mondo plurimorfe e frammentato restare legati a modelli come quello – denunciato da Tocqueville già duecento anni fa – della “dittatura della maggioranza”. Quali maggioranze, d’altronde? Visto che a governare oggi sono spesso formazioni politiche che non superano il 25% e/o alleanze di facciata raccogliticce ed effimere che prendono in prestito il nome da cespugli, piante e astri del cielo o da slogan come “En marche”. È pur vero che negli Stati Uniti o in Gran Bretagna è ancora in auge un’alternanza fra due partiti storici. Ma i segni di crisi profonda sono sotto gli occhi di tutti: lo scontro fra democratici e repubblicani negli USA di Trump è violento e l’instabilità è fortissima e il Regno Unito era totalmente impreparato ad affrontare Brexit. Forse qualche spunto utile per il superamento dell’attuale crisi della legittimazione politica e per una riforma del contratto sociale nell’era della globalizzazione, potrebbe venire dal modo con cui la Svizzera moderna ha progressivamente integrato e federato le diverse componenti del Paese nelle strutture di Governo ed ha esteso la partecipazione popolare alla presa di decisioni. Benché il solo accenno alla democrazia diretta faccia rizzare i capelli in testa a chi maledice Brexit come la madre di tutti i disordini, sta di fatto che la democrazia partecipativa è un potente strumento di formazione politica e di responsabilizzazione dei cittadini. Tutto sommato, per rimettere in discussione una decisione popolare… basta rivotare. Sono convinto che in una società complessa e globale, solo scommettendo sulla responsabilizzazione tramite una partecipazione attiva dei cittadini alla gestione della cosa pubblica si possa ritrovare la legittimazione politica perduta.