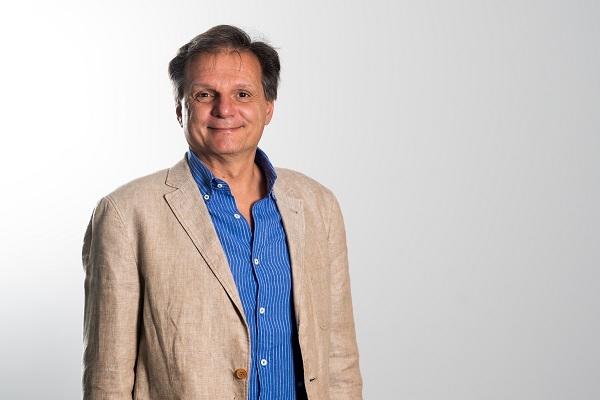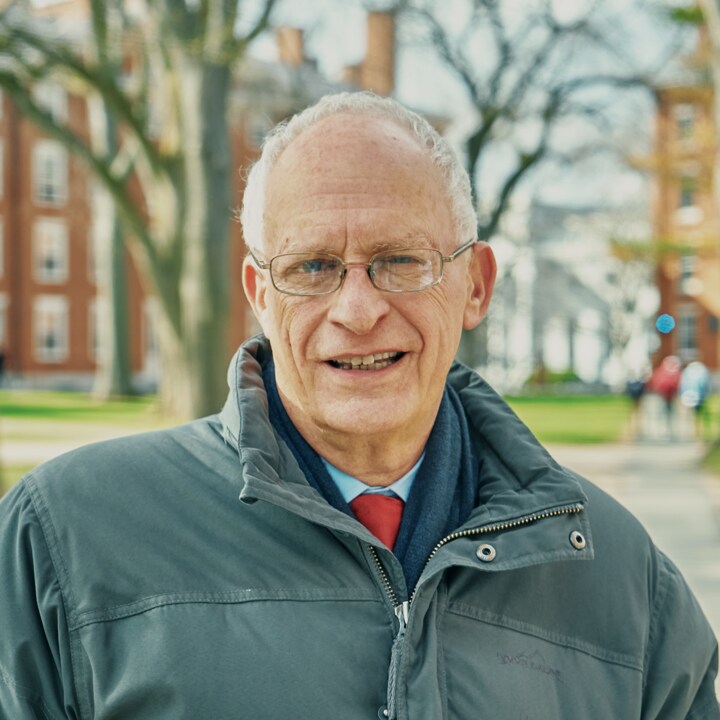La pratica del telelavoro, o smart working che dir si voglia – ammesso e non concesso che siano la stessa cosa -, ha subito un’espansione massiccia. A fronte degli indubbi vantaggi e del gradimento testimoniato dai lavoratori (stando a un sondaggio commissionato dal sindacato Syndicom, durante il lockdown della scorsa primavera l’80% degli intervistati si è detta molto o piuttosto soddisfatta del lavoro a domicilio), emergono diversi interrogativi, cui prima o poi bisognerà dare una risposta.
Da un punto di vista economico infatti rischiano di essere numerosi i settori che rischiano di essere penalizzati, in particolare quelli che vivono dei consumi dei lavoratori durante una normale giornata lavorativa (ristoranti, bar, piccoli negozi ecc.), mentre da quello sociale bisognerà analizzare l’impatto che avrà una diversa vita comunitaria e un’altra gestione del tempo, con una maggiore promiscuità tra quello lavorativo e quello libero. Senza dimenticare la politica, che sarà chiamata a gestire l’evoluzione dall’attuale modello lavorativo (anche economico?) a un altro.
Piccola premessa, nella maggior parte dei casi imprese e pubblica amministrazione hanno fatto ricorso al telelavoro, non allo smart working (che letteralmente significa lavoro intelligente, non da casa). La questione non ha solo rilevanza lessicale, poiché fraintendendo il significato delle parole si rischia di non afferrare completamente il cambiamento che esse suggeriscono. In estrema sintesi, il telelavoro è solo, si fa per dire, un diverso modo di intendere lo svolgimento della prestazione professionale, la cui natura tuttavia rimane sostanzialmente invariata e si svolge come in azienda. È una specie di delocalizzazione, o meglio domiciliazione del lavoro, un fenomeno già in crescita prima del Covid 19 e che adesso ha subito un’accelerazione e un’impennata.
Lo smart working è invece altra cosa, e presuppone una disciplina di produzione agile, che permette al lavoratore di organizzare le proprie mansioni in forma sostanzialmente indipendente, in cui la produzione è organizzata per fasi, cicli e obiettivi e i vincoli (i vincoli, non le regole, sia ben chiaro), in particolare per presenza e orario, sono molto più labili. Si passa dall’ufficio di una volta con le foto di famiglia sulla scrivania a tavoli sotto gli alberi con i laptop, in cui il lavoro è basato sulla contaminazione e la condivisione delle conoscenze in una comunità che è sì virtuale ma allo stesso tempo anche reale. Non per nulla a inizio secolo a San Francisco e nella Sylicon Valley, nel tempo e là dove il fenomeno fece udire i suoi primi vagiti, fu constatato un aumento non solo della produttività, ma anche della creatività. Filosofeggiando un po’, stiamo forse assistendo ai primi passi di un cambiamento della nozione stessa di lavoro, di conseguenza al declino della figura su cui si è retto il nostro modello economico negli ultimi secoli, l’homo faber.
Lungi dall’esserci spinti tanto in là, quello che abbiamo vissuto la scorsa primavera durante il lockdown e stiamo vivendo in parte anche adesso è dunque una forma di telelavoro. Per di più dettata dall’emergenza, dunque non pianificata e, in diversi casi, poco organizzata. Se da un lato questo ha comunque permesso di continuare a portare avanti le attività, ha fatto anche emergere alcune criticità.
L’Università Bocconi ha svolto diversi studi su telelavoro e smart working: nel pre-pandemia erano stati registrati effetti positivi su produttività, benessere del lavoratore e bilanciamento di vita, effetti che tuttavia sono scemati, fin quasi ad annullarsi, nel post, con sovraccarichi di lavoro, perdita di socializzazione e capacità relazionali, aumento dello stress e conseguente calo della produttività. Più che lavoratori smart, dunque, i dipendenti sono diventati cottimisti con scarso entusiasmo e ancor meno idee.
Un’evoluzione tuttavia che gli studiosi fanno risalire più all’improvvisazione senza protocolli e prassi che al telelavoro in senso stretto. Da questo punto di vista prendere l’esempio del lockdown come forma lavorativa smart cui guardare è di conseguenza del tutto sbagliato.
Eppure secondo l’Ufficio federale di Statistica la percentuale dei dipendenti svizzeri che lavorano da casa è raddoppiata dal 25 al 50% dall’inizio della pandemia, una curva destinata a continuare, anche se forse non con la stessa intensità, pure in futuro.
Una prospettiva che solleva questioni pratiche e giuridiche, ché in Svizzera non esiste il diritto al lavoro a domicilio, per cui – potrà anche sembrare paradossale – ma chi lavora da casa senza il consenso del datore di lavoro rischia sanzioni. Addirittura stando alle norme in vigore anche durante una pandemia i membri di un gruppo a rischio possono essere obbligati a essere presenti al lavoro, purché il datore di lavoro adempia al suo dovere di diligenza e protegga adeguatamente i dipendenti.
Allo stesso tempo non esiste però alcun obbligo di telelavoro, per cui in teoria anche durante una pandemia ci si potrebbe rifiutare di lavorare da casa. In teoria, appunto, ché un dipendente sottostà comunque anche al “dovere di lealtà” verso chi gli versa lo stipendio, per cui la questione è dubbia. Senza dimenticare che il licenziamento è comunque sempre dietro l’angolo.
È invece indiscutibile che il diritto del lavoro (leggi, ordinanze e contratti individuali e collettivi) si applichi anche al lavoro a domicilio, per cui, ad esempio, il diritto alle pause rimane valido tanto quanto le restrizioni sul lavoro notturno e domenicale.
Malgrado ciò i sindacati chiedono regole più chiare. Punti dolenti, secondo l’Unione Sindacale Svizzera, sono la protezione della salute dei lavoratori, che rischiano stress e workalcholism (la dipendenza dal lavoro), e i costi del materiale d’ufficio, per cui chiede che nei contratti sia specificato che l’azienda mette a disposizione degli spazi lavorativi e che lo scambio e i contatti sociali siano garantiti. Anche orari e raggiungibilità dovrebbero essere regolamentati: sembra incredibile, ma in pochi mesi siamo passati dalla necessità di riconoscere il “diritto alla connessione” a quella di introdurre il “diritto alla disconnessione”. Potere della pandemia.
Da parte sua Travail.Suisse teme che alcune aziende considerino l’home office come un programma di risparmio, per cui chiede indennizzi e che gli eventuali risparmi siano equamente ripartiti tra le parti.
Di tutt’altro avviso le organizzazioni padronali. Ad esempio l’Unione svizzera degli imprenditori ha recentemente pubblicato delle linee guida per i suoi associati, in cui si stabilisce che, salvo rare eccezioni e solo dietro consegna delle relative ricevute, tutti i costi per il telelavoro sono a carico dei dipendenti.
Anche se la letteratura manageriale propone una visione win-win per lavoratori e per imprese ed enfatizza alcuni indubbi vantaggi competitivi, è dunque probabile che a dirimere questa e altre questioni sarà chiamata la politica, se non addirittura, come recentemente accaduto, i tribunali.
Economisti, sindacalisti e imprenditori sono invece d’accordo su una cosa: il cambiamento non sarà indolore. Ad esempio il rapporto del WEF citato in apertura afferma che entro il 2025 verranno persi 85 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo. A fronte di 97 milioni di posti creati, è vero; tuttavia la sostituzione non sarà né potrà essere automatica: c’è chi si adatterà, certo, ma c’è anche chi soccomberà.
La posta in gioco è dunque alta; in particolare bisognerà fare attenzione a non confondere l’urgente con l’importante, il vantaggio immediato con quello a lungo termine. In ultima analisi, il vivere con il sopravvivere.
Consigli: sicurezza informatica e smart working
La digitalizzazione del mondo del lavoro in ogni caso non si arresterà. Per questo diverrà indispensabile adottare accresciuti protocolli di sicurezza informatici. Fisica anzitutto, come ci ha spiegato Paolo “Il disinformatico” Attivissimo. Non tanto per gli uomini ma per le macchine, che al domicilio privato si trovano esposte molto più che in ufficio a possibili danni, da parte ad esempio di bambini o animali. Non per nulla la casa è, stando alle statistiche della SUVA, il luogo principale dove gli essere umani si infortunano; volete che non lo sia anche per i PC?
La connessione dal domicilio all’azienda invece non pone soverchi problemi: i rischi di essere infettati da un virus o di subire un’intrusione da parte di malintenzionati possono infatti essere evitati con normali procedure indipendentemente dal luogo in cui si lavora. Purché naturalmente si usi il computer aziendale e non quello privato (dunque le due reti siano nettamente divise), ché altrimenti lo cose cambiano, e di molto, tanto che la sicurezza da intrusioni e infezioni da virus non può più essere garantita: il computer privato del dipendente, usato anche per le attività di tutti i giorni (social, videogiochi, internet, chat ecc.), può infatti essere un perfetto cavallo di Troia per entrare nella rete aziendale.
Diverso il caso dell’interdizione del servizio (in gergo DDoS), ossia un attacco in cui si fanno esaurire deliberatamente le risorse di un sistema o un sito web fino a renderlo non più in grado di erogare il servizio proposto. Lo scopo è ovviamente farsi pagare per ripristinarne la piena funzionalità. Un ricatto informatico, in estrema sintesi, relativamente più facile da effettuarsi su una linea casalinga che su quella di un ufficio.
A tutto questo si aggiunge che l’isolamento dal luogo di lavoro, venendo appunto a mancare il contatto costante con i colleghi e quindi quelle piccole, automatiche e preziosissime verifiche interne che si svolgono spontaneamente tra una scrivania e l’altra o in pausa caffè, può rendere più facile il lavoro ai truffatori informatici. La cronaca di questi mesi ne è un esempio lampante.
Per questo Attivissimo consiglia di adeguare la formazione dei dipendenti: non solo tecnica, ma anche informazione sui pericoli della rete, dove abbondano truffatori e malintenzionati di ogni taglia e specie. Un giretto sulla pagina di Melani, il Centro Nazionale per la Cybersicurezza, in questo senso può essere molto istruttivo.
Scopri anche come lo smart working sta cambiando il settore bancario.