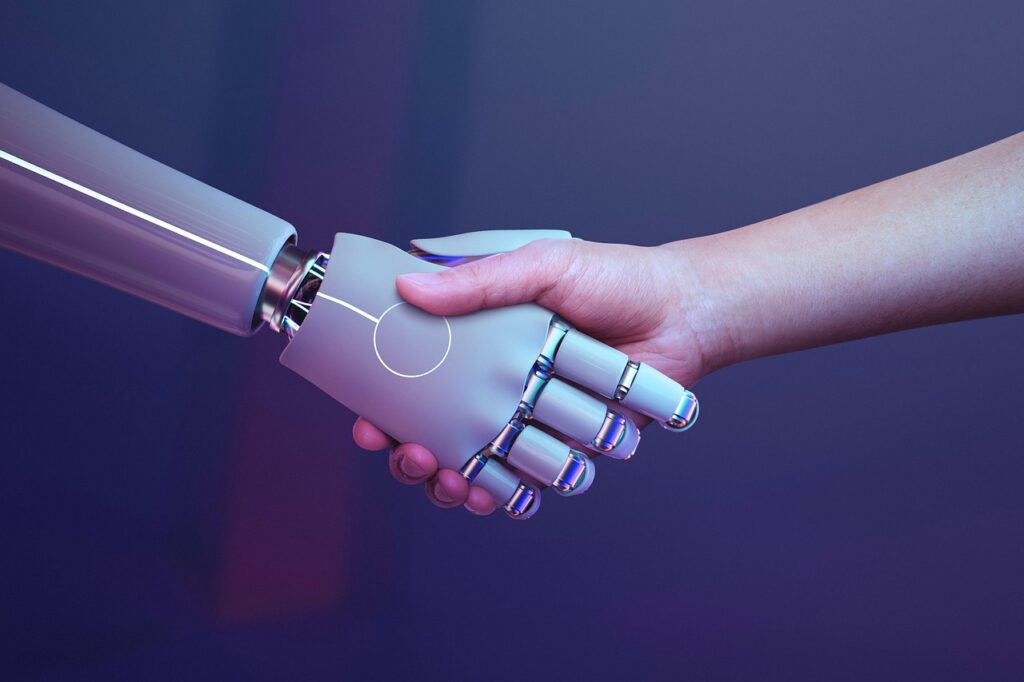Primo approfondito servizio di rendicontazione sulle buone pratiche e iniziative a favore della sostenibilità nella gestione dei mandati di SUPSI, il rapporto di sostenibilità presentato il 16 settembre alla stampa è un importante strumento di continua analisi per guidare la SUPSI nel suo lavoro.
Che ruolo hanno le università nella transizione verso una società più sostenibile?
F.C.: «La sostenibilità deve essere un patrimonio comune del modo di pensare delle persone che saranno poi i futuri cittadini. Le università sono un elemento chiave nella transizione verso una società più sostenibile, poiché possono aiutare a identificare le strade da percorrere per favorire la transizione. Le scuole universitarie professionali come la SUPSI, con la loro ricerca applicata e operativa, hanno un ruolo essenziale. Anche tutte le nostre attività di formazione giocano un ruolo chiave nell’aiutare la transizione o, viceversa, nel bloccarla. E non dimentichiamo il ruolo di esempio nella gestione della nostra stessa istituzione: siamo un punto di riferimento per gli altri attori del territorio, pubblici e privati».
C.B. «Un concetto che mi piace sottolineare legato alle università e alla sostenibilità è che all’interno delle università si può ricreare una sorta di “laboratorio vivente” in cui abitano persone, studenti, docenti, collaboratori e attori esterni, dove poter esercitare comportamenti virtuosi. Tutto ciò mettendo in atto atteggiamenti sostenibili a livello ambientale, come la mobilità casa-lavoro con mezzi pubblici o in bicicletta, la gestione attenta dei rifiuti, l’offerta di alimenti più sani e sostenibili da parte delle mense, l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, ma anche aspetti di sostenibilità sociale, come la parità all’interno dell’istituzione e tutti i principi legati all’inclusione. Si tratta di comportamenti virtuosi che, studiati e sperimentati dagli studenti in seno all’università, di riflesso poi saranno trasferiti alla società esterna».
Come nasce la necessità di realizzare un rapporto di sostenibilità, sempre più diffuso tra aziende e istituzioni?
C.B. «Sin dagli esordi, il gruppo di lavoro sostenibilità SUPSI ha discusso su quali fossero gli ambiti, i temi principali e gli indicatori da tenere in considerazione per la redazione del nostro rapporto di sostenibilità. Non è banale selezionare i più indicati. Ad esempio io ho da poco concluso presso SUPSI il CAS in Responsabilità sociale delle imprese, grazie al quale ho appreso, fra i diversi temi trattati nel corso, anche a realizzare un rapporto di sostenibilità per le aziende. È di sicuro una tematica molto in auge in quanto serve a comunicare agli attori esterni quali sono i criteri di sostenibilità che l’azienda applica nelle sue diverse attività».
F.C.: «Questi rapporti di sostenibilità sono sempre più diffusi proprio perché è sempre più diffusa la consapevolezza fra le aziende e le istituzioni pubbliche della necessità di rendere conto del proprio operato verso l’esterno. Cioè verso tutti gli attori che nutrono interessi correlati a quello che fanno e al modo in cui lo fanno. Per noi, peraltro, è stato difficile fare una scelta di quali aspetti mettere in evidenza perché il nostro target di interlocutori è molto diversificato: il settore pubblico, il privato, gli studenti, la comunità scientifica a livello locale e internazionale».
Che tipo di lavoro è stato messo in atto per redigere il rapporto della sostenibilità della SUPSI?
C.B. «Un lavoro enorme, da sempre supportato dalla Direzione SUPSI. Ci siamo principalmente focalizzati sui mandati, cioè formazione di base, formazione continua, ricerca, prestazioni di servizio e trasferimento della conoscenza sul territorio, e poi sugli aspetti relativi alla gestione della nostra stessa istituzione, cioè la responsabilità sociale, economica e ambientale della SUPSI applicata all’interno dei propri campus. L’elaborazione del rapporto di sostenibilità è stata anche un momento di riflessione interna molto importante per capire quali fossero i nostri elementi forti e di debolezza, mantenendo ampio il campo di osservazione e allineandoci con i modelli di valutazione di altre università a livello internazionale».
F.C.: «Alla SUPSI i temi della sostenibilità sono affrontati da un gruppo di lavoro ampio. Una scelta esplicita della Direzione SUPSI, presa con la consapevolezza che essere in tanti significa anche magari rallentare i lavori. La Direzione ha preferito puntare sull’idea di un gruppo di esperti che lavora assieme, in maniera condivisa e collaborativa, imparando dagli altri e sensibilizzandosi a vicenda. Queste sono manifestazioni concrete di come intende la SUPSI la sostenibilità. Due anni abbondanti di lavoro, con circa nove mesi per il processo di consultazione interna, per un rapporto che alla fine si basa su tre anni, 2019-2020-2021, e per il quale è stata coinvolta sui contenuti tutta la comunità SUPSI».
Quali sono gli obiettivi del rapporto?
C.B. «Gli obiettivi del rapporto di sostenibilità in generale non devono essere quelli di fare “greenwashing” e quindi di vendere una sostenibilità di facciata che non esiste. Occorre essere onesti nel presentare quella che è la situazione reale. Il nostro rapporto ha l’obiettivo di far conoscere quello che sono le buone pratiche di sostenibilità all’interno della SUPSI, mettere in evidenza i punti critici da migliorare ed essere fruibile da parte di tutti gli stakeholder interni, quindi studenti, docenti, ricercatori, oltre ai partner esterni. Vuole cioè essere un documento di rendicontazione che sia anche utile come strumento di sensibilizzazione e apprendimento sull’istituzione stessa».
F.C.: «Siamo molto contenti di essere riusciti a fare una prima analisi interna, pur migliorabile in molti modi. È chiaro anche dagli esiti del processo di consultazione interna: dalle colleghe e dai colleghi sono emersi numerosi suggerimenti. Alcuni abbiamo potuto metterli in atto, altri sono nella lista dei miglioramenti per le edizioni future. Il valore aggiunto di questi processi sta nel fare una riflessione sulla condizione attuale, mettendo in evidenza i buoni risultati raggiunti – sicuramente da valorizzare per diffondere consapevolezza dell’efficacia dei provvedimenti attuati – ma anche nel prendere atto di quelli che sono gli ambiti di miglioramento. In questa prospettiva, con il rapporto di sostenibilità abbiamo avviato un processo continuo di analisi e successiva definizione di interventi di miglioramento, che ci guida poi nel nostro lavoro quotidiano. Dobbiamo cioè capire dove siamo stati capaci di colmare (o quantomeno migliorare) le lacune e dove invece le criticità permangono».
La SUPSI fa parte di quali reti federali dedicate alla promozione della sostenibilità negli atenei svizzeri?
C.B. «Facciamo parte della rete sustainability at swissuniversities, costituita nel 2020 e di cui sono vicepresidente, che è stata anche ospite di SUPSI lo scorso aprile. La riunione dell’Assemblea plenaria si è tenuta alla vigilia dell’evento Sustainable University Day, la giornata della sostenibilità delle scuole universitarie svizzere, svoltasi il 29 aprile a Mendrisio. Un evento che abbiamo avuto l’onore di accogliere in Ticino, organizzato in collaborazione con l’USI e promossa dalle Accademie svizzere delle scienze grazie al programma U Change.
Facciamo anche parte del Gruppo di lavoro Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS) delle Alte scuole pedagogiche. Nell’ambito della cooperazione allo sviluppo partecipiamo al programma di swissuniversities Development and Cooperation Network (SUDAC). Da diversi anni inoltre, il Dipartimento formazione e apprendimento collabora con Globe Svizzera. La possibilità di prendere parte a nuove reti non manca».
F.C.: «Grazie ai contatti con la rete nazionale U Change, abbiamo anche recentemente attivato i lavori per lo sviluppo di una piattaforma digitale, SUPStain, a supporto di iniziative per la transizione verso una società più sostenibile che motiva, ispira e supporta le idee di progetti sostenibili degli studenti e di tutti i membri della comunità SUPSI. Un’altra rete di cui facciamo parte dedicata agli studenti e supportata dalle università è quella della “Settimana della sostenibilità”. Sono entrambe iniziative che partono dal corpo studentesco e che supportiamo, in collaborazione con le altre università svizzere, per favorire lo sviluppo di iniziative autonome di sostenibilità da parte degli studenti. Un’ulteriore iniziativa a cui abbiamo aderito recentemente è quella con Focus Sustainability, il centro nazionale per la promozione dell’impegno studentesco sui temi della sostenibilità».
Quali sono gli auspici per l’inserimento di tematiche legate alla sostenibilità nella formazione accademica di domani?
F.C.: «Le attività che stiamo cercando di sviluppare con gli studenti sono tutte extra-curriculari. L’obiettivo sarebbe quello di integrarle nei corsi di studio per tutti, in maniera veramente sistemica, tematiche mirate alla sostenibilità, così da facilitare la diffusione di nuovi modi di operare coerenti con i principi della sostenibilità. Ogni corso di laurea può trovare appigli per integrare la sostenibilità all’interno delle proprie discipline fondanti: la sostenibilità, per definizione, interdisciplinare! Alla SUPSI c’è sicuramente molto interesse ad andare in questa direzione, ci scontriamo però con un contesto didattico fortemente strutturato, in cui le studentesse e gli studenti hanno già un carico di lavoro molto elevato. Diventa quindi difficile trovare spazi per queste attività. Insomma, è uno dei temi su cui stiamo lavorando».
C.B. «Le esigenze del mondo del lavoro rispetto alla sostenibilità stanno cambiando. I limiti planetari sono oggi maggiormente riconosciuti, come pure l’accezione di sostenibilità a livello economico, sociale e culturale. Ci sono delle necessità che vent’anni fa non c’erano, oppure c’erano ma non si era abbastanza sensibilizzati per poterle cogliere. L’importante è che questo processo di transizione venga avviato e che quindi, oltre alla volontà di integrare nei piani di studio le tematiche della sostenibilità, si trovino poi dei modi di sperimentare possibili soluzioni per integrarle davvero nei corsi di studio. Da queste sperimentazioni poi si impara e ci si migliora, riuscendo a convergere su proposte formative che vadano proprio a soddisfare bisogni ed esigenze del mondo del lavoro».
Francesca Cellina*
Laureata in Ingegneria ambientale al Politecnico di Milano (2001), è attualmente impegnata in un percorso di dottorato di ricerca in Sociologia presso l’Università di Milano Bicocca. Ricercatrice SUPSI dal 2009, studia come favorire la transizione verso una società più sostenibile e resiliente al cambiamento climatico.
Camilla Belfiore**
È attiva in SUPSI nel gruppo di lavoro sostenibilità, partecipa ai lavori di sviluppo della piattaforma SUPStain ed è vicepresidente della rete sustainability at swissuniversities. Nel corso del 2022 ha lavorato nel gruppo organizzativo per l’evento Sustainable University Day. Laureata in Economia aziendale all’Università di Friborgo, presso SUPSI ha concluso il CAS in Responsabilità sociale delle imprese.