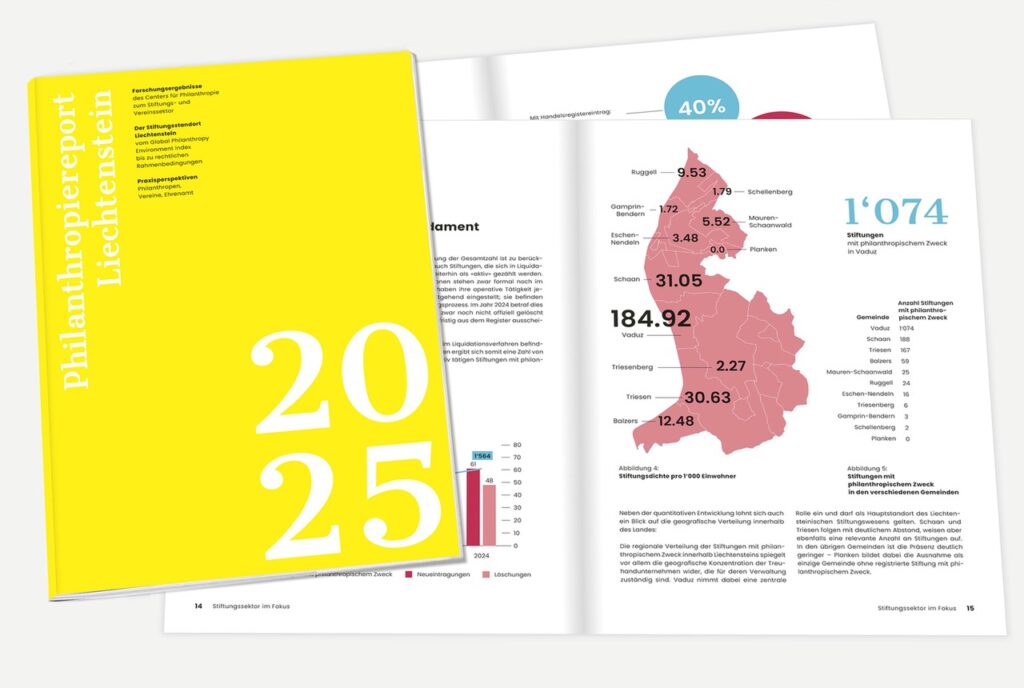Quali esperienze hanno avuto un ruolo nella sua decisione di impegnarsi nella filantropia?
«È un po’ imbarazzante definire se stessi, ma cercherò di essere molto concisa. Sono nata in Sicilia, ma solo perchè per mio padre il primogenito doveva nascere nella casa avita. Avrei dovuto essere maschio, poi a tre mesi mia madre ed io siamo rientrati a Milano dove i miei genitori vivevano e dove mio padre, magistrato, lavorava. Dovrebbe essere una data facile da ricordare in quanto arrivammo il giorno prima che la città venisse bombardata, 24 ottobre 1942, e vi assicuro che non è stato il mio arrivo a provocare una simile distruzione. Ho studiato a Milano (liceo classico), mio padre non avrebbe accettato nessun’altra scelta. Più tardi, laurea in Lettere antiche, volevo diventare archeologa, ma poi la vita decise in altro modo, mi sono sposata: alla fine Sessanta non sarebbe stato facile sovvertire un‘educazione che mai mi avrebbe consentito di lasciare casa e marito per seguire il mio sogno di scoprire siti sconosciuti. Mi sono perciò diplomata a Parigi alla scuola del Museo Camondo in architettura di interni, un’altra delle mie scelte, ma più facile da seguire. Sono sempre stata una ribelle e ho sempre pensato che la mia libertà l’avrei ottenuta solo con l’indipendenza economica».
Che peso ha avuto la sua famiglia nella sua scelta di diventare mecenate? C’è una persona particolare che l’ ha ispirata?
«Forse mio padre in maniera indiretta; mia madre era cattolica per cui per lei si trattava di fare beneficenza, cosa molto diversa da un impegno costante, mentre mio padre profondamente ateo stimava molto la filosofia protestante e credo sia stato lui per primo a dirmi che chi aveva doveva ridare, per un senso etico e di giustizia sociale, non già per un precetto religioso. Questo mio sentire ha trovato la sua strada quando mi sono risposata e sono andata a vivere a New York, dove è molto presente la necessità morale di dare agli altri anche come ringraziamento per quello che la vita ti ha donato. Molti, forse troppi, pensano a un interesse finanziario in quanto la legislazione americana ti permette di detrarre dalle tasse, secondo del tuo imponibile, le donazioni di beneficenza. Questo non per noi o per altre persone che conosco, e quando sono rimasta vedova il mio primo atto è stato esaudire il desiderio di mio marito: «Ho avuro molto dalla via, ora è giusto che quello che ho costruito aiuti altri non così fortunati». La mia fondazione si occupa dal 2001 di elargire borse di studio a ragazzi non abbienti che desiderano accedere a studi presso le migliori università americane».
Quale è stato il fattore determinante che l’ha spinta ad impegnarti nella filantropia? C’è stato un momento preciso o forse è stato l’incontro con qualcuno?
«Vivere a New York è stata per me una grande esperienza formativa, in tutti i sensi; quello che ho fatto e la persona che sono diventata lo devo a mio marito e alla città, dove sei sempre messa a contatto con realtà diverse, progetti e problemi, per cui sei obbligata a crescere per non rimanere un essere inerme».
Com’è nata la sua fondazione di diritto americano?
«La Fondazione è una No Profit Foundation e il suo ambito di intervento è molto ristretto, si occupa solo di educazione scolastica senza nessuna preclusione nè religiosa nè etnica. Sono due gli standard di accesso, il profilo studentesco e la mancanza di risorse finanziarie. Io mi sono volutamente esclusa dall’amministrazione e dalla scelta dei candidati che vengono valutati da un board di avvocati e professori».
Di quali progetti si occupa la fondazione?
«Come dicevo il nostro scopo è quello di accompagnare studenti eccellenti nel loro percorso fino al conseguimento di una laurea. Credo che in un mondo che diventa sempre più competitivo una buona educazione scolastica sia la base per una società piu evoluta e democratica. E per me è una gioia incredibile leggere i reports degli studenti che ce la fanno».
Come è nata invece Musadoc e di che cosa si tratta?
«Nel 2003 mio marito è stato trasferito in veste di Ambasciatore italiano nella Confederazione Svizzera dall’ONU a Berna, una città che ho molto amato. Avevo subito avvertito mio marito che non mi sarei accontentata di fare le tartine per la festa nazionale del 2 giugno, e che avrei voluto essere di aiuto nell‘ individuare occasioni per parlare dell’Italia e della sua cultura. Abbiamo organizzato eventi molto interessanti che credo siano piaciuti ai nostri ospiti svizzeri e alla comunità italiana. Il primo è stato particolarmente faticoso in quanto abbiamo svuotato l’Ambasciata per poter mettere in mostra importantissime opere dell’arte moderna italiana e l’Ambasciata è rimasta aperta al pubblico per un mese. Arrivando a Roma mi sono occupata di organizzare altri eventi ma sempre no profit».
Quale filosofia e quali obbiettivi sono alla base di questo progetto?
«Musadoc è un’associazione culturale senza scopo di lucro e credo che questo status ci dia molta libertà nella scelta dei progetti. Ho accettato di diventarne Presidente di Musadoc perché lo status dell‘Associazione mi ha dato la libertà di attivarmi per progetti che non fossero condizionati dal guadagno. Alla mia età trovavo giusto continuare ad attivarmi per quegli ideali che avevano nutrito la mia gioventù. Abbiamo bisogno di creare opportunità di dialogo e di confronto, e la cultura è uno straordinario veicolo per abbattere quei muri che ci isolano, abdicando così a dei principi morali che sono alla base delle nostre democrazie».
Parliamo di Covid 19: in quale modo la pandemia ha modificato e modificherà le relazioni fra filantropi e stato? Come pubblico e privato possono interagire ed eventualmente collaborare?
«Spero vivamente che il Covid possa influire e modificare i rapporti tra filantropi e Stato: questa pandemia forse aiutera a capire che i progetti importanti hanno bisogno dello sforzo del privato e del pubblico. L’obbiettivo deve essere comune perchè la filantropia individua e analizza il progetto, ma il pubblico ha il dovere di essere più pragmatico per poter parlare poi di un successo a lungo termine».
Da ultimo: quale è la sua visione per la filantropia del futuro?
Credo che la filantropia dovrebbe essere una materia di studio nelle scuole superiori; dobbiamo insegnare ai ragazzi che occuparsi del bene comune è un dovere, il bene tuo è anche il mio, e un tuo successo a cui io ho partecipato sostenendoti è il successo della società in cui viviamo. Siamo una catena e in un mondo globale ci devono essere degli ideali che ci aiutino a non creare muri: la filantropia può essere un giusto mezzo per raggiungere grandi risultati».
Dieci anni di impegno per la cultura
Nel 2009 Marilena Citelli Francese ha organizzato, come presidente degli Amici del Museo di Israele a Gerusalemme, presso l’Auditorium di Roma, il concerto “In memoria di Yitzhak Rabin”, diretto dal Maestro Lorin Maazel. Ogni anno dal 2014 organizza per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri un concerto per il Giorno della Memoria con il coinvolgimento di artisti di prestigio internazionale. Dopo l’11 settembre ha creato l’associazione Women For Cross Cultural Understanding, convinta che le donne hanno e avranno un ruolo sempre più importante nella lotta contro la discriminazione razziale, fa parte del Board della Casa Italiana alla New York University, fondata dalla filantropa italiana Mariuccia Zerilli Marimo e dal 2019 del Board di Visionarie, donne tra cinema, tv e racconto.