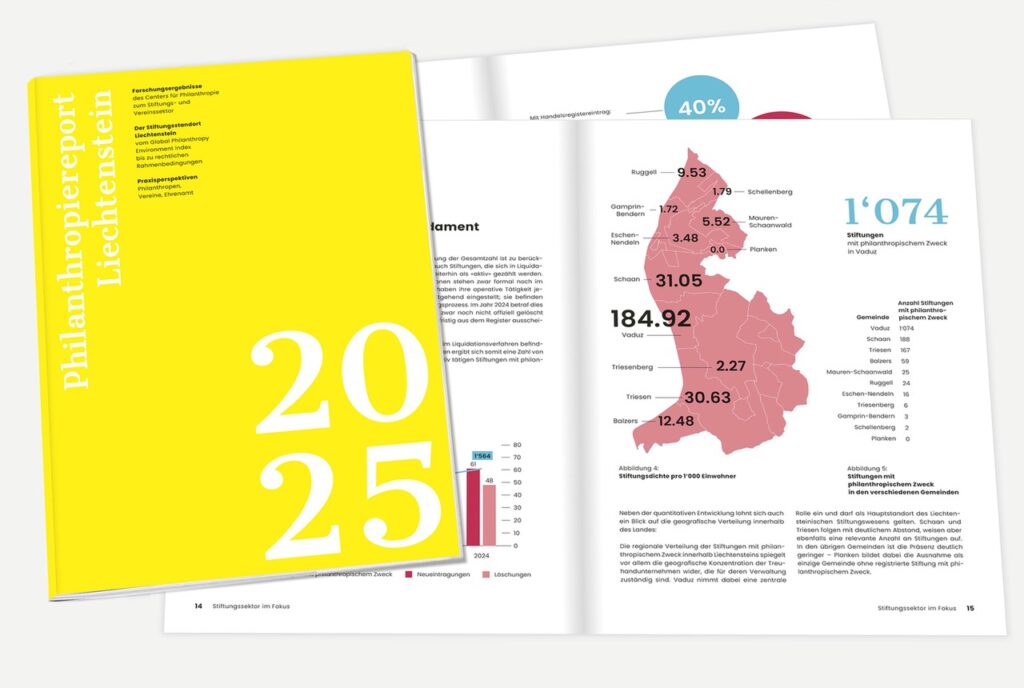«La prossima volta che sentite che qualcuno sta affrontando un qualche problema e pensate che non vi riguardi, ricordate che quando uno di noi viene colpito, siamo tutti a rischio. Siamo tutti coinvolti in questo viaggio chiamato vita. Prendersi cura gli uni degli altri è un modo per incoraggiarci e sostenerci a vicenda. Quando senti suonare la campana non chiederti per chi suona. Suona anche per te» (Ernest Hemingway)
«La prossima volta che sentite che qualcuno sta affrontando un qualche problema e pensate che non vi riguardi, ricordate che quando uno di noi viene colpito, siamo tutti a rischio. Siamo tutti coinvolti in questo viaggio chiamato vita. Prendersi cura gli uni degli altri è un modo per incoraggiarci e sostenerci a vicenda. Quando senti suonare la campana non chiederti per chi suona. Suona anche per te» (Ernest Hemingway)
«La vita è fondata su complesse reti di relazioni che collegano gli individui che fanno parte di una comunità, ed esiste un legame tra la terra e il corpo, la cui condizione di benessere o malattia incide sulla qualità della vita quotidiana. Quelle che supportano la nostra vita di tutti giorni sono spesso piccole azioni apparentemente banali. La gratitudine rappresenta la lieta consapevolezza di questa realtà, e la chiave di accesso a una prospettiva di vita più ampia e appagante. È un potente strumento che ci aiuta a riorientare la nostra attenzione verso il positivo, coltivando un atteggiamento ottimista».
Qual è il legame tra la riconoscenza e la filantropia?
«Gratitudine e filantropia afferiscono entrambe alla sfera della generosità: la prima esprime la valorizzazione del donatore e l’apertura mentale del beneficato, che non teme di riconoscere pubblicamente il gesto del donatore; la seconda consiste nell’azione concreta di sostenere gli altri attraverso il supporto economico o con iniziative benefiche. La gratitudine è il valore fondante della relazione generosa fra filantropo e beneficiario».
Ci sono effetti psicologici positivi che derivano dal provare ed esprimere riconoscenza?
«È ampiamente dimostrato che provare un sentimento di riconoscenza migliora il benessere mentale, la felicità, e che la gratitudine, se coltivata, può ridurre stress e ansia, incrementare il senso di appartenenza e contribuire a relazioni interpersonali più salutari. Dice Warren Buffett, imprenditore filantropo: “La gratitudine è l’anima della felicità. Quando si è grati per ciò che si ha, si è più capaci di apprezzare le piccole cose della vita e di essere felici, nonostante le sfide che si presentano”».
Si può dire che la gratitudine migliori le relazioni tra donatori e organizzazioni?
«Certamente. Innanzitutto è il clima della collaborazione che cambia: si crea una comunicazione aperta e trasparente, un’atmosfera benevolente che favorisce lo scambio, facilitando la crescita e lo sviluppo di rapporti duraturi e significativi. Tutto questo può motivare chi dona a non mettere a disposizione solo risorse materiali, ma anche le proprie reti sociali, e a sostenere l’organizzazione non profit sul lungo periodo. L’esprimere pubblicamente riconoscenza ha poi un impatto sulla reputazione tanto del donatore che dell’organizzazione non profit, poiché dimostra un impegno verso la trasparenza e la cura dei propri sostenitori. Oprah Winfrey, celebre moderatrice televisiva, imprenditrice, filantropa, ha tenuto un diario della gratitudine per molti anni. Attraverso la sua fondazione ha donato cifre significative a organizzazioni che sostengono l’istruzione e l’autonomia di donne e bambini, e a quelle locali che si dedicano all’aiuto dei più vulnerabili nelle loro comunità. Oprah, testimoniando pubblicamente e per anni la sua convinzione che la gratitudine possa produrre azioni significative e altruistiche, ha ispirato migliaia di persone a fare altrettanto».
Quali sono i modi in cui i beneficati possono dimostrare riconoscenza nei confronti dei loro filantropi?
«I filantropi vogliono sentirsi riconosciuti come persone e non solo in virtù delle loro possibilità finanziarie. Il coltivare una consapevolezza costante di questo aspetto porta anche a riflettere in quale modo sia più opportuno dimostrare riconoscenza. Occorre tenere conto della forma mentis e sensibilità personale di ciascuno. Werner Reinhart, grande mecenate della musica di Winterthur, raccomandava il massimo riserbo ai musicisti che sosteneva, al contrario di Paul Sacher, mecenate basilese coevo, che manifestava il desiderio opposto, apprezzando anche il pubblico riconoscimento. Due caratteri diversi, due diverse aspettative, ma lo stesso piacere di sentire nella relazione la meraviglia dell’essere apprezzati.
Al di là dei gesti materiali, è dunque l’attitudine spirituale del beneficato quella che conta. Impegnarsi nel ringraziare un filantropo non è qualcosa che si esaurisce dopo aver ricevuto una donazione, ma un atteggiamento interiore che accompagna la relazione per tutta la sua durata. Spesso, purtroppo, le istituzioni per le quali un donatore si è speso per anni hanno la memoria breve, ne ignorano perfino la scomparsa, non lo ricordano alla comunità, non confortano la famiglia, dimenticando totalmente il contributo che ha dato, qualche volta adducendo il motivo di un suo prematuro ritiro dalla vita pubblica».
In che modo la riconoscenza può contribuire alla creazione di un senso di comunità fra filantropi?
«Vivere con un senso di gratitudine e riconoscenza il privilegio della ricchezza può favorire la creazione di un senso di appartenenza e identità condivisa tra filantropi, portando a uno scopo condiviso. Da qui la nascita di nuove forme di filantropia come quella della Trust-Based Philanthropy, o filantropia della fiducia, un modello che si fonda appunto sulla fiducia nell’abilità dei beneficiari e delle loro comunità di appartenenza di identificare i propri bisogni e dar loro soluzioni ottimali senza intervento esterno. L’approccio è quello di un sostegno pluriennale alle istituzioni e non solo ai progetti, per permettere loro di poter adattare ed espandere programmi e portata.
Da qui anche la nascita del modello della filantropia collettiva, uno strumento potente che si attiva quando gruppi di filantropi fanno rete, aggregano risorse e agiscono insieme per massimizzare l’impatto positivo sulla comunità o sulle cause affrontate. Significativa a questo riguardo è l’esperienza di UBS, che ha avviato “UBS Collectives”, gruppi di clienti che uniscono le loro risorse, concentrandosi su temi come la protezione dell’infanzia, il cambiamento climatico e questioni legate alla salute e all’istruzione».
In che modo riconoscere e valorizzare il sostegno del filantropo può creare una dinamica positiva e trasformare il beneficiario consapevole in un futuro donatore?
«Riconoscere e apprezzare il sostegno del filantropo può ispirare il beneficato a praticare a sua volta azioni benefiche e incoraggiare comportamenti virtuosi in vari modi:
Motivazione e incoraggiamento: l’apprezzamento per il sostegno ricevuto può spingere a titolo di esempio un artista affermato a sostenere i giovani. Anne-Sophie Mutter, celebre violinista, pupilla di Paul Sacher che la sostenne per anni, ha istituito una propria fondazione con l’obiettivo di fornire supporto globale a violinisti, violisti, violoncellisti e contrabbassisti emergenti. La fondazione offre un supporto personalizzato ai borsisti in base alle loro esigenze specifiche. Questo può includere lezioni con lei, assistenza nella scelta di un insegnante adeguato, fornitura di strumenti musicali, contatti con solisti famosi e partecipazione alle loro masterclass, e audizioni con direttori d’orchestra (https://www.anne-sophie-mutter.de/seite/anne-sophie-mutter-stiftung/).
Gratitudine e reciprocità: Essere grati per il supporto ricevuto può spingere un’artista a ricambiare con gesti altruistici e di solidarietà. Un esempio virtuoso è quello di Angelika Kauffmann, pittrice austriaca del XVIII secolo, sostenuta da mecenati e collezionisti come il conte Josef Johann von Fries. In seguito, la stessa Kauffmann diventò filantropa (https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/022037/2021-12-13/)
Senso di comunità e responsabilità sociale: La consapevolezza di quanto ricevuto potenzia il senso di responsabilità sociale per il benessere collettivo e spinge un’artista a impegnarsi per la comunità. Aviva Rahmani, per esempio, nota artista interdisciplinare, collabora non solo con altri artisti, ma anche con scienziati, architetti e ingegneri, soprattutto a progetti di sostenibilità ambientale. Supportata da fondazioni quali la Doris Duke Charitable Foundation e dalla Andrew W. Mellon Foundation, crede che piccoli cambiamenti possano avere un impatto positivo sull’intero sistema, diffondendo il suo messaggio attraverso l’arte. Nel suo libro Generosità contagiosa. L’idea che vale assolutamente la pena di diffondere, il presidente delle Conferenze Ted, Chris Anderson, presenta un esempio di come una donazione inneschi un circolo virtuoso, raccontando la storia di due donatori anonimi che hanno regalato 10.000 dollari ciascuno a duecento sconosciuti, scoprendo che la maggior parte dei beneficiari ha deciso di “restituire” parte della somma con atti generosi propri».
Che ruolo ha infine la gratitudine nell’era moderna e tecnologica? È ancora un sentimento rilevante o è diventato fumoso e anacronistico nel mondo contemporaneo?
«In una società sempre più veloce e frenetica, solo a uno sguardo superficiale la gratitudine può sembrare un concetto antiquato. In realtà mai come adesso, in un periodo di crescente violenza e incertezza internazionale, ognuno di noi ha bisogno di relazioni qualificanti e di creare per sé un’isola di pace. Condivido il pensiero di Roberto Benigni: “È un segno di mediocrità quando dimostri la tua gratitudine con moderazione”. A maggior ragione per chi ha fatto della generosità un pilastro della propria esistenza».
Dr. Elisa Bortoluzzi Dubach, consulente di Relazioni Pubbliche, Sponsorizzazioni e Fondazioni, è docente presso varie università e istituti superiori in Svizzera e Italia e co-autrice fra gli altri di La relazione generosa. Guida alla collaborazione con filantropi e mecenati.