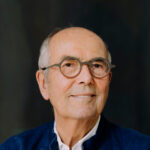L’impegno della filantropia a favore della salute è cosa recente?
«Filantropia e sanità si sono sempre incontrati. Basti pensare a Roma alle Corsie Sistine, volute da Papa Sisto IV in occasione del Giubileo del 1475 all’interno del Complesso di Santo Spirito in Sassia, il più grande ospedale d’Europa. Gli architetti Andrea Bregno e Baccio Pontelli pensarono di costruire una vasta corsia dotata di grandi finestre per consentire il ricambio d’aria, ma una delle intuizioni geniali fu quella di affrescare la sommità delle pareti, in modo che i malati allettati potessero guardare le immagini che raffiguravano le gesta dei papi che avevano dato vita alla struttura e godere della bellezza dei dipinti.
Un altro esempio virtuoso è la Ca’ Granda di Milano, voluta da Francesco Sforza, in accordo con la moglie, in seguito a un voto fatto il 25 marzo 1450, giorno dell’Annunciazione. Una sola vasta struttura, la Magna Domus Hospitalis, avrebbe fornito assistenza medica gratuita a tutti, in particolare ai poveri. Fino ad allora a Milano non esistevano grandi nosocomi, ma soltanto delle infermerie in luoghi diversi della città gestite da religiosi, con scarsità di posti letto. Le malattie erano curate in modo adeguato in relazione alle conoscenze dell’epoca, dove la farmacopea di base era un riferimento».
Come operavano in passato i filantropi attenti a questi argomenti?
«Ben prima che gli Stati si dessero un welfare sociale, i medici, in prevalenza di sesso maschile, si dedicavano a una piccola fascia sociale in grado di remunerarli. A livello di quartieri la cura dei pazienti non benestanti era spesso esclusiva delle donne. Dettata da convinzioni religiose e spinte etiche, era dominio di personalità femminili, appartenenti al ceto nobiliare o molto facoltoso, che sentivano la voglia di impegnarsi in favore dei più deboli, considerando fra gli altri la filantropia come un mezzo per acquisire profilo. Le ragazze di buona famiglia, specialmente se sposate, prevedevano un impegno assiduo nella filantropia – in particolare sul territorio in cui vivevano. Fortemente influenzato dallo stato civile della donna, l’impegno filantropico variava a seconda della vita sociale: nubili, sposate e vedove avevano un diverso approccio nei confronti della filantropia e il mecenatismo divenne uno strumento per acquisire una diversa visibilità e un più ampio campo di influenza. Con il miglioramento sociale e il nascere del welfare, molte attività furono delegate alle istituzioni pubbliche, ma i filantropi, uomini e donne, continuarono ad avere attenzione ai temi della salute, un tema centrale come dimostrano le esperienze e gli studi in tutto il mondo, per es. fra i molti, di WealthX, una delle banche dati e degli istituti di ricerca di riferimento o della Lilly Philanthropy School dell’Università dell’Indiana».
Filantropia e sanità si possono incontrare oggi in maniera virtuosa?
«In Svizzera le strutture sanitarie che lavorano al meglio con i mecenati sono quelle che si danno strategie e definiscono le regole, stabiliscono obbiettivi, ambiti di intervento e vincoli, e hanno loro interno figure professionali in grado di interagire in modo ottimale con loro, realizzando progetti non coperti dai budget ordinari. Una bellissima opportunità per quanti come me sono convinti che un obbiettivo fra i molti sia di facilitare il lavoro degli specialisti alleviandolo dalle mansioni burocratiche e rifocalizzandolo alla vocazione primaria della prevenzione e cura dei pazienti».
Quali sono le aree del settore sanitario in cui i mecenati scelgono di impegnarsi?
«Sono attivi in moltissime aree che spaziano dalla ricerca -fra gli altri anche in quei casi dove le case farmaceutiche sono più restie a investire, come nello sviluppo di farmaci per le malattie rare – ai vaccini, all’acquisto di materiale sanitario e di infrastrutture, al contributo economico per la costruzione di padiglioni ospedalieri.
Oppure laddove è necessario, per esempio con interi ospedali nei Paesi in via di sviluppo, il sostegno di nuovi modelli di cura o di ambiti in cui le istituzioni pubbliche investono ancora troppo poco, come nella prevenzione. I medici di base concentrano le loro energie soprattutto nell’intervenire sulle malattie, anche a causa delle risorse economiche limitate, ma spesso non c’è metodo, costanza e attenzione sufficiente per la prevenzione. Al contrario, gli specialisti si concentrano su un solo problema, spesso ignorando il paziente nella sua interezza. Da parte loro, i grandi donatori possono mettere a disposizione capitali di rischio, che sostengano quei pionieri del mondo della cura che sono allo studio di nuovi modelli di intervento sanitario, a patto di poter finanziare progetti volti a una piena visione di sostenibilità sanitaria».
Parliamo di medicina olistica: c’è spazio per i filantropi anche in questo ambito?
«Sono convinta che il medico non debba solo dispensare farmaci, ma che la cura sia un concetto olistico, e al paziente serva sempre anche una comunicazione adeguata. Quando la malattia è di lungo periodo, o particolarmente invasiva, serve altresì un adeguato supporto psicologico. In generale gli ospedali, anche i più moderni, sono spesso strutture grigie e tristi. Posto che quasi sempre le istituzioni pubbliche non hanno fondi per migliorare l’estetica degli ospedali, anche soltanto per rendere meno anonime le sale d’attesa o realizzare stanze di lunga degenza che riconoscano quanto abbiamo appreso dalla psicologia, ecco una grande opportunità di collaborazione con i privati. Le nuove frontiere della ricerca scientifica continuano ad approfondire le potenzialità degli effetti del suono, dei colori, della luce, della natura sull’organismo, dimostrando che la musica è anche in grado di stimolare la produzione di endorfine (gli ormoni del “buon umore”) e il sistema immunitario. Un esempio è il progetto “Cultura e Salute”, avviato nel 2011 dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna, che ha fornito e raccolto le risorse economiche necessarie. Alla base c’è la volontà di creare luoghi in grado di influenzare il risultato terapeutico nell’interesse dei pazienti e degli stessi curatori. In un decennio è stato ripensato un intero blocco dell’Ospedale Sant’Anna di Torino. L’arte è una importante risorsa di accoglienza per operatori sanitari e pazienti, e il processo di recupero della salute coinvolge il corpo, ma anche la mente».
“Solo il tocco, il rimedio e la parola possono guarire”, diceva Ippocrate, ma sembra che nel corso del tempo la scienza medica abbia dimenticato questo prezioso insegnamento e abbia messo a tacere la parola, concentrandosi soltanto sul tocco e sul rimedio. È vero?
«Oggi, la comunità scientifica, grazie all’approccio sistemico, ha nuovamente preso in considerazione lo studio e l’applicazione della comunicazione verbale, cogliendone la soggettività, come vuole la medicina narrativa che purtroppo al momento non fa sempre parte della formazione del personale sanitario. Ecco allora l’importanza delle Medical Humanities, che danno primaria importanza ai criteri etici, necessari a guidare le decisioni nei casi più problematici, senza dimenticare però la dignità del paziente, e il rispetto per la sua sofferenza fisica e psicologica. È il cosiddetto “umanesimo scientifico”, che privilegia i piccoli gesti, “come un tocco, un sorriso, una parola gentile, un orecchio in ascolto, un complimento sincero, o il più piccolo atto di cura, che hanno il potenziale per trasformare una vita” (Leo Buscaglia). In Canton Ticino, la Fondazione Sasso Corbaro, nata nel 2000 per iniziativa di medici, imprenditori e studiosi, e cresciuta con l’appoggio delle autorità cantonali, è stata la prima in Svizzera a dedicarsi alla promozione delle Medical Humanities e dell’etica clinica».
Come migliorare la sensibilità sulla collaborazione fra Stato e mecenati anche nell’ambito della salute?
«È necessario passare da una filantropia “occasionale e casuale” a interventi specifici, sistematici e coordinati nel tempo. Risultato che si ottiene andando incontro ai bisogni della comunità e confrontandosi sulle regole della collaborazione fra istituzioni e privati. In questo modo, si crea anche un rapporto più concreto e profondo con il filantropo, basato sulla conoscenza reciproca e su una “professionalità dal volto umano”, in cui la collaborazione ha obbiettivi precisi, condivisi, e dagli effetti misurabili. Che serve inoltre a prevenire il pensiero che il filantropo sia solo un bancomat dispensatore di fondi. Concretamente, immaginiamo per es. l’aiuto che un grande donatore può offrire alle comunità locali, ad esempio con la formazione di operatori sociali di quartiere, in grado di monitorare lo stato fisico e psicologico delle persone anziane fare così prevenzione a livello sanitario.
“Bisogna tornare alla Medicina della persona” sosteneva Umberto Veronesi, che da grande taumaturgo, sapeva che per curare qualcuno dobbiamo sapere chi è, che cosa pensa, che progetti ha, per che cosa gioisce e soffre. Dobbiamo far parlare il paziente della sua vita, non solo dei suoi disturbi. “Prima di essere auscultato, il paziente ha bisogno di essere ascoltato” scrive Fulvio Fiori nel suo libro Le parole della cura, dal linguaggio medico al linguaggio terapeutico, Edizioni Lindau. Mentre oggi le cure sembrano spesso fatte a macchina, in serie, anche se le cause non sono sempre legate alla volontà del personale sanitario: “Lei ha questo, faccia questo; ha quest’altro, prenda quest’altro”. Ma così non è curare. Ebbene, la filantropia può portare linfa preziosa alla Nuova Medicina, quella che vuole guarire l’uomo, insieme alla sua malattia».
*Dr. Elisa Bortoluzzi Dubach, consulente di Relazioni Pubbliche, Sponsorizzazioni e Fondazioni, è docente presso varie università e istituti di studi superiori in Svizzera e Italia.