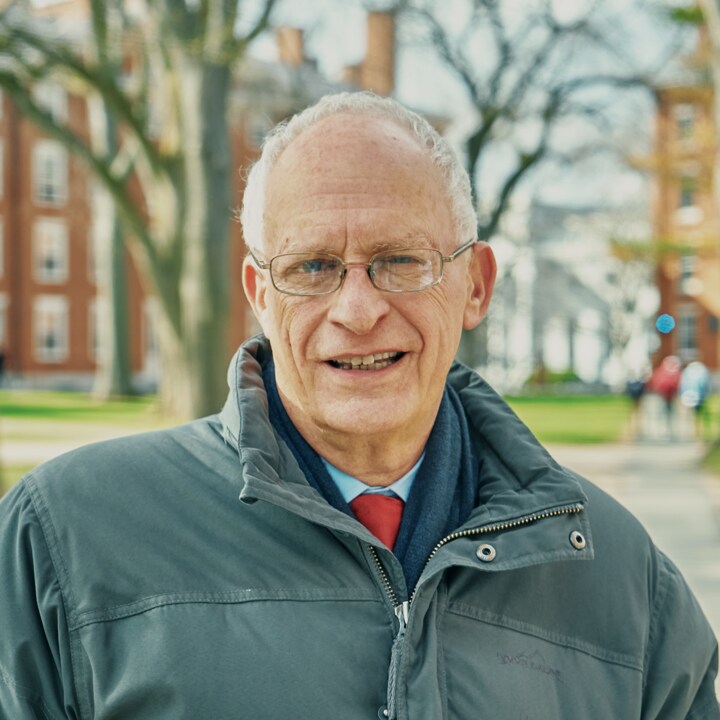Gestire la “quarta rivoluzione industriale”, con i suoi grandi bisogni dal punto di vista delle fonti energetiche e raggiungere nel contempo la neutralità ambientale per far fronte ai cambiamenti climatici rappresenta una sfida estremamente complessa che non si vince con slogan velleitari e fughe in avanti ma individuando soluzioni differenziate e concertate su scala mondiale per evitare pericolosi squilibri geopolitici.
Recentemente la presidente dell’Unione europea Ursula von der Leyen ha affermato quanto segue: «L’economia dei combustibili fossili ha raggiunto i suoi limiti. L’Europa è il primo continente che presenta un’architettura globale per realizzare le nostre ambizioni climatiche con una tabella di marcia. La rivoluzione verde è il nostro compito generazionale. Non c’è un compito più grande e più nobile di questo e l’Europa è pronta ad assumere un ruolo guida».
Il piano FitFor55 indica gli strumenti per la rivoluzione verde, ovvero ridurre del 55% le emissioni di CO2 entro il 2030, con l’obiettivo finale di azzerarle nel 2050 e per farlo occorre fra l’altro bandire le auto a benzina entro il 2035 e sostituirle con quelle che consumano elettricità. Ma l’Europa è davvero “pronta ad assumere un ruolo guida”? Per raggiungere questo obiettivo molto ambizioso non basta applicare la ricetta cui la BCE ha abituato gli europei dal punto di vista economico-finanziario: non curarsi dell’indebitamento e stampare moneta a colpi di migliaia di miliardi (cui non corrisponde più da decenni nessun deposito reale di ricchezza). I chilowattora con cui far funzionare le macchine elettriche e i computer non si stampano alla bisogna; occorre produrli concretamente. E sappiamo che l’UE non solo non è autosufficiente dal punto di vista del proprio fabbisogno energetico, ma dipende in larga misura dall’energia importata dall’estero. Nel 2019 era dipendente per il 60% dalle importazioni, soprattutto di petrolio e gas in provenienza dalla Russia. La dipendenza energetica della locomotiva economica dell’UE, la Germania, è addirittura del 67% e anche qui si tratta in larga misura di importazioni di energie fossili dalla Russia.
Il paradosso è stridente: come si fa a dichiarare la volontà di svolgere un ruolo guida nel campo dell’economia verde e dipendere in modo preponderante (e crescente) dalle importazioni di energie fossili? A maggior ragione se – come ha fatto velleitariamente la Germania – si decreta la chiusura anticipata delle centrali che producono energia nucleare, una fonte di energia che non produce anidride carbonica. La Svizzera, che ha seguito troppo frettolosamente le orme della Germania, si è vista costretta a procrastinare la chiusura delle proprie centrali atomiche, senza le quali appare impossibile realizzare gli obiettivi ambientali della Strategia energetica 2050.
Il fantasma della penuria energetica è ormai un problema riconosciuto e molto reale in Europa e dipendere dalla Russia per avere garantita l’elettricità necessaria per scaldare le case d’inverno e alimentare le macchine elettriche e l’insieme delle infrastrutture su cui poggia la rivoluzione digitale non è una prospettiva rallegrante.
Come non appare rallegrante dipendere in larga misura dalla Cina per rispondere al fabbisogno di minerali rari da cui dipendono le tecnologie sia delle energie alternative (turbine eoliche, pannelli solari…), sia dei cellulari, i tablet, le batterie delle auto elettriche e circuiti dei veicoli autonomi, sistemi radar, intelligenza artificiale e sistemi di cybersicurezza… La lista di queste terre rare essenziali per le tecnologie digitali e le energie rinnovabili sarebbe lunga: silicio, cobalto, bismuto, tantalo, prometeo… nomi emblematici che evocano la volontà dell’uomo di sostituirsi agli dei e di fare prodigi. Le loro proprietà catalitiche, elettroniche e ottiche sono “magiche”: l’indio permette ad esempio agli schermi dei cellulari di diventare tattili, ma per rendere i nostri smartphone i gioielli che sono ci vogliono una dozzina di metalli rari. La realtà è che la produzione di smartphone, di pannelli solari, microchip, magneti, veicoli elettrici, turbine eoliche… richiede l’estrazione di enormi quantità di materie grezze per trarne centinaia di migliaia di tonnellate di terre rare ogni anno. Per le turbine eoliche di ultima generazione e quelle off-shore del Mare del Nord (ma anche per i magneti utilizzati nei veicoli elettrici) viene utilizzato il neodym, molto raro e costosissimo, la cui estrazione è estremamente difficoltosa e provoca enormi danni ambientali a causa delle scorie tossiche e radioattive che vengono prodotte. Insomma, estrarre e raffinare questi minerali ha un costo ecologico elevatissimo, come dimostrano inchieste approfondite pubblicate negli ultimi dieci anni.
La realtà è anche che il principale produttore di queste terre rare è la Cina (nel 2018 ne ha prodotto 120.000 tonnellate su 170.000, vale a dire più del 70%). Dall’inizio degli Anni Novanta del secolo scorso, Pechino ha investito massicciamente (e segretamente, con danni ambientali e umani devastanti per intere regioni del Paese, ad esempio nella regione di Boatou, nella Mongolia interiore) in questo mercato conquistando un’indiscutibile posizione dominante. E proprio a causa di questa posizione dominante due anni fa, in replica alle minacce di Trump di bloccare l’esportazione di merci cinesi, Xi Jinping ha pubblicato i dati della produzione mineraria cinese (segnatamente quella delle terre rare) mandando a dire agli USA e al mondo che se l’Occidente non voleva ripiombare negli Anni precedenti la rivoluzione digitale, era meglio che non alzasse troppo la voce con Pechino.
Come si vede, oggi come oggi il prezzo da pagare per la svolta energetica “green” e per la quarta rivoluzione industriale è elevatissimo in termini ecologici e foriero di pericolosi squilibri geopolitici. Non può non preoccupare il fatto che l’Unione europea – che si proclama campione della svolta energetica ecologica – sia in realtà vieppiù dipendente dal petrolio e dal gas russo (anche perché alcuni suoi membri chiudono le centrali nucleari) e che il mondo intero, per garantire il fabbisogno di terre rare necessarie alle tecnologie digitali e a quelle per la svolta energetica, sia più dipendente ancora dalle miniere cinesi dove rifiuti tossici e radioattivi devastano interi territori e insediamenti umani. Una cosa è certa: anche dietro alle magnifiche sorti e progressive della svolta energetica ecologica odierna e della quarta rivoluzione industriale c’è una faccia oscura. Nella definizione delle scelte strategiche occorre tenerne conto adeguatamente.