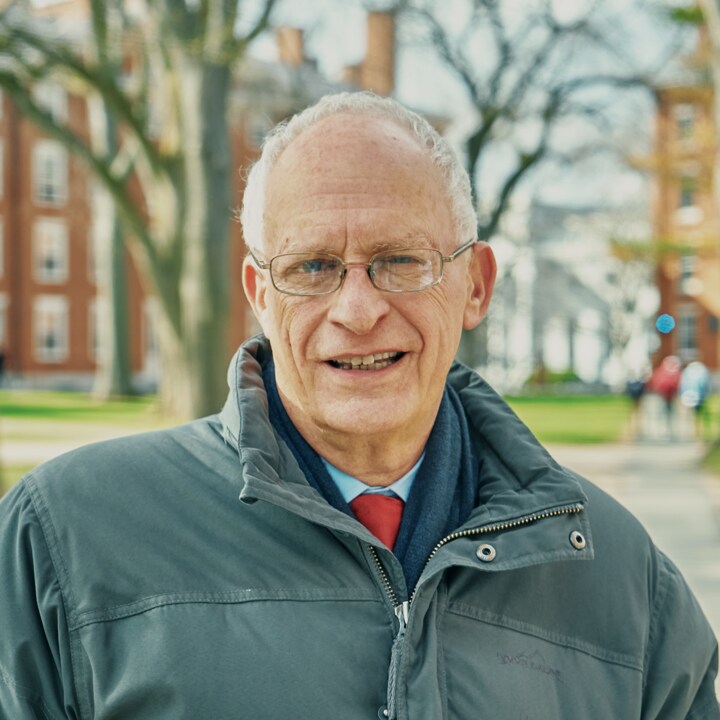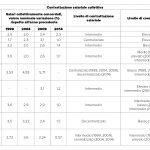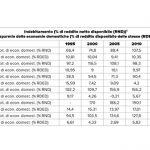Il lettore attento sia tranquillizzato da subito: non vi è errore ortografico nel titolo e, nello specifico, nel termine “intraprenditore”. Resta da domandarsi perché non si sia voluta utilizzrae la denominazione corrente di “imprenditore”. Questa volta, la lingua italiana rende poco l’idea sottostante a tale ruolo strategico nella società lavorativa, che è invece riprodotto in modo più calzante dall’inglese entrepreneur, cioè (ricalcandone la somiglianza fonetico-lessicale) “intraprenditore” appunto. Del resto, l’imprenditore stesso – per potere fare impresa in modo adeguato al termine management – deve necessariamente essere “intraprendente”, cioè possedere una visione poco conservativa, ma positivamente aggressiva oltre che orientata al rischio ponderato. Beninteso: non tanto fino a sé stesso quanto per il raggiungimento di obiettivi economici, che si ritengano alla portata di mano. Nel contempo, l’imprenditore (se non deve necessariamente essere un self-made man) – così come nelle società capitalistiche non si dovrebbe demonizzare il concetto di “eredità”, cioè della trasmissione intergenerazionale di risorse oltre che sapere –, certamente deve possedere una visione strategica di medio-lungo termine, sapendo coniugare quella giusta oculatezza contabile (per evitare di trasformarsi in uno speculatore-faccendiere) con quella generosità paternalistica tipica di chi sa che dare fiducia alle persone giuste nei momenti giusti comporterà un ritorno economico oltre che umano importante. Lungimiranza chiama, evidentemente, sempre risultati. Allo stesso tempo, l’imprenditore deve essere fonte inesauribile di idee, conoscere tutti e tutto all’interno del proprio business, non essere accentratore almeno per evitare di porre egli stesso le basi per il declino della propria “creatura” allorquando egli non potesse più occuparsene. L’imprenditore deve “sapere fare impresa”, cioè essere in grado di competere con la propria azienda per la qualità del bene/servizio offerto sul mercato (inter)nazionale di riferimento. Quest’ultima affermazione, che parrebbe incontestabile anche solo sulla base di un ideale tramandato ancestralmente, in realtà non è sempre facile incontrarlo nel mondo dell’imprenditoria, perché talvolta si assiste alla tentazione di taluni di essi a sviluppare piuttosto relazioni con la sfera politica – quindi, extra-mercato – per massimizzare il ritorno economico dell’azienda. In altre parole, l’“intraprenditore” probabilmente difficilmente accetterebbe sodalizi “extra-imprenditoriale” (vedi con la politica). L’imprenditore storicamente ha messo del proprio – dalle risorse all’inventiva, dalla costanza all’accettazione del rischio – senza ricorrere ad eccessivi “paracaduti statali”. In realtà, non dovrebbe è tanto la cessazione di certe attività di business che dovrebbe preoccupare l’opinione pubblica (in quanto simili fenomeni di “rinnovamento aziendale” ricorrono da sempre nella storia economica) quanto piuttosto la frequente difficoltà da parte della forza lavoro prima impiegatavi a reperire in archi temporali circoscritti impieghi a condizioni lavorativo-remunerative simili. Gli Stati Uniti d’America hanno potuto contare in tempi recenti su un numero più elevato di “intraprenditori”, che si sono perlopiù concentrati sul settore tecnologico-informatico con tutte le conseguenze derivanti da cambiamenti troppo repentini (che ricordano il concetto di “creazione distruttrice” dell’economista austriaco Joseph Schumpeter): è noto che i più grandi colossi di social media, piattaforme di vendita al dettaglio, motori di ricerca o altro non soltanto sono un marchio di fabbricazione americana, ma hanno una storia recentissima. Il messaggio è, dunque, chiaro e forte: l’“imprenditorialità” pare lungi dall’essere smarrita, ma è altretanto evidente che l’Europa nel suo complesso abbia negli anni passati troppo spesso “latitato”, puntando troppo poco su settori economici certamente meno tradizionali (rispetto ad altri più “consolidati” per valore aggiunto), ma capaci di generare un soft power di influenzamento non indifferente della società mondiale. Sul fatto che sia difficile stimare la portata negli anni a venire del settore tecnologico (che ha in gran parte rimpiazzato quello meramente industriale) vi sono pochi dubbi – lo stesso approccio comparato dovrebbe avere luogo anche per l’aspetto occupazionale: rimane, comunque, inalterato il fatto che il Vecchio Continente abbia troppo poco sfruttato il potenziale di crescita derivante dall’investimento in progetti, che rispecchino particolarmente il mood dell’epoca (come, invece, intercettato anzitempo da certi colossi americani dell’informatica). Il rischio paradossale è che, in una società globale orientata al libero mercato, si creino fenomeni di detenzione e rielaborazione semi-monopolistica di dati individuali in capo a pochi attori con un netto sbilanciamento a vantaggio di Oltreoceano. Se il recente fenomeno (anche europeo) delle start-up sia effettivamente una “mossa” sufficiente a ridurre tali squilibri, è difficile da determinare, poiché non è tale etichetta a simboleggiare “vera” innovatività, ma è quest’ultima a dovere caratterizzare il progetto imprenditoriale stesso. Certo è che “fare impresa” rimane una caratteristica imprescindibile delle società post-capitalistiche ed, in quanto tale, debba essere assiduamente aiutata e coltivata, riscoprendo quel carattere di giusta “intraprendenza”, che ha da sempre denotato i pionieri in ambito aziendale. Solo così potranno essere gettate “nuove” basi per una riscoperta della crescita economica “2.0”. Si potranno così avere figure iconiche, che hanno caratterizzato le fasi immediatamente successive alla Rivoluzione industriale. Sarà, però, solo il tempo a decretare chi siano i veri “intraprenditori” del futuro – certo è che questi non potranno essere follower, ma leader illuminati.
Economia
L’“intraprenditore” chiave di rinnovamento economico
18 Settembre 2018