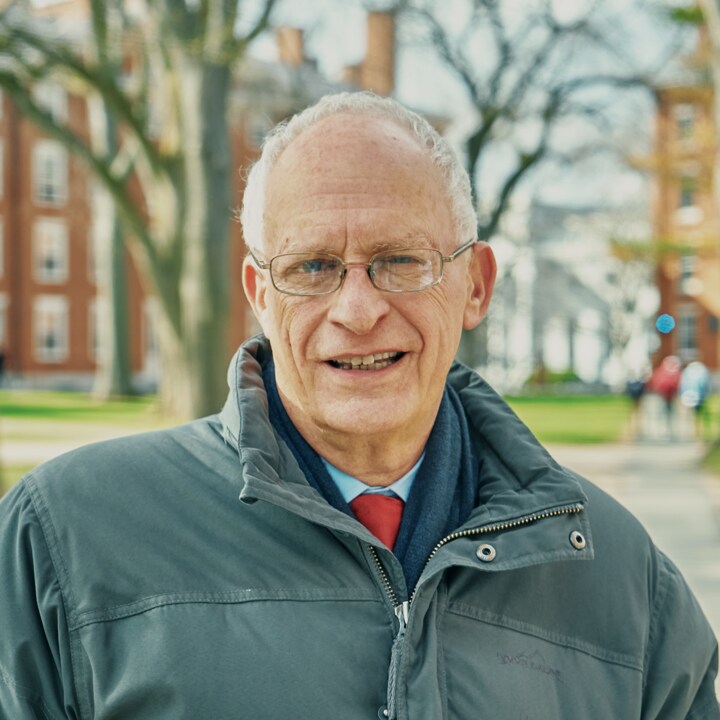Il Consigliere di Stato Norman Gobbi elenca qualche numero: «Storicamente – e qui mi riferisco agli anni ’80 e ’90 – il frontaliere era una risorsa per il settore secondario e le nostre industrie traevano benefici, non trovando manodopera sufficiente sul territorio cantonale. Anche altri settori, nel caso in cui mancasse un profilo necessario all’azienda, avevano la possibilità di accedere a un mercato del lavoro molto più ampio e spesso anche molto qualificato. Gli Accordi bilaterali con la libera circolazione delle persone a partire dal 2005 hanno modificato tutto il quadro di riferimento: sono saltati tutti i controlli preventivi su chi poteva venire a lavorare in Svizzera. Così oggi in Ticino abbiamo 74mila lavoratori frontalieri. Non più solo nel secondario, ma soprattutto nel settore terziario vi è stata un’esplosione di addetti che quasi raggiunto la soglia delle 50mila unità. Da settembre 2020 a settembre 2021, dunque in piena crisi COVID, i frontalieri nel terziario sono aumentati del 5,4%. Sono cifre che devono fare riflettere”.
Che cosa è cambiato dunque in seguito alla pandemia? Per Andrea Puglia del sindacato OCST «la pandemia ha mostrato la fondamentale importanza dei frontalieri nel nostro tessuto economico». Per il suo collega di UNIA Giangiorgio Gargantini, più a lungo in Italia ci sarà crisi, più aumenterà la pressione sul mercato del lavoro ticinese. Ora si parla di ripresa, al di là del confine, e qualcuno, come per esempio Luca Albertoni, direttore della Camera di Commercio Cantone Ticino, ipotizza che si potrebbe perdere parte della manodopera locale. Peraltro anche il nuovo accordo fiscale tra Svizzera e Italia potrebbe rendere lo status di frontaliere meno attrattivo, quanto meno per chi approda da noi per la prima volta.
Che cosa spinge, attualmente, un datore di lavoro a scegliere un dipendente frontaliere? Per Puglia, un mix tra formazione e, purtroppo, questioni salariali. «I frontalieri accettano o tendono a accettare salari al ribasso. Ma al tempo sono qualificati con formazioni di eccellenza, soprattutto quelli operanti nel settore terziario. L’informatica del Mendrisiotto per esempio non ha profili residenti in linea con le skills e i requisiti richiesti dall’azienda». Raimondo Pancrazio dell’Unione Italiana del Lavoro (UIL), aggiunge come «ci siano competenze, per esempio quelle richieste dall’industria, non tutte reperibili sul mercato interno ticinese. Dei circa 8.000 frontalieri provenienti dall’area metropolitana milanese che lavorano in Canton Ticino gran parte sono figure con media e alta professionalità: si tratta di ingegneri, chimici, informatici. Certamente i frontalieri vengono spesso assunti per i salari più bassi, ma anche perché sono portatori di competenze non disponibili nel mercato del lavoro locale».
Cosa ne pensano i datori di lavoro? Con molta trasparenza, chi è stato interpellato ci ha detto quanti frontalieri impiega. Per Andrea Gehri, presidente della Camera di commercio dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Canton Ticino e titolare della omonima ditta di lavorazione, fornitura e posa di ceramiche, mosaici, pietre naturali e artificiali, consulenza di vendita e tecnica, sono «circa 50, un numero che corrisponde a circa il 67% del totale della manodopera impiegata. Sono occupati essenzialmente nel ruolo di posatori, profili da cantiere e gestione della logistica, la maggior parte di loro lavorano da noi da moltissimi anni». Alla casa di riposo Rivabella di Magliaso il direttore Alexandre Alerman parla di «62 frontalieri su un totale di 124 dipendenti. Invece l’azienda farmaceutica IBSA ha il 67% del personale che viene da oltre confine, la metà occupati nella manifattura.
E diversi di loro lamentano di non trovare manodopera ticinese qualificata. «In Ticino il settore farmaceutico occupa circa 3.000 addetti, in Lombardia lo stesso settore ne può contare circa 29.000; va tenuto infatti presente che l’industria farmaceutica italiana e in particolare quella Lombarda è tra le prime al mondo», sottolinea Virginio Cattaneo, Head of Humas Resorces del Gruppo IBSA, secondo cui «il settore farmaceutico in Ticino, per quanto in crescita da diverso tempo, non ha una massa critica tale da generare un mercato del lavoro interno sufficiente a garantire la manodopera che serve alla crescita dell’azienda. Gehri sottolinea come «registriamo in particolare nelle professioni dell’edilizia e dell’artigianato una certa diffidenza da parte dei giovani ticinesi e/o dei residenti ad affrontare professioni di carattere manuale. Riteniamo ciò un vero peccato. Vi fosse manodopera locale, domiciliata, residente che intendesse lavorare nel settore dell’edilizia e dell’artigianato in particolare, ne saremmo molto felici». Per Aleman «il mercato non abbonda di personale sanitario e per le case anziani effettivamente non ci sono risorse a sufficienza». Secondo Pancrazio, «ci sono interi settori in Ticino, a partire dalla sanità che senza i frontalieri non starebbero in piedi. Lo stesso simbolo della Svizzera, i suoi orologi, sono per il sessanta per cento prodotti da lavoratori senza il passaporto svizzero».
Certo, il mercato del lavoro ticinese non è sempre semplice per i giovani, se è vero, come si evince da una ricerca della RSI, che i 9/10 degli studenti oltre Gottardo ritiene che per aspirare a una soglia di benessere sia necessario lasciare il Ticino. «Non diciamo però che i ticinesi emigrano a causa dei frontalieri», ammonisce Gargantini. «Piuttosto, lo fanno a causa delle pessime condizioni salariali offerte dal mercato del lavoro ticinese. La differenza è fondamentale».
Cosa spinge un frontaliere a venire da noi? A.C., una dipendente del settore sociosanitario, centrale appunto in epoca pandemica (Gobbi sottolinea quanto la crisi abbia mostrato la fragilità del comparto, troppo dipendente dal frontalierato), confessa di aver voluto principalmente aiutare economicamente la sua famiglia, ma parla anche di qualità del lavoro. «Sono grata alla Svizzera per l’opportunità. La vita del frontaliere è fatta anche di levatacce e traffico, ma prevalgono i lati positivi. Il nostro lavoro qui in Ticino viene riconosciuto, a differenza di quanto avviene purtroppo in Italia». Sulle condizioni lavorative, Cattaneo specifica: «C’è per i lavoratori di oltre frontiera una oggettiva convenienza a lavorare in aziende ticinesi come la nostra, che offrono condizioni che, a parità di posizione, non troverebbero altrove».
Dunque, tornando alla domanda base, il frontalierato costituisce una opportunità per tutti? Gobbi resta critico. «Non c’è dubbio che il frontaliere sia anche una risorsa, che sia un “buon lavoratore”. Non sta qui il problema. Come ho detto sono le dinamiche che nascono all’interno del mercato del lavoro ticinese in particolare – e pure nella società ticinese – legate al frontalierato a creare problemi. Così come non vi siano dubbi che il frontaliere venga assunto anche per un discorso salariale, altrimenti non saremmo dovuti intervenire come Stato in una ventina di settori economici applicando “d’imperio” dei contratti normali di lavoro». E Marco Chiesa, presidente dell’UDC, invita i datori di lavoro a dare possibilità ai residenti, “che sono padri madri, figlie e figli della nostra società, di avere l’opportunità di lavorare in Ticino ad un salario congruo».
Gli imprenditori però non concordano: «Nei settori dell’edilizia e dell’artigianato non esistono stipendi diversificati tra frontalieri e residenti, ma CCL con classi di stipendio che regolano il grado di formazione e di formazione continua», precisa Andrea Gehri. Senza dubbio il personale italiano è indispensabile per il Ticino, in un’ottica anche di crescita economica e qualitativa. Che qualche criticità ci sia è innegabile come è altresì vero che anche in futuro non si potrà prescindere dalle sinergie con l’Italia in ambito di personale.