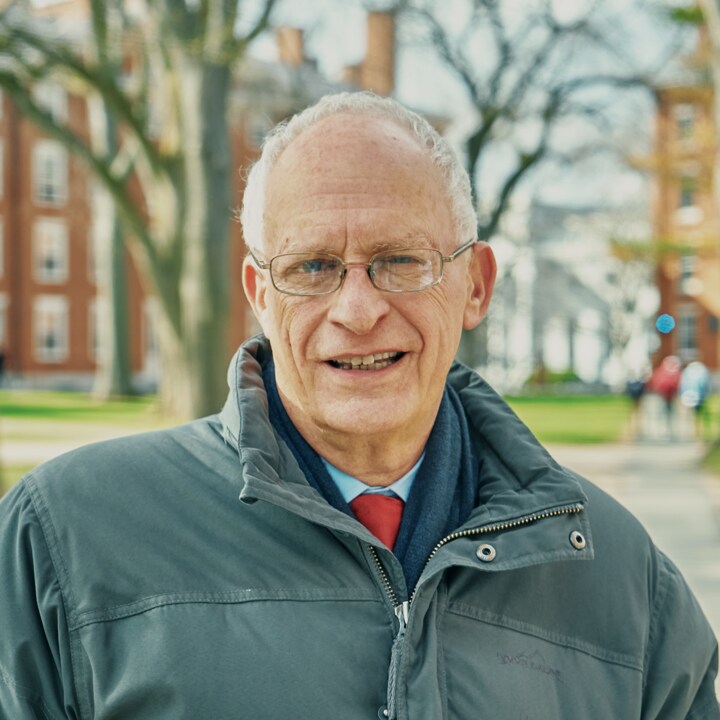Il messaggio di questa 53esima edizione del summit grigionese WEF si può riassumere nelle conclusioni di alcuni dei massimi dirigenti economici presenti alla conferenza finale.
Christine Lagarde, la presidente della Banca Centrale Europea-BCE, ha esordito ricordando il vero problema che minaccia la eurozona: “l’inflazione europea è eccessiva. E la BCE continuerà la sua politica di rialzo dei tassi di interesse”.
Per quanto riguarda le prospettive economiche, secondo il WEF, il 2023 lascia poco spazio all’entusiasmo: “la recessione vissuta nel terzo e quarto trimestre 2022, dovrebbe protrarsi al primo trimestre in corso. Questo non è che l’effetto”, ha proseguito la figura leader della BCE, “di una crescita economica ancora debole: nel 2023 si prevede un modesto +0,5 per cento, contro un complessivo +3,4 per cento del 2022”.
E ancora: “Il problema è noto: l’inflazione la BCE intende ridurla al 2 per cento in tempi brevi, con tutti gli strumenti a disposizione. Abbiamo già aumentato i tassi di interesse di 250 punti base”, ha annunciato la Lagarde, “e proseguiremo sino a stabilizzare l’inflazione al 2 per cento”. È una missione possibile perché “i dati europei sull’occupazione sono positivi”, ha commentato Lagarde: “il mercato del lavoro in Europa non è mai stato così vivace; i disoccupati sono al minimo degli ultimi 20 anni. Ora è nostro compito dirigere la ripresa occupazionale non più a beneficio dei bilanci, ma del futuro della collettività”.
In particolare, ha chiarito la dirigente di BCE, “il tessuto economico europeo deve riconvertirsi ad una transizione digitale e climaticamente responsabile, sfruttando i finanziamenti già stanziati dal governo di Bruxelles”.
“Secondo i numeri della Commissione”, ha puntualizzato Lagarde, “nei prossimi sette anni saranno necessari 500 miliardi di dollari per renderci meno vulnerabili dalle instabilità geopolitiche mondiali”.
Tuttavia, ha aggiunto, “è indispensabile realizzare la Unione Europea del mercato dei capitali che BCE ha già programmato dal 2016; solo così potremo liberare i nostri finanziamenti“.
 Le osservazioni di Lagarde sono state riprese da Kristalina Georgieva, direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale-FMI di Washington, la banca delle 190 banche centrali sparse per il mondo: “la situazione congiunturale è meno negativa di quanto temevamo un paio di mesi fa, ma non per questo è arrivato il momento di abbassare i tassi di interesse”.
Le osservazioni di Lagarde sono state riprese da Kristalina Georgieva, direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale-FMI di Washington, la banca delle 190 banche centrali sparse per il mondo: “la situazione congiunturale è meno negativa di quanto temevamo un paio di mesi fa, ma non per questo è arrivato il momento di abbassare i tassi di interesse”.
“Sarebbe tragico se le banche centrali abbandonassero prematuramente l’obiettivo di assicurare la stabilità dei prezzi; ci troveremmo costretti a combattere questa battaglia per una seconda volta”, ha aggiunto Lawrence Summers, oggi professore alla Harvard Kennedy School of Government, ma già responsabile del National Economic Council, l’ufficio economico della White House di Washington, nel primo biennio della presidenza Obama, ed ideatore della strategia che ha aiutato la amministrazione statunitense ad uscire dalla crisi borsistica del 2008.
Proseguendo l’esame delle prospettive economiche, una delle priorità mondiali resta la de-carbonizzazione, la sostituzione del carbone con le energie rinnovabili.
Gli Stati Uniti l’hanno già decisa.
Tuttavia i finanziamenti milionari varati dalla presidenza Biden a sostegno dell’energia verde alimentano il timore di scatenare una guerra tra USA, Europa e resto del mondo.
Infatti, se da un lato la riconversione ecologica da parte delle economie benestanti ne favorisce la ripresa, al medesimo tempo potrebbe discriminare le nazioni incapaci di aggiornare e “rinverdire” le proprie filiere industriali, e dunque penalizzarle, perché i loro prodotti non sarebbero più conformi ai requisiti di mercato vigenti nelle economie primarie.
“Spero vivamente che questa corsa ai sussidi verdi decisi dai governi non scateni una corsa al ribasso”, a danno delle nazioni più fragili, ha osservato la Lagarde.
Inoltre, l’evoluzione nel segno di de-carbonizzazione anticiperebbe altri problemi: perché molti Paesi potrebbero anteporre la necessità di rafforzare il bilancio statale all’integrazione climatica.
In altri termini, pur di sopravvivere, invece di investire nella de-carbonizzazione le economie emergenti sceglierebbero di produrre ad ogni costo.
Ma ancora: in mancanza di accordi condivisi a livello globale, la decarbonizzazione penalizzerebbe anche le catene di approvvigionamento.
Ad esempio, l’Europa e gli Stati Uniti sono ormai prossimi alla autosufficienza nella produzione di chip di silicio, indispensabili ad ogni attività digitale.
In tal modo le economie dei Paesi in via di sviluppo, di cui proprio le nazioni benestanti sinora sono state i clienti principali, si troverebbero abbandonate al loro destino industriale, climatico, economico e sociale.
 “Negli ultimi tre anni siamo passati da una globalizzazione guidata dal mercato ad una globalizzazione mossa dalla politica”, ha infatti ricordato Bruno Le Maire, Ministro francese dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale.
“Negli ultimi tre anni siamo passati da una globalizzazione guidata dal mercato ad una globalizzazione mossa dalla politica”, ha infatti ricordato Bruno Le Maire, Ministro francese dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale.
Anche l’allentamento delle restrizioni contro la pandemia in Cina solleva interrogativi sulle prospettive economiche 2023, leggasi: inflazione.
Una delle principali incognite infatti resta il prevedibile aumento dei costi che il risveglio economico del gigante asiatico potrebbe causare alla fattura energetica mondiale.
Una ultima osservazione: tutte le previsioni degli economisti si soffermano gli effetti ma non sulla causa delle attuali difficoltà della congiuntura internazionale.
E questa causa, ricordiamolo, ha un nome ed una precisa origine geografica: il conflitto Russia-Ucraina.
Sinché questo dossier non sarà risolto, le amministrazioni pubbliche ed il commercio internazionale non riusciranno ad avviare la resilienza economica tanto attesa a livello globale sia dai partecipanti al Forum di Davos, come anche dalla società civile dell’intero pianeta.