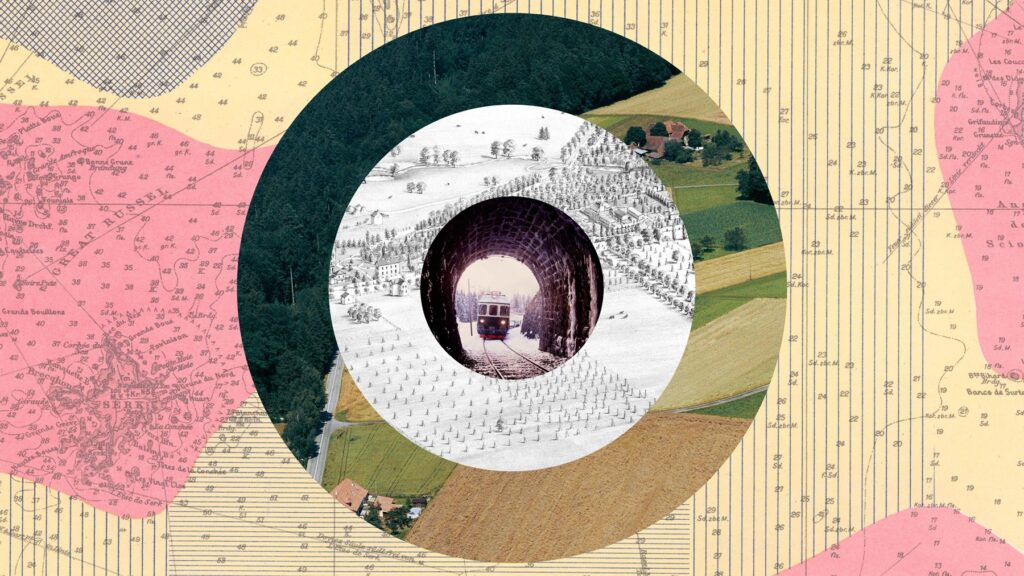Dal 1° febbraio al 24 novembre 2023 la programmazione riunisce le forze delle principali istituzioni musicali della città: LuganoMusica, l’Orchestra della Svizzera italiana, 900presente e la rassegna I Vesperali.
Dal 1° febbraio al 24 novembre 2023 la programmazione riunisce le forze delle principali istituzioni musicali della città: LuganoMusica, l’Orchestra della Svizzera italiana, 900presente e la rassegna I Vesperali.
Secondo uno dei più autorevoli musicologi contemporanei – l’americano Alex Ross – György Ligeti «visse il Novecento, il “secolo della morte”, sulla propria pelle; avendo perso gran parte della sua famiglia nei campi di sterminio di Hitler per poi soffrire ancora sotto il regime stalinista della patria ungherese. Ligeti ebbe comunque l’animo di scrivere musica luminosa e arguta».
Nato il 28 maggio 1923 in Transilvania – in una famiglia di ebrei ungheresi – studiò musica sin da giovanissimo e, sopravvissuto ad alcune delle più crude vicende di metà Novecento (la Seconda Guerra Mondiale, le deportazioni, la Rivoluzione ungherese del 1956) trovò nella Germania dell’Ovest – e nell’accogliente disponibilità di personaggi chiave come Herbert Eimert, Bruno Maderna e Karlheinz Stockhausen – un terreno fertile per radicare e sviluppare le proprie innovative idee attorno alla creazione musicale. Un approccio che – nell’ampio panorama delle musiche d’avanguardia – risultò da subito libero e personale. E in modo unico rispetto a qualunque altro suo collega, Ligeti trovò anche un approdo nella cultura di massa, grazie all’utilizzo di quattro sue composizioni nel capolavoro cinematografico 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick.
Come avvicinamento al centesimo anniversario della nascita di György Ligeti e come introduzione alla sua visione sul mondo della musica e dell’arte – un approccio disincantato e critico che suona molto attuale ancora oggi, a più di vent’anni di distanza – proponiamo l’inedita traduzione italiana di un suo breve testo del 1999, intitolato La nuova musica e il futuro.
«La nuova musica ha sempre avuto difficoltà ad affermarsi. Alcuni compositori del ventesimo secolo devono il loro successo a certe opere che sono diventate popolari per motivi vari e molto diversi – questo per esempio è vero per il Boléro di Maurice Ravel o i tre celebri balletti di Igor’ Stravinskij, che ancora suscitano grande interesse. Ma chi oggi è sinceramente interessato ad altri meravigliosi lavori di Stravinskij, come le Sinfonie di strumenti a fiato del 1920? Per inciso: considero Stravinskij il più grande compositore del XX secolo.
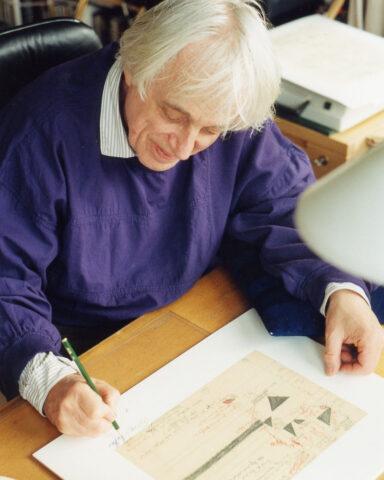
Viviamo in un’epoca in cui l’arte e il suo sviluppo dipendono in larga misura dal mecenatismo. Un artista oggi difficilmente può sfondare da solo. Questo è molto chiaro nelle arti visive, dove i galleristi e i direttori dei musei favoriscono certi artisti e certe tendenze. Quella che oggi viene chiamata “musica contemporanea d’arte” non ha più una funzione sociale. L’autonomia dell’arte del passato – a cui la grande musica deve la sua esistenza, e penso in particolare a Beethoven – è oggi minacciata dall’appiattimento e dalla commercializzazione del mondo musicale, dagli interessi dell’industria musicale e dalla notevole influenza della pubblicità. Il vecchio ideale dell’artista indipendente – un miraggio a cui anch’io sono affezionato – non è infatti compatibile con il mondo attuale del cinema e della televisione, un mondo che a volte produce film di alta qualità, certo, ma dove l’attenzione al profitto è fondamentale. Noto con rammarico che le tendenze della musica contemporanea “colta” – rappresentate da Pierre Boulez, György Kurtág, Conlon Nancarrow e me – stanno diventando sempre meno importanti. Alcune tendenze post- moderne, invece, sono ampiamente accettate: in particolare penso ai minimalisti e ai “religiosi”. Alcuni media spingono e sostengono i “geni”, tra cui in Germania Wolfgang Rihm è il più importante. Infine, una parte della stampa tollera quella certa tendenza dell’arte che si dice impegnata – rappresentata in passato da Luigi Nono – e che vorrebbe vedere il paradiso in terra realizzarsi oggi (per esempio all’Avana…). In quale direzione si svilupperà la musica nel XXI secolo è impossibile da prevedere. Ma temo che il futuro appartenga alla musica funzionale, alla musica d’uso. Le pubbliche relazioni e il marketing, e tutto ciò che porta un immediato profitto materiale, sono già oggi più importanti dell’arte. Sembra addirittura che ci siano piani per accoppiare la produzione di dischi con la produzione di limonate…».
Tutti gli appuntamenti da non perdere

Si comincia mercoledì 1° febbraio alle ore 18:30 con una conferenza gratuita (prenotazione consigliata) nella Hall del LAC dal titolo “L’arte è inutile. Tornate a casa!” – Che cosa era Fluxus?, in collaborazione con il Museo d’arte della Svizzera Italiana. Tobia Bezzola, direttore del MASI, approfondisce la storia di Fluxus, movimento nato alla fine degli anni Cinquanta con il quale Ligeti entra in contatto dopo essere fuggito dall’Ungheria.
Il giorno successivo, giovedì 2 febbraio alle ore 20:30 presso l’Auditorio Stelio Molo RSI, Jean-Guihen Queyras dirige l’Orchestra della Svizzera italiana nel brano di Ligeti Ramifications, in un programma che comprende anche musiche per violoncello e orchestra di Franz Joseph Haydn e Carl Philipp Emanuel Bach.
Doppio appuntamento al LAC sabato 11 febbraio: alle ore 18:30 in Sala Refettorio, per il ciclo Ascoltare due volte, il direttore artistico di LuganoMusica Etienne Reymond racconta i due Quartetti per archi di Ligeti n. 1 Métamorphoses nocturnes e n. 2, eseguiti dal Quatuor Diotima in Teatrostudio per il concerto delle 20:30 insieme a due quartetti di Leoš Janáček.
Domenica 26 marzo alle ore 17:00 la Cattedrale di San Lorenzo ospita il concerto della rassegna I Vesperali, i concerti che ogni anno accompagnano Lugano in occasione della Quaresima: il Coro della Radiotelevisione Svizzera italiana, diretto da Francesco Bossaglia, è impegnato in un raffinato approfondimento della musica corale di Ligeti, con un programma che include Lux Aeterna e le Cantate n. 1 Tenebrae factae sunt e n. 2 Venit Angelus, in prima esecuzione svizzera. A completare il programma il Requiem in memoriam Josquin Desprez di Jean Richafort.
La stessa domenica 26 marzo alle ore 20:30 il percorso continua presso l’Auditorio Stelio Molo RSI con un’incursione nella musica da camera di Ligeti per il quarto appuntamento di 900presente. Diretto da Arturo Tamayo l’Ensemble900 interpreta alcuni tra i lavori strumentali più importanti di Ligeti: il Kammerkonzert e il Doppelkonzert per oboe e flauto, insieme al raro Fragment e alla famosissima Musica Ricercata.
Non poteva mancare la musica per pianoforte, affidata a Gabriele Carcano nel concerto di mercoledì 29 marzo, alle ore 20:30 al LAC per la stagione di LuganoMusica. Pianista torinese tra gli interpreti italiani più affermati della sua generazione, Carcano impagina un programma che si muove tra diversi mondi sonori e che include una selezione degli Etudes di Ligeti.
Ancora un appuntamento sinfonico giovedì 30 marzo alle ore 20:30 al LAC con l’Orchestra della Svizzera italiana, guidata dal direttore ungherese Gergely Madaras in un programma che accosta il Concert romanesc di Ligeti al Concerto per viola di Béla Bartók, solista Maxim Rysanov, alla Sinfonia n. 26 in re minore di Haydn e alla nuova commissione al compositore Oscar Bianchi dal titolo Exordium. Il concerto verrà replicato in tournée sabato 1° aprile alle ore 19:00 a Coira, al Theater Chur, nell’ambito della Biennale Tuns contemporans.
Il ciclo si chiude venerdì 24 novembre, alle ore 20:30 al LAC, con il concerto di 900presente: Francesco Angelico dirige due brani dove le voci sono protagoniste. Accanto a Bölcsőtől a sírig, From the cradle to the grave, brano degli esordi largamente influenzato dal folclore ungherese, si eseguirà il visionario e unico Aventures et Nouvelles Aventures.