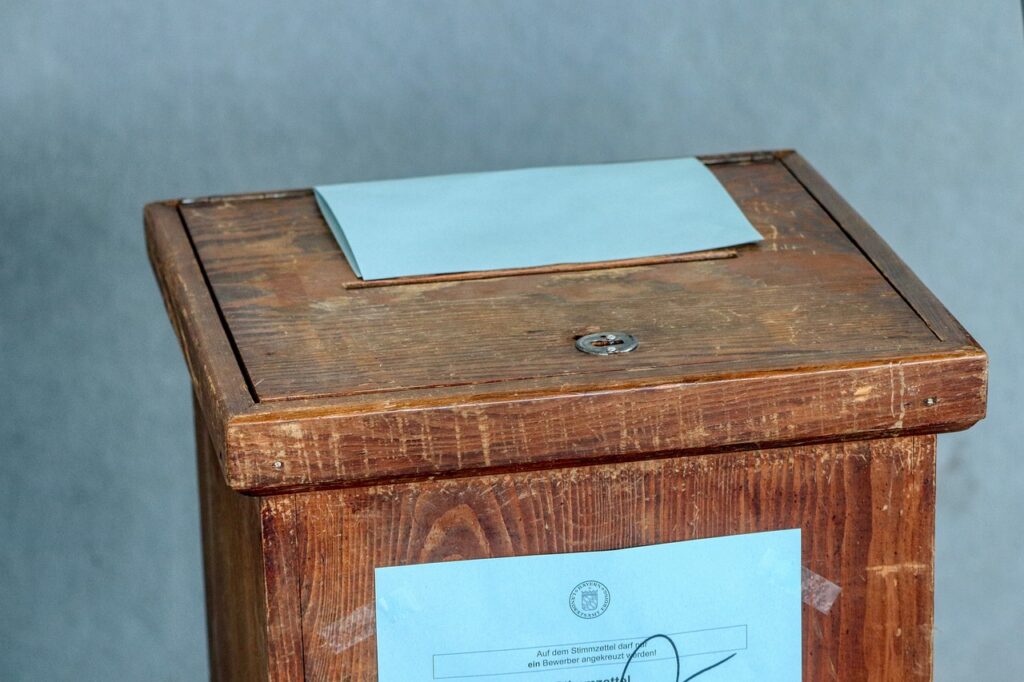Grazie alla catena fulminea multimediale che produce su scala planetaria, può avvicinare un evento catastrofico accaduto a 10.000 chilometri di distanza ingigantendone la minaccia come se stesse accadendo in questo momento davanti a casa nostra. Può indurre a credere che non solo la disinformazione, una calunnia o una menzogna, ma anche una cosa che ha solo l’apparenza di una verità, siano una verità a tutti gli effetti. Oppure può negare lo statuto di esistenza ad un evento per la semplice ragione che non viene menzionato oppure è ignorato – per censura o perché ritenuto non abbastanza sensazionale o troppo differenziato e complesso per diventare virale – da chi governa, gestisce oppure sfrutta il villaggio globale. Tutto ciò accade – afferma Ryszard Kapuscinski – da quando l’informazione viene considerata una merce il cui valore dipende essenzialmente dall’audience più o meno grande che suscita. Da quel momento – aggiungeva – l’informazione ha cessato di essere sottoposta ai tradizionali criteri di verifica e di autenticità. E George Orwell rincarava profeticamente: «Il fatto sinistro è che ormai la censura è largamente volontaria. Idee impopolari possono essere silenziate grazie all’interiorizzazione dei valori del conformismo e al controllo dell’opinione».
Tutto ciò ha un impatto sociale e politico rilevante e sotto gli occhi di tutti. Facciamo alcuni esempi. Nell’era pre-digitale l’incidente alla centrale atomica di Fukushima, in Giappone, non avrebbe creato premesse politiche ed emotive sufficientemente impellenti per spingere in Svizzera Governo, Parlamento e una chiara maggioranza del Popolo a decidere – come invece è accaduto nel 2015 – l’abbandono del nucleare. Con ogni evidenza il fatto che gli impianti nucleari che si trovano qui, sul nostro territorio, garantiscano la massima sicurezza non ha inciso sulla percezione e la ponderazione della minaccia esistente realmente nel nostro Paese. Semmai, chi ha voluto ha potuto approfittare dell’incidente di Fukushima – grazie alla forza d’urto della catena informativa pervasiva del villaggio globale – per favorire una svolta della politica energetica propizia alle fonti alternative. Per rimanere nel campo della causa ambientalista, senza la lente di ingrandimento e la cassa di risonanza planetaria che il web e i social hanno fornito agli allarmi sull’emergenza climatica e al movimento Extinction/Rebellion alla vigilia delle elezioni federali svizzere, i Verdi non avrebbero quasi raddoppiato la loro forza in Parlamento.
Un discorso simile può essere fatto sulla questione migratoria. Se l’UDC in Svizzera ha sfiorato il 30% dei consensi in Svizzera quattro anni fa e se un anno prima era riuscita a far approvare l’iniziativa contro l’immigrazione di massa, ciò non è dipeso tanto o soltanto dalle sue attività di comunicazione in Svizzera, bensì dall’abilità nel cavalcare l’onda di una minaccia d’invasioni migratorie come fenomeno globale. E questo, prima che la questione climatica fosse accreditata dal villaggio globale dell’informazione come la madre di tutte le minacce e prima che il movimento “Metoo” trasformasse il processo ad un produttore cinematografico di Nuova York in una rivolta planetaria femminista contro il genere maschile, considerato predatore a prescindere e – a ruota – aprisse la via alla decisa rivendicazione da parte delle donne di una reale parità salariale e di un’equa rappresentanza ai vertici della politica e dell’economia. La macchina del villaggio globale dell’informazione rappresenta un’arma formidabile che condiziona, nel bene e nel male, l’opinione dei cittadini determinando anche le priorità della politica. Occorre essere consapevoli che – proprio perché retta dalla sola legge dell’audience – questo megafono globale e capillare favorisce anche il rischio di condanne sommarie di individui, gruppi o ceti sociali e la gogna planetaria nonché la diffusione panica di paure apocalittiche anziché suscitare la responsabilità razionale di fronte alla complessità dei problemi da risolvere. In un contesto di forte indebolimento dei corpi politici intermedi (dai sindacati ai partiti interclassisti tradizionali) che facevano da collante sociale e avevano propri strumenti di informazione che offrivano una diversità di visioni, l’anonimo e omologato villaggio globale dell’informazione schiva il problema della responsabilità e si ritrova de facto a favorire la recrudescenza di conflitti sociali anarchici, al posto della ricerca di soluzioni condivise fra gruppi sociali che hanno interessi diversi. Qui sta il punto. Il villaggio globale dell’informazione tende ad assegnare uno statuto indiscusso a visioni settoriali e di parte e talvolta deformate dei fatti (perché semplificate o monche), mentre il mondo della vita reale – a fortiori nell’epoca della globalizzazione – è refrattario alle semplificazioni poiché il paradigma del suo funzionamento è quello della complessità. Il villaggio globale configura un mondo che funziona secondo un principio binario: bianco/nero; bello/brutto; maschi oppressori/femmine oppresse; ricchi corrotti/poveri buoni…Veicola una visione della realtà deformata perché è incapace di rendere la complessità del mondo reale, la quale è sempre differenziata. Social media e algoritmi che orientano la comunicazione degli utenti/consumatori della rete si prestano bene ad una società neotribale in cui i membri del clan vengono pilotati e confortati (radicalizzati?) nelle proprie convinzioni settoriali e ben si attagliano ad attori sociali che si muovono in termini di caricature e contrapposizioni frontali, foriere di conflitti. Mal si confanno, invece, all’esame differenziato dei problemi e alla ricerca di soluzioni articolate e ponderate in mondo globale che sotto un manto apparentemente unitario nasconde in realtà una miriade di circostanze e visioni diverse a dipendenza dell’angolo visuale dal quale si guarda. Credo che se si vuole evitare il rischio dell’anarchia e/o di un’omologazione forzata e autoritaria, occorra stabilire regole di funzionamento del villaggio globale che ripristino il principio di responsabilità. Che non è quello coartato di un mondo artificiale politicamente corretto (la forma di censura o autocensura di cui parlava Orwell), bensì quello basato sul discernimento e sull’aderenza all’autenticità del “mondo della vita” reale, come ammoniva Edmund Husserl.