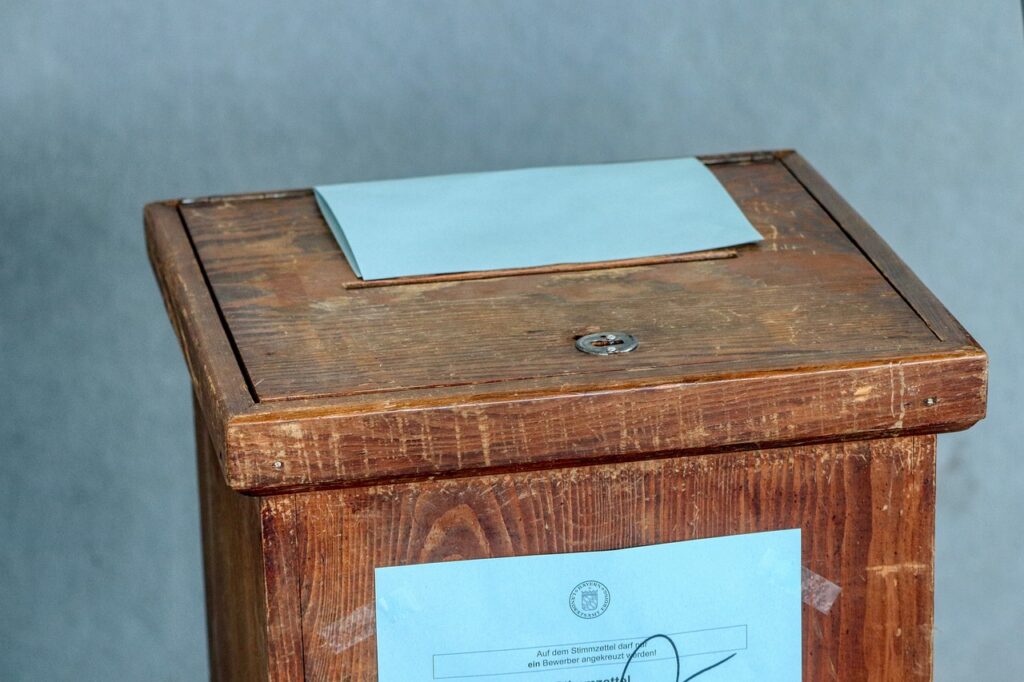Che la cancelliera tedesca Angela Merkel abbia scelto come ultimo grande progetto della sua lunga carriera politica di replicare in chiave europea lo slogan elettorale di Donald Trump (“Make America great again”) ha del clamoroso. Eppure, l’odierna difficile posizione dell’UE nel nuovo contesto geopolitico mondiale è tale da rendere una simile sfida ineluttabile. Se Merkel dovesse vincerla passerà alla storia lavando in qualche modo l’onta e la colpa che la Germania si trascina dalla Seconda guerra mondiale; se la perderà, potrà perlomeno dire di aver tentato il tutto e per tutto per fermare il declino europeo in un mondo da tempo avulso dagli equilibri di Yalta fissati 75 anni fa e ormai in balia di nuovi fortissimi disequilibri e minacce di una nuova guerra fredda e nuove mire imperiali.
Per illustrare ragioni e contenuti dell’ambizioso piano di rilancio europeo (realizzato col sostegno della Francia di Macron), la cancelliera tedesca ha rilasciato una grande intervista pubblica alle testate giornalistiche europee. L’idea portante è che urge ricucire il Nord e il Sud Europa grazie ad un vero e proprio piano Marshall (il “Recovery Fund” post Coronavirus) che permetta in particolare di salvare l’Italia e la Spagna dallo sfacelo prodotto dagli effetti devastanti della pandemia (aggiunti ai dissesti endemici dei Paesi del Sud). A dimostrazione che la Germania pensa e agisce davvero in termini europei, Berlino ha addirittura accettato – dopo decenni di fredda inflessibilità di fronte ai Paesi della finanza allegra e dell’indebitamento facile – di abbandonare il principio del rigore dei conti per entrare in una logica di sussidi. Sembra incredibile, ma il “Recovery fund” da 750 miliardi proposto da Berlino (insieme a Parigi) per ricucire la frattura fra Nord e Sud Europa rompe con la politica dei soli prestiti e prevede 390 miliardi di sussidi, in buona parte a favore dell’Italia e della Spagna.
Come si spiega un simile, radicale cambiamento di mentalità della Germania? Nell’intervista, Merkel lo spiega così: «Vista la misura diversa con cui i Paesi europei sono stati toccati dalla pandemia, anche la ripartizione degli aiuti va fatta secondo una chiave diversa rispetto a quella della normale gestione finanziaria dell’Unione. Per Paesi che hanno già un indebitamento elevato, nuovi crediti sono meno sensati rispetto a dei sussidi. In una situazione come quella generata dalla pandemia, è richiesto che la Germania non pensi solo a se stessa ma sia disposta ad un atto straordinario di solidarietà. La Germania ha una quota di indebitamento ridotta e in questa situazione straordinaria può permettersi di aumentarla».
Generosità gratuita? Con onestà intellettuale, Merkel precisa che «naturalmente agiamo anche nel nostro interesse. È nell’interesse della Germania avere un forte mercato interno: fare in modo che l’UE si rafforzi e non cada a pezzi. Ciò che è bene per l’Europa, era ed è bene per la Germania». Da queste parole si capisce bene che in gioco c’è la sopravvivenza stessa dell’Eurozona e dell’Unione. Per l’UE l’ora è grave. Non tanto a causa della pandemia: quest’ultima ha semplicemente portato la costruzione europea ad un “redde rationem”.
Ma la risposta è adeguata alla sfida? Il nuovo Piano Marshall europeo è certo un’iniziativa di grande rilievo e l’obiettivo di ricucire Paesi del Nord e del Sud Europa è lodevole (a fortiori, vista la clamorosa mancanza di solidarietà fra gli Stati europei durante il picco della pandemia). Ma per rifare grande l’Europa basterà un’operazione finanziaria gigantesca basata essenzialmente su un aumento del debito comunitario? La vera domanda è probabilmente la seguente: l’Europa ha la forza per “rifarsi grande” da sola nell’attuale contesto geopolitico mondiale? Essa ha infatti potuto risollevarsi dalle macerie della seconda guerra mondiale e diventare la potente Eurozona economico-finanziaria che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni grazie al Piano Marshall (l’European Recovery Programm) varato nel 1947 dagli USA, nonché grazie agli Accordi di Yalta e alla presenza militare dell’Alleanza atlantica NATO per difenderla militarmente e fare da argine alle mire imperialiste sovietiche.
La riunificazione della Germania dopo il crollo dell’URSS e del muro di Berlino e – a ruota di questi cambiamenti geopolitici fondamentali – la nascita dell’Unione europea, sono certo il segno di una forte volontà di garantire un nuovo futuro pacifico e solidale agli Stati europei, ma senza le premesse geopolitiche summenzionate (e la permanenza della NATO) tutto ciò sarebbe stato possibile? L’UE non è stata fin qui un polo geopolitico indipendente. Può diventarlo oggi, in un contesto di equilibri e disequilibri planetari totalmente mutati? Non ne sono sicuro. Benché a prima vista l’UE sembri oggi condannata a fare di necessità virtù, muovendosi senza stampelle. I legami transatlantici non sono mai stati, infatti, così disastrosi.
Il progetto di Partenariato transtlantico per il commercio e gli investimenti è fallito nel 2016: respinto fieramente da Francia e Germania, era sparito dal radar dell’agenda politica americana già durante la campagna elettorale di Hillary Clinton. Con Donald Trump le cose sono peggiorate ancora: la guerra dei dazi e la volontà americana di ridurre drasticamente i finanziamenti alla NATO sono lì a dimostrarlo Ma indipendentemente da Trump, negli USA la percezione della cosiddetta ‘’eredità comune” si è andata perdendo, anche perché da almeno un paio di generazioni l’immigrazione negli Stati Uniti non è più europea ma asiatica e latino-americana. Con lo spostamento dello scontro di influenze dall’Atlantico (e dal Mediterraneo) al Pacifico, gli interessi degli Stati Uniti nel Vecchio Continente è scemato. Un interesse che si affievolisce ulteriormente dopo che il più atlantico e storicamente filoamericano dei Paesi europei, il Regno Unito, ha divorziato dall’UE.
Ma senza una presenza militare forte dell’Alleanza atlantica alle proprie frontiere orientali, l’UE attuale – priva di un esercito comune altamente performante – come farebbe? Come farebbe oggi a far fronte alla politica aggressiva del nuovo Zar, Putin (da cui è fortemente dipendente dal punto di vista energetico) e a quella forse ancor più insidiosa del nuovo Sultano, Erdogan, intenzionato a ripristinare il vecchio Impero ottomano (come dimostra emblematicamente la decisione di ritrasformare l’antica basilica bizantina di Santa Sofia in moschea)? In questa fase storica di grandi incertezze, l’Unione europea sembra sotto assedio ad Est ma anche a Sud: il problema dei migranti e dei rifugiati dal Nord Africa è fuori controllo ed è fattore di divisioni profonde fra gli Stati membri. Senza parlare dell’espansionismo economico della Cina in Europa che la Nuova via della Seta intende sancire.
Nel nuovo contesto di una minacciosa e incombente nuova Guerra fredda fra gli Stati Uniti e la Cina e di rinnovate mire imperiali russe e turco-ottomane, il rischio è che un’Europa meno atlantica, più continentale e velleitariamente indipendente, non diventi più forte e grande bensì finisca per ridursi suo malgrado a territorio di conquista. Qualcuno pensa che con Joe Biden alla presidenza USA le cose potrebbero cambiare. Forse. Biden è certamente un sostenitore del multilateralismo più di quanto non sia Trump. Ma è bene tener presente il fatto che oggi come oggi non solo i Repubblicani ma anche i Democratici ritengono la sfida con la Cina (considerata uno Stato canaglia totalitario e inaffidabile, capillarmente presente con la propria tecnologia digitale e con i propri sistemi di intelligence nei gangli del tessuto economico mondiale) la questione più importante per il futuro degli Stati Uniti. E che sia il Pacifico (e non più l’Atlantico e tanto meno il Mediterraneo) lo scenario geopolitico di questo scontro. Al di là dei sogni di grandezza, l’UE non potrà non scegliere: o con gli USA e i suoi alleati del “Five Eyes” oppure con la Cina.