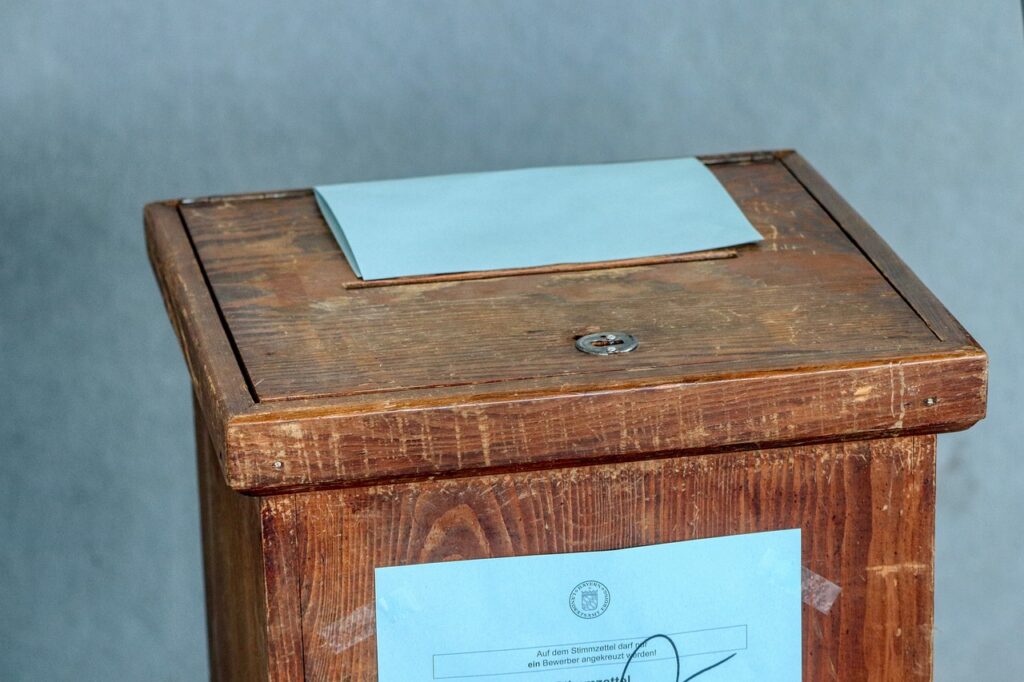Da quasi due anni lei ha iniziato il suo terzo mandato come Consigliere nazionale. Quali sono i dossier che intende prioritariamente affrontare nei prossimi mesi?
«Questa crisi ha scompaginato agende e priorità anche politiche, ed evidenziato le nostre fragilità. Riguardo al futuro sono piuttosto pessimista. Ci stiamo muovendo su un territorio assolutamente inesplorato, da cui traggo la percezione dell’arrivo di una crisi economica ancora più devastante di quella del 2008, che occorrerà affrontare con misure di rilancio, ma anche con politiche di sostegno per persone e realtà economiche che sono sfuggite sinora alle maglie degli aiuti economici decisi dal Consiglio federale. Dall’influenza spagnola che falcidiò il mondo tra il 1916 e il 1918, ne derivarono politicamente molte dittature, ed economicamente la crisi finanziaria del 1929. Memore di questi errori del passato il mio impegno come Presidente dell’Unione arti e mestieri sarà incentrato sul sostegno alle PMI svizzere ma anche a correggere le diseguaglianze. E qui interviene il partenariato sociale, cui tengo molto perché una delle prerogative della Svizzera ed elemento importante del suo successo. Nel quadro di questa collaborazione tra lavoratori e datori di lavoro vengono negoziate, spesso senza l’intervento del legislatore, le condizioni di lavoro di un settore o di un’azienda a livello bilaterale e, se necessario, regionale. Ciò permette di trovare soluzioni flessibili e specifiche per un settore o una regione, che si basano su un mercato del lavoro liberale e tengono conto della realtà economica. Quindi più che dei dossier, noi politici abbiamo davanti un grosso cantiere di ricostruzione economica e sociale».
Quali sono i problemi aperti nell’economia e nella società ticinese che la pandemia ha messo in luce o accentuato?
«L’ho ricordato nel mio intervento di commiato dalla presidenza AITI del 27 aprile scorso. La pandemia da Covid-19 ha evidenziato alcune fragilità del tessuto economico cantonale. I dati statistici di inizio anno ci dicono che siamo il Cantone che più di altri ha sofferto per la pandemia, e non solo in termini sanitari: abbiamo perso più impieghi di altri cantoni svizzeri e abbiamo annullato più di 3000 impieghi femminili, a fronte dei 100 maschili. Nella maggior parte – va detto – distribuiti nel settore terziario. Un record in negativo che non ci fa onore come società e come imprenditori, e che per giunta cade a 50 anni dall’introduzione del suffragio femminile. Il segnale è di quelli che preoccupano e ci invita ad affrontare il problema quanto prima anche e soprattutto perché riguarda il settore terziario. Per questo ritengo molto pericoloso costruire il nostro rilancio economico nel dopo Covid senza tener conto di questi oltre 3000 impieghi persi, delle ineguaglianze tra uomo e donna nel mondo professionale, tra fasce sociali e tra generazioni. Tantopiù che le rilevazioni sullo stato della popolazione segnalano che la stessa è diminuita per tre anni consecutivi. Una tendenza che impatterà in modo sistemico su tutti gli altri ambiti della nostra società: prima diminuiscono i bambini, poi gli adolescenti ed infine la forza lavoro. A ciò si aggiunge una flessione della migrazione dall’estero ma anche da oltre Gottardo. È accertato che una società in decrescita demografica fa esplodere l’invecchiamento della propria popolazione con tutte le conseguenze del caso: sistemi pensionistici in difficoltà, scarsa attrattività di una società di anziani, costi della salute in aumento… Ma anche modifica le proprie risorse e crea nuovi bisogni, rendendo indispensabile una riorganizzazione a livello di mercato del lavoro e dell’utilizzo del nostro territorio. È pericoloso continuare a fondare le nostre decisioni in base a scenari di espansione, quando la popolazione diminuisce! Siamo di fronte a un problema serio e molto complesso. Credo che tutti noi, attori politici ma anche economici, dovremo seriamente interrogarci per capire le ragioni che stanno facendo perdere attrattività al nostro Cantone e soprattutto valutare cosa dobbiamo fare per invertire questa tendenza»
Lei è alla guida di un importante gruppo industriale. A suo giudizio è stato fatto abbastanza, a livello federale e cantonale, per sostenere le imprese e cosa si augura venga ancora promosso?
«Non si può dire che non si è fatto niente, ma di sicuro all’interno della rete degli aiuti diverse realtà sono passate fra le maglie. Con il senno di poi per gli indipendenti occorreva fare di più. In questo periodo le indennità di lavoro ridotto fungono da salvagente, soprattutto nella prima fase dello scorso anno quando i sostegni erano rapidi e agevolati. Quest’anno si è invece pasticciato molto, complice anche il federalismo. Ma sarà nel dopo-pandemia che i veri problemi verranno a galla, costringendoci a ripensare il nostro tessuto economico, persino quello industriale. La pandemia ha messo ad esempio a nudo la nostra dipendenza dall’estero, persino per la produzione di semplici mascherine e di vaccini nonostante siamo la nazione che accoglie la sede delle principali industrie farmaceutiche. Credo che dopo anni di delocalizzazione questa pandemia ci costringe a ragionare su un modello alternativo che ci agevoli l’accesso ad alcuni beni essenziali, come ad esempio le materie prime, di cui la Svizzera è povera. Non sto dicendo che dobbiamo internalizzare ad esempio l’estrazione del litio, la cui domanda è in forte aumento per la fabbricazione di batterie elettriche, quanto piuttosto che occorrerà moltiplicare i siti di produzione affinché non si riproduca la situazione di penuria e dipendenza vissute. Questa crisi pandemica è l’occasione unica per noi imprenditori del settore industriale per dimostrare che c’è ancora futuro nel patriottismo economico (da non confondere con il “primanostrismo”), sostenuto da una produzione industriale che si basa su una manodopera qualificata, su un sistema di formazione invidiato dall’estero grazie ai quali siamo in grado di produrre sul nostro territorio prodotti innovanti e di qualità, a prescindere dal momento congiunturale, dalle pandemie e da quanto ci impongono dall’estero. Sono convinto che noi siamo ancora in grado di dimostrare di saper fare cose nuove, competitive, belle in grado di affascinare il mondo».
Quale ritiene debba essere il modello di sviluppo del Ticino dei prossimi anni, per continuare ad assicurare adeguati livelli di benessere a tutta la popolazione?
«Guardo con interesse e curiosità al progetto di organizzazione territoriale Greater Zürich Area, che prevede la collaborazione tra Svizzera tedesca e italiana, con opportunità di collaborazione tra mondo accademico e industriale sull’asse Ticino-Lombardia. Tuttavia, affinché abbia delle ricadute concrete su tutta la popolazione del Ticino, bisogna rendere attrattivo il nostro territorio per industrie e personale qualificato. Purtroppo i dati del rilievo demografico cantonale indicano curve in rallentamento, una tendenza molto preoccupante in una prospettiva di sviluppo economico, e sulla quale si potrà intervenire solo mettendo in campo misure organiche a sostegno della formazione, dell’innovazione industriale e di nuovi processi lavorativi a sostegno della conciliabilità lavoro e famiglia».
Lei è membro dal 2014 del Consiglio di amministrazione dell’HCL. Come è nata e cresciuta questa sua passione per l’hockey luganese?
«Essendo nato e cresciuto nel locarnese, a quell’epoca a livello hockeistico il tifo era praticamente monocolore, ovviamente biancoblù. Nella mia classe dell’elementare era la stessa cosa e quindi quasi tutti i miei compagni erano tifosi dell’Ambrì. Io trovavo questa cosa piuttosto strana e siccome già allora non mi piaceva seguire acriticamente il mainstream decisi di diventare tifoso degli odiati “cugini” sottocenerini. La cosa non fu priva di conseguenze, anche perché sono sempre stato un tifoso piuttosto focoso: nel migliore dei casi venivo considerato una sorta di traditore ma a volte le discussioni sfociavano addirittura anche in zuffe, soprattutto nei pre- e post-derby in cui ero quasi sempre soccombente vista la disparità delle forze in campo (in definitiva ero solo contro tutti!). Ricordo anche la prima volta che andai alla vecchia Resega (eravamo agli inizi degli anni settanta) in curva nord, che ho poi frequentato per diversi anni: da quel momento è definitivamente sbocciato l’amore per l’HC Lugano che poi nei decenni a seguire ha saputo regalarmi grandi soddisfazioni, con alcune inevitabili delusioni. Fra le prime annovero ovviamente i sette titoli nazionali ai quali sono sempre stato presente in prima persona, mentre fra le seconde sicuramente le tre finali perse in casa in gara 7 con lo Zurigo, il Berna e ancora lo Zurigo. Certo che non avrei mai immaginato che la passione la mia squadra del cuore mi avrebbe addirittura portato ad entrare a far parte del CdA del HC Lugano. Quando Vicky nel 2014 mi chiamò per chiedermi se fossi interessato, e di questo la ringrazio ancora, ne fui molto onorato».
Tra i suoi interessi nel tempo libero indica anche la caccia. Cosa risponde a quelle fasce di popolazione che vorrebbero arrivare una totale abolizione dell’attività venatoria?
«Ci tengo innanzitutto a chiarire che io non considero la caccia un hobby o un passatempo. La caccia è per me una grande passione, la mia più grande passione, e mi spingerei quasi a definirla una filosofia di vita. Contrariamente a ciò che molti pensano, la caccia non si limita allo sparo, ma è molto di più: non a caso si parla di arte venatoria. Anche se può sembrare paradossale, il cacciatore è un amante della natura con la quale instaura un rapporto quasi di simbiosi. Per far capire cosa intendo vorrei riportare una citazione di un filosofo-cacciatore spagnolo in cui mi identifico, che disse: “io non vado a caccia per uccidere, uccido perché vado a caccia”. Fatta questa premessa è innegabile che si percepisce da parte di taluni ambienti, provenienti soprattutto dalle aree urbane, una pressione accresciuta per voler abolire l’attività venatoria. Dico subito senza mezzi termini che sarebbe un grave errore per almeno due motivi. Il primo è che la caccia ha una funzione regolatoria per alcune specie problematiche, in particolare il cinghiale e il cervo, senza la quale profilerebbero in modo incontrollato con conseguenze che si possono facilmente immaginare (già oggi il Ticino paga annualmente ca. 1 mio. di franchi per danni alle colture provocati da queste due specie). Il secondo è che una caccia con regole chiare e severe, come quella che viene praticata in Svizzera, è sostenibile e quindi giustificata. Per questo essa deve essere mantenuta, perché rappresenta una testimonianza di una tradizione e di una cultura rurale che fanno parte della nostra storia e che stanno purtroppo vieppiù disparendo. E questo sarebbe un vero peccato».