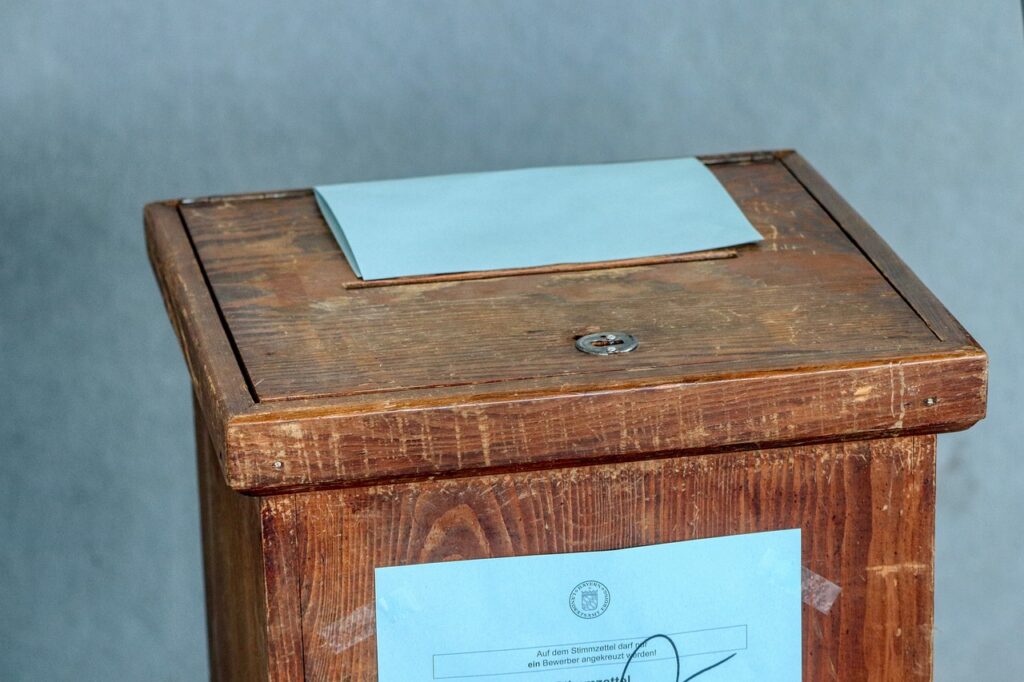Che importanza riveste la sede di Lugano?
«Lugano appartiene alla ristrettissima categoria dei consolati di prima classe, come Shangai, New York, Hong Kong. La Confederazione è l’unico paese che ne ha due: Zurigo e Lugano. Sono sedi che, per motivi storici e culturali, la Farnesina, il Ministero degli Esteri italiano, riserva a funzionari con il grado di ambasciatore: io lo ero a Bratislava, in Slovacchia. La funzione di Ministro plenipotenziario equivale al grado di generale nella gerarchia militare».
Come è iniziata la sua carriera diplomatica?
«Sono nato a Milano ma, oltre che svizzere, ho origini anche toscane, da cui il mio cognome Meucci, che è molto popolare in quella regione. Dopo il dottorato in diritto, mi sono perfezionato prima all’Istituto per gli studi di politica internazionale-ISPI di Milano, e poi in materie economiche alla Università di Bologna. Arrivato a Roma, esordii, insieme a Silvio Mignano, oggi ambasciatore italiano a Berna, alla Direzione del personale presso il Ministero degli esteri. È stata una esperienza che, oltre a gestire le risorse umane di un ufficio, mi ha subito familiarizzato con la applicazione in ambito diplomatico internazionale dei provvedimenti legali decisi nella capitale italiana».
Successivamente, come si è andata sviluppando?
« Ho iniziato a Spalato, in Croazia, che a metà degli Anni Novanta dopo una guerra fratricida iniziava ad aprirsi al mondo. Quindi sono stato trasferito ad Ottawa, la capitale federale del Canada, ed in seguito, tra il 2001-2003, a Tirana, in Albania, che già allora era un paese in grande sviluppo. Tornato a Roma fui assegnato alla Direzione affari europei, occupandomi di un gruppo di paesi con cui l’Italia ha frequenti relazioni: Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, ma anche San Marino e Città del Vaticano. La mia funzione era di spiegare ai corrispondenti presso le cancellerie estere la applicazione delle normative emanate dal governo della Repubblica, chiarendone la portata teorica e le conseguenze pratiche. La mia carriera poi è proseguita in ambito giuridico, sempre alla Farnesina, con la nomina all’Ufficio Rapporti con il Parlamento italiano. In particolare, grazie a questo nuovo incarico ho seguito i lavori della Commissione affari esteri dei due rami del Parlamento di Roma, occupandomi anche delle attività conseguenti, come ad esempio la ratifica dei trattati con paesi esteri. Comprendere il funzionamento della macchina politica italiana rimane alla base del mio lavoro. Anche perché, in Italia come altrove, la evoluzione delle decisioni politiche puo’ risultare imprevedibile».
Quali altre esperienze ha avuto modo di maturare?
«Arrivai in Montenegro nel giugno 2006, pochi giorni dopo la dichiarazione indipendenza del paese. Dal 2009 al 2014 invece fui assegnato a Berlino, nel periodo della crisi del debito pubblico greco e del debito italiano, di cui in particolare mi occupai come responsabile dell’ufficio politico presso la nostra rappresentanza diplomatica nella capitale tedesca. Proprio le esperienze che ho accumulato a Berlino oggi mi convincono che, dopo la pandemia, la prossima sfida che i paesi europei si troveranno a vincere sarà di impiegare nel modo migliore i prestiti che riceveranno dal governo di Bruxelles. Concluso il mio incarico in Germania, tornai a Roma per iniziare a seguire il sindacato dei diplomatici. Rispetto ad altri, il nostro ministero non può vantare grandi numeri: abbiamo solo 900 unità, concentrate alla Farnesina, la nostra unica sede».
Lei ha svolto anche incarichi per il governo di Bruxelles…
«Dal 2014 al 2016 i rappresentanti degli stati membri della UE, ovvero il Consiglio Europeo, mi nominò a capo della missione europea Eulex a Pristina; era l’epoca della indipendenza del Kossovo dalla Serbia. Questo incarico concentrava le funzioni di responsabile delle attività giudiziarie e di polizia, ma anche il coordinamento di un contingente di 1500 militari inviati dalla comunità internazionale. La mia carriera poi è continuata ancora nell’Europa orientale, come ambasciatore a Bratislava, in Slovacchia».
Le sue origini sono in parte svizzere…
«Il padre di mia madre era zurighese. Dopo la laurea al Politecnico di Zurigo, negli anni Trenta si trasferì a Milano come responsabile degli stabilimenti aeronautici della Brown Boveri. Era un calvinista, orgoglioso alle sue origini confederate, tanto che a mia madre diede il nome di Elvezia e, nel dopoguerra, la mandò ad Olten presso uno zio attivo nella industria tessile. Ancora oggi i parenti ricordano che alcuni tratti del mio carattere sono ispirati dalla personalità di mio nonno, persona organizzata, rigorosa e precisa».
Come si trova a Lugano?
«Quando ho accettato di trasferirmi già ne conoscevo la importanza strategica. Nella città del Ceresio mi sento a casa, anche perché i miei familiari continuano ad abitare nella vicina Milano. In queste settimane ho in programma di visitare le autorità locali presenti nel territorio. Dopo il Governo Cantonale, incontrerò i sindaci delle città, per poi visitare il Conservatorio, le varie istituzioni culturali e la Università. Dal punto di vista artistico il Ticino è di una ricchezza strepitosa ed i rapporti culturali fra i due paesi sono intensissimi. Come in passato, il Consolato Generale d’Italia a Lugano conferma la sua disponibilità a sostenere le iniziative ticinesi che necessitano di un coordinamento istituzionale. Penso ad esempio alle aziende elvetiche interessate a partecipare alle rassegne commerciali in Lombardia e in Italia. Tra la Svizzera e l’Italia i rapporti sono già consolidati, ed i nostri uffici sono pronti ad amplificarne la portata. Rimaniamo sempre disponibili a risolvere anche altre problematiche, come accaduto nel 2020, nelle primissime fasi della emergenza sanitaria mondiale, in occasione della richiesta avanzata dalle autorità svizzere al governo italiano per non interrompere l’afflusso negli ospedali ticinesi di personale infermieristico italiano».