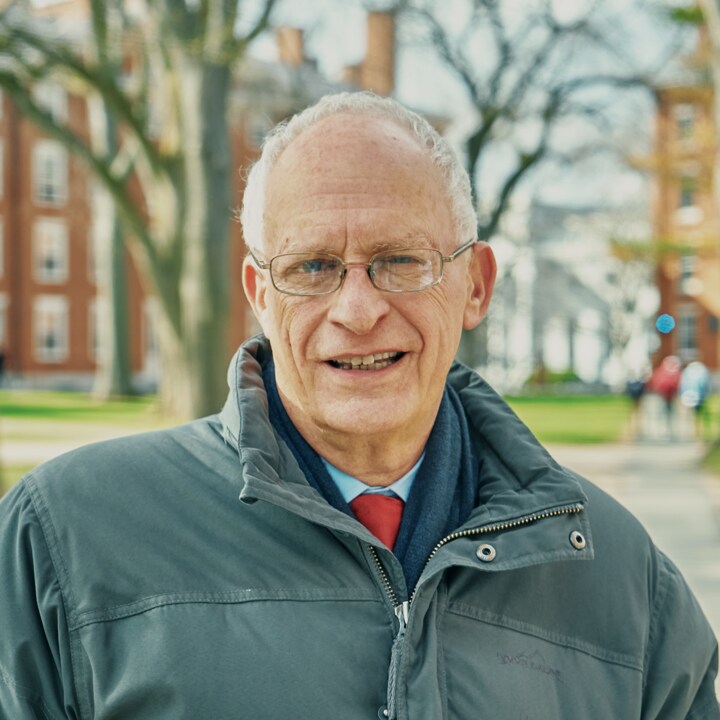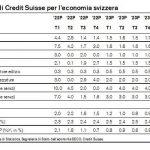“Gentlemen Joe” ha raggiunto la vetta di qualsiasi settore in cui si sia cimentato. Più volte è finito in prima pagina per il suo modo di affrontare pubblicamente le questioni più ostili del nostro tempo. Con schiettezza brutale discute di argomenti come il cambiamento climatico, le crisi finanziarie, l’eurozona e la crescita del divario tra ricchi e poveri. I suoi articoli sono stati pubblicati sul Financial Times ed è stato intervistato praticamente da ogni rete televisiva sul pianeta. L’economista è un leader nel pensiero, e la sua mente brillante è accompagnata da elevati standard morali: quando parla dei difetti dei mercati dà voce alle fasce più povere della popolazione.
Come è possibile convincere le persone che l’egoismo non aiuta nessuno?
Secondo Stiglitz, le disuguaglianze sociali a livello mondiale sono la radice dei peggiori conflitti in ciò che chiama la nostra “economia mal governata”. L’egoismo peggiora le condizioni anche degli egoisti stessi.
Perché dovremmo pagare il conto per gli altri?
L’economista punta il dito contro l’1% della società, secondo lui responsabile del crescente divario tra ricchi e poveri. «Vi faccio un esempio», dice raddrizzandosi nella sedia per parlare dell’allentamento quantitativo, ossia dell’immissione di denaro contante nell’economia da parte di una Banca centrale di un determinato Paese. «Capisco il motivo, ma pensate a ciò che determina: praticamente l’economia viene inondata di liquidità, e la percentuale degli investimenti sul PIL diminuisce, facendo aumentare i prezzi delle azioni. E chi vince quando aumentano i prezzi delle azioni? Coloro che le possiedono. Ma chi sono? Sono persone ai vertici, ovviamente. Cosa succede ai poveri pensionati che dipendono dai titoli sovrani per la pensione? Per loro, i tassi d’interesse sono diminuiti. Questa politica non ha favorito la crescita, ma le disuguaglianze».
Perché non siamo in grado di creare posti di lavoro per chi cerca un’occupazione?
Stiglitz si concentra sulle statistiche più che sull’acclamato sviluppo economico. «Negli Stati Uniti, il reddito delle persone della fascia media è inferiore rispetto a 25 anni fa e il reddito medio di un lavoratore a tempo pieno è inferiore paragonato a 40 anni fa, mentre il valore reale degli stipendi più bassi è minore rispetto a 60 anni fa». L’economista è poi molto critico nei confronti dei politici che osannano i programmi di welfare. «Queste persone non vogliono dipendere dallo stato, vogliono guadagnarsi da vivere lavorando. E nonostante ciò, il nostro sistema economico li ha delusi. Hanno ragione a essere arrabbiati».
Chi ha provocato la crisi finanziaria?
Stiglitz ritiene che questa rabbia, la rabbia di coloro che si sentono ignorati, sia una ripercussione sociale naturale di un mercato che non funziona. Il caso più recente è rappresentato dalla crisi finanziaria del 2008, e quando si cerca di trovare un responsabile, Stiglitz non ha dubbi: «Le mie teorie avevano già spiegato perché la regolamentazione era così importante, e poiché uno dei principali problemi del mercato finanziario era raccogliere informazioni, non potevamo aspettarci che il settore della finanza funzionasse a dovere. Chiunque abbia studiato la storia sapeva che si era comportato ripetutamente in maniera non corretta. Di conseguenza, a mio avviso, gli economisti che affermavano non esserci alcun bisogno di regolamentazione, erano in parte colpevoli della deregolamentazione che ha permesso ai banchieri di operare in maniera così scellerata».
È possibile creare un mondo più equo?
Stiglitz ritiene che la situazione non si possa risolvere dall’oggi al domani, ma che esista un programma in grado di ripristinare una forte crescita dell’economia. E ora più che mai ne abbiamo la necessità, dato il numero, in costante aumento, di cittadini che si sentono esclusi e che ripongono speranze nei partiti di destra.
Abbiamo già scritto le regole per rendere l’economia più ingiusta. «E ora è nostro dovere riscriverle per rendere l’economia più giusta. Dobbiamo dare ai lavoratori più diritti di negoziazione, limitare il potere delle grandi multinazionali e creare una migliore governance aziendale. Dobbiamo limitare il potere del settore finanziario, che è cresciuto dal 2,5% all’8% del PIL senza alcuna prova di un aumento della produttività nella nostra economia e, al contrario, sono numerose prove di una maggiore instabilità e disuguaglianza».
Da dove viene il suo interesse verso i più poveri?
Nato nel 1943, solo pochi anni dopo la Grande Depressione, Stiglitz ha trascorso la sua infanzia a Gary, nell’Indiana, una città industriale povera e caratterizzata da discriminazione razziale, livelli elevati di disuguaglianza e, sporadicamente, disoccupazione. Furono i suoi genitori a incoraggiarlo a fare qualcosa di buono a favore di tutti i membri della società.
Stiglitz vinse una borsa di studio completa per l’Amherst College, dove inizialmente voleva a tutti i costi studiare fisica. In seguito, si accorse che conseguire una laurea in economia sarebbe stato il modo migliore per combattere le disuguaglianze sociali, e pertanto iniziò a lavorare al suo dottorato presso il Massachusetts Institute of Technology.
Dopo aver studiato e vissuto personalmente recessioni, depressioni e crisi finanziarie, Stiglitz è riuscito a minare alla base l’assunto secondo cui i mercati funzionano sempre. A suo parere, ciò è dovuto al fatto che operano con informazioni imperfette o asimmetriche; in altre parole, nei mercati esiste una parte che dispone di maggiori o migliori informazioni dell’altra. Questo, conclude, è stato uno dei principali fattori a contribuire alle disuguaglianze economiche. Grazie alla sua ricerca, nel 2001 è stato insignito del Premio Nobel con George Akerlof e Michael Spence. Insieme, i tre ricercatori hanno dato forma a una scuola di pensiero alternativa che ha inciso profondamente sul campo dell’economia.
La globalizzazione ha causato sofferenza?
Con l’aiuto della sua teoria economica che gli è valsa il Nobel, Stiglitz ha scoperto ulteriori lacune nel sistema e ha trovato possibili soluzioni per colmarle. Il suo studio passa costantemente dalla micro alla macroeconomia e viceversa. «Paesi diversi si trovano in differenti situazioni e occorrono norme di base che si possano applicare ovunque. I Paesi in via di sviluppo devono essere in grado di perseguire i propri obiettivi, e sono convinto che dobbiamo applicare regole globali legate al cambiamento climatico: ad esempio, se inquini non puoi commerciare. Non puoi vendere a noi beni prodotti nelle tue fabbriche che contribuiscono al riscaldamento globale».
Come possiamo fare in modo che la globalizzazione vada a beneficio di tutti?
Se si chiede a Stiglitz come riesce a focalizzarsi su tutti i vari problemi del futuro della nostra economia, egli ricorda un momento cruciale della sua vita. Washington D.C., 28 agosto 1963: Stiglitz è stata una delle 250.000 persone presenti di fronte al Lincoln Memorial per udire Martin Luther King pronunciare le sue celebri parole “I have a dream.” «Fu un momento unico, un momento non fatto di un semplice discorso, ma di fede nella democrazia degli Stati Uniti». L’economista, però, diventa pensieroso quando ammette che il sogno di King è ben lontano dall’essersi realizzato. «Non penso che si fosse reso conto appieno di quanto le cose sarebbero peggiorate in termini di divario economico. Il suo discorso è, in un certo senso, una pietra miliare della nostra storia e qualcosa che tutti noi dobbiamo considerare quando riflettiamo sul futuro del nostro Paese».
Qual è la cosa più importante che le persone devono imparare?
Questo momento di introspezione emotiva viene subito interrotto dall’assistente, che gli ricorda il meeting in programma con altri professori. Stiglitz sfrutta l’ultimo momento per dare consigli alle nuove generazioni e condividere un messaggio importante imparato dai suoi genitori. «Per prima cosa, mi hanno detto: “i soldi non ti daranno mai la felicità”. Poi hanno aggiunto: “Dio ti ha dato un cervello formidabile. Usalo”. E in conclusione: “Sii al servizio degli altri”». Queste parole sono la base del suo successo? «Penso che sia stato un mix di precetti morali e di idealismo. La cosa importante erano le proprie idee e cosa se ne voleva fare. E forse un pizzico di temerarietà».
Per gentile concessione di UBS
Le crisi non hanno mai un solo colpevole
Di Paul Donovan
All’indomani di ogni grande turbolenza economica si tende a cercare un unico colpevole, un capro espiatorio che si faccia carico di ogni responsabilità. Ciò è conveniente perché si creano una narrativa semplice e una soluzione altrettanto semplice: se una cosa è sbagliata, vi si pone rimedio e il problema non si ripresenterà mai più. L’insidia di questo approccio è che è incompleto. Le crisi sono eventi complessi con cause anch’esse complesse, e puntare il dito contro un singolo capro espiatorio può indurre in una pericolosa noncuranza quando altre cause del problema vengono trascurate.
Joseph Stiglitz ritiene giustamente che il settore bancario sia stato la causa più importante nella crisi finanziaria del 2008/2009; non c’è dubbio che i collaboratori delle banche abbiano commesso enormi errori. Tuttavia, colpevolizzare unicamente gli istituti bancari che premono per deregolamentare e fidarsi di nuove regolamentazioni come antidoto contro crisi future sembra un’interpretazione troppo semplicistica dei fattori che contribuiscono allo scoppio di una crisi.
L’idea che le banche abbiano perseguito all’unisono l’obiettivo comune della deregolamentazione (che a sua volta ha causato la crisi) presuppone un livello di allineamento e coordinazione che non può esistere solo in riferimento a coloro che lavorano nel settore. È vero che le banche volevano la deregolamentazione, ma anche molti politici sposavano quest’ideologia; il ciclo del credito favoriva la prosperità, e la prosperità piace sempre agli elettori. I politici sono addirittura arrivati al punto di criticare duramente le banche perché non facevano abbastanza per prestare denaro ai lavoratori a basso reddito negli anni precedenti la crisi. Alle banche era stato detto di smettere di usare “misure irragionevoli per l’affidabilità creditizia”, e arrivavano minacce di multe per quelle che si rifiutavano di prestare denaro a determinati gruppi a basso reddito.
Tutto ciò non nega il fatto che le banche e l’insufficiente regolamentazione abbiano contribuito alla nascita della crisi, ma ponendo l’attenzione solo sugli istituti bancari e ignorando o esonerando altri fattori si rischia di creare un’altra crisi. I media e i politici hanno spinto le banche a correre rischi, che probabilmente si sono rivelati eccessivi, e la società ha incoraggiato i mutuatari a prendere in prestito somme di denaro irrealistiche. Questi sono fattori che devono essere considerati.
Il mondo si ritrova ancora una volta di fronte a un evento economico di grande complessità. La pandemia ha accelerato cambiamenti strutturali nell’economia globale, generando ciò che gli economisti chiamano la quarta rivoluzione industriale. Tali cambiamenti si ripercuoteranno su alcune fasce della società; la sfida consisterà nel ridurre al minimo i danni personali ed economici che un cambiamento strutturale può causare. Le soluzioni non saranno certamente facili, e servirà ben più della sola regolamentazione per cercare di rendere i benefici economici il più inclusivi possibile.