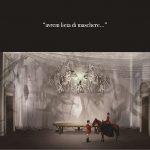Lei è entrato in carica il 1 gennaio 2018 e fin dalle sue prime dichiarazioni ha parlato della necessità di internazionalizzazione del MASI. Che cosa significa di preciso?
«Inserire il MASI all’interno del panorama delle istituzioni internazionali è il primo obiettivo che ho voluto porre al centro del mio programma di attività per i prossimi anni. Il MASI, nato dalla fusione del Museo Cantonale e del Museo d’Arte di Lugano ha delle grandi potenzialità, ma è ancora un museo troppo poco conosciuto soprattutto al di fuori dei confini territoriali. Siamo in una fase di costruzione di un’identità: non dobbiamo pensare che la fusione tra il Museo Cantonale e quello cittadino fosse la fine di un percorso, era soltanto l’inizio. Se pronuncio la sigla MaASI, nessuno sa di cosa parlo (fuori del Canton Ticino); non è così invece quando dico MoMA. È insomma un brand ancora tutto da costruire. Il mio sogno, nel giro di alcuni anni, è che nel mondo la sigla MASI venga identificata subito con il Museo d’Arte della Svizzera italiana, come avviene oggi per gli altri musei più importanti».
Come è possibile raggiungere questo importante traguardo?
«Per far crescere il MASI ho tutta l’intenzione di fare ricorso alla rete di relazioni e di contatti che ho costruito in tanti anni di carriera. Sono, infatti, profondamente convinto che la collaborazione sia la strada da percorrere per garantire fama e sostegno al museo. Prima di tutto le collaborazioni con artisti e collezionisti, ma anche con le altre istituzioni museali. Questo garantirà al MASI la possibilità di elaborare progetti di ampio respiro altrimenti irrealizzabili. Ancora oggi c’è chi chiede espressamente di tornare alle grandi mostre che un tempo garantivano la coda sul lungolago di Lugano, fuori da Villa Malpensata. Viviamo in un mondo in cui le istituzioni museali non possono più legittimarsi soltanto attraverso il lavoro di ricerca, di conservazione o di restauro. Essendo spesso finanziati da soldi pubblici, i musei devono essere pensati anche per il grande pubblico e non unicamente per gli specialisti. Le mostre di richiamo sono quindi necessarie, l’importante è capire semmai come debbano essere fatte. È la qualità a fare la differenza, anche quando ci sono in ballo nomi di artisti famosi. Bisogna mettere a fuoco un tema forte, poi viene il nome. Sono quindi convinto che si debbano (e si possano) pensare delle mostre capaci di attirare grandi quantità di visitatori, senza rinunciare per questo a ricerche originali. Dobbiamo avere il coraggio di cambiare il nostro modo di pensare a un artista: guardare la sua opera in una prospettiva nuova, diversa, laterale, è sempre interessante, si posso avere belle sorprese. Credo sia una condizione ideale per lavorare con serietà e originalità».
Dunque nel suo lavoro la collaborazione internazionale rappresenta una condizione imprescindibile…
«Le mostre si fanno sempre (sempre) con l’aiuto degli altri, con la loro collaborazione e generosità. Un curatore da solo non fa una mostra. Artisti e collezionisti saranno portati a collaborare a un progetto tanto più questo è forte e solido. Si presta più volentieri un’opera quando si ha la certezza che questa venga poi inserita in un contesto adatto, magari anche con uno sguardo innovativo. La solidità di un progetto, cioè la “scienza”, non è sufficiente per allestire una grande mostra. Ci sono sempre molti interessi in ballo. Il sistema dell’arte oggi è molto complesso. Se chiedi in prestito un’opera, molto facilmente ti imporranno di prenderne anche un’altra, assieme alla prima, che a te non interessa per nulla (ma devi farlo, prendere o lasciare)».
Possiamo delineare quali saranno le linee guida del suo programma culturale…
«Al di là di quanto già anticipato alla stampa, e cioè una grande mostra dedicata all’arte svizzera, quello che posso dire è che il mio programma non punterà solo sull’arte contemporanea ma sarà pluridisciplinare, quindi indirizzato anche al teatro, alla musica, alla danza non solo alle arti visive. Grande aiuto, in questo senso, arriva dagli spazi del LAC, un museo naturalmente votato alla multidisciplinarità grazie al teatro interno e a grandi spazi condivisi”.
Lei è nato a Berna, ma le sue origini sono ticinesi…
«Sono nato a Berna, è vero, ma Comologno, in Valle Onsernone, è sempre stato un nome importante per me: per il semplice fatto che era scritto sul mio passaporto, come luogo di origine della mia famiglia. Mio padre e mio nonno, pur abitando a Berna, facevano parte di un’associazione di ticinesi. Insomma la Svizzera italiana non mi è mai stata del tutto estranea, anche se devo dire che ho iniziato a conoscerla soltanto negli ultimi anni, per ragioni diverse, anche professionali. Già durante gli studi ho avuto occasione di incontrare e conoscere molti ticinesi, sia a Berna che a Zurigo. Con alcuni di loro ho ancora dei contatti. A Comologno invece sono stato una volta sola, perché dopo la morte di mio nonno, mio padre ha venduto la casa e non ci sono più state occasioni».