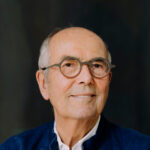La filantropia, in termini culturali e storici, è spesso associata alle grandi religioni: dalla zedaqah del mondo ebraico alla zaqat musulmana fino alla tradizione del mecenatismo artistico-culturale e dell’aiuto umanitario cristiano. Quanto incide la componente religiosa sulla sfera della moderna filantropia?
La filantropia, in termini culturali e storici, è spesso associata alle grandi religioni: dalla zedaqah del mondo ebraico alla zaqat musulmana fino alla tradizione del mecenatismo artistico-culturale e dell’aiuto umanitario cristiano. Quanto incide la componente religiosa sulla sfera della moderna filantropia?
«Carità e filantropia sono cose diverse. Vi sono motivazioni profonde che spingono il mecenate, e le convinzioni etiche e religiose sono fra queste, insieme ad eventi di tipo biografico, passione per un tema particolare o desiderio di ricordare una persona scomparsa. La motivazione religiosa è una delle più frequenti, anche se la situazione può mutare a seconda dei contesti culturali. Tuttavia la semplice elargizione verso il prossimo è un riflesso del rapporto con l’entità trascendente se non addirittura una prescrizione, come nel caso della zaqat islamica. Per filantropia intendiamo invece tutte quelle attività, ad opera di privati, finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone o al raggiungimento di obiettivi di interesse generale, come il sostegno alla cultura, alla salute, all’inclusione, all’istruzione, all’innovazione sociale» (cfr. Italia Non Profit).
Si dibatte spesso sul dualismo filantropia tradizionale-filantropia strategica. In cosa quest’ultima è più rispondente al contesto attuale?
È forse più corretto distinguere oggi la filantropia tradizionale, sovente spontanea ed orientata a sostenere progetti limitati, e filantropia sistemica, che si pone invece l’obiettivo di sostenere progetti rivolti a risolvere in modo innovativo e sostenibile la soluzione di un problema, mettendo tutti gli stakeholder di quella specifica area intorno ad un tavolo. Ambedue le forme di filantropia hanno un senso e possono coesistere, anche se nel primo caso il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi è più alto. Dal canto suo la filantropia sistemica è orientata all’impatto, misura gli effetti dell’azione e finanzia sulla base dei risultati ottenuti. Questi aspetti sono importanti ed andrebbero adattati a quella parte dell’universo non-profit il cui funzionamento risulta spesso insoddisfacente, proprio perché non inserito in un contesto strutturale».
Verso quali aree tematiche si orienta prevalentemente la filantropia religiosa e comunque ad orientamento etico?
«I settori oggi prevalenti sono quelli legati alla lotta alla povertà, alla tratta di esseri umani ed alla schiavitù, alla migrazione, al contenimento della violenza, allo sviluppo dell’istruzione, della salute globale e del clima».
Chi sono i filantropi religiosi?
«La filantropia religiosa vanta una storia antichissima. Già ai tempi del Buddha, 2500 anni prima di Cristo, ne troviamo traccia, ad esempio con riferimento all’uomo d’affari Anathapindika, il laico che, pur non essendo membro della comunità monastica, finanzia il primo monastero buddhista. I filantropi di oggi sovente provengono spesso da famiglie con una lunga tradizione al servizio della fede, colpite da vicende particolari, convertite o ispirate da personaggi eccezionali, particolarmente attente ai temi etici ed alla vita spirituale. Vi sono poi persone mosse da una molla spirituale anche se non necessariamente religiosa. Come ricorda John Mc Caffrey, Presidente di Galileo Foundation, in questo numero, sono personalità di tutto il mondo che si vanno riunendo in reti globali per rispondere alle grandi sfide sociali».
Come risente la filantropia dei megatrend imperanti, come ecologia, social responsability, oltre che delle transazioni generazionali?
«Di certo è particolarmente attenta ai temi caldi ed attuali della nostra società. La pandemia ha cambiato molte cose, focalizzando aspetti come digitalizzazione o rapidità delle trasformazioni, determinando nuove urgenze. Un’importante funzione di sensibilizzazione e di orientamento è svolta in questo senso da consulenti, family officer, gestori patrimoniali, che individuano e selezionano i progetti. Le transazioni generazionali sono una grande sfida, e la maggior parte delle famiglie coinvolge i giovani, fin dalla più tenera età, nelle attività filantropiche che esse perseguono. In essi si nota uno sguardo più critico, una voglia di rinnovamento che si esprime in vari modi. Non è raro, ad esempio, che giovani imprenditori coinvolgano attivamente nelle attività filantropiche anche i loro collaboratori».
La filantropia è condizionata dall’evolversi degli scenari geopolitici ed economici, e dall’andamento dei mercati finanziari?
«La filantropia risente del quadro economico, ma prevalentemente a livello nazionale. Se consideriamo le grandi entità attive a livello globale, l’effetto di una crisi è trascurabile in termini di risultato finanziario, anche in un “annus horribilis” per i mercati come il 2022, e può al contrario diventare il catalizzatore di una maggiore attività. In un’economia sempre più finanziarizzata, si pone certamente la questione della compatibilità fra fondi derivati da attività speculativa ed uso filantropico. Oggi si diffondono strumenti e percorsi nuovi, all’insegna dell’impact investing e della finanza etica. Quanto all’aspetto geopolitico, vi è attenzione a nuovi temi, come l’immigrazione. In alcuni casi, quelli di Stati con regimi totalitari, vi può essere un lato oscuro, cioè il rischio che l’azione filantropica risulti strumentalizzata in chiave politica a favore di questo o quel regime. A maggior ragione cresce quindi la responsabilità di persone, quali i grandi leader spirituali, nel promuovere un dibattito etico profondo sul ruolo dei filantropi e sui limiti della filantropia stessa».
I grandi leader spirituali non si sono mai pronunciati sulla filantropia pubblicamente. È un’occasione mancata?
«Direi proprio di sì. Le grandi organizzazioni religiose vivono anche del contributo dei filantropi, ed i loro finanziamenti costituiscono il 36% delle donazioni globali. Il fatto che i leader spirituali non abbiano promosso un dibattito più attivo su questi flussi è sorprendente, anche se ho l’impressione che qualcosa stia cambiando. Molti sarebbero i tempi da dibattere, come le condizioni quadro, il contenimento degli sperperi, la focalizzazione degli interventi…Vi è poi chi demonizza la filantropia accogliendo il suo denaro, e questo risulta a dir poco irritante».
A tale riguardo, cosa pensa delle forme di filantropia collettiva e della creazione di “reti” di cui si sente parlare di recente?
«Il sistema delle alleanze non può che risultare positivo: alleanze di visione, di temi e settori fra diversi soggetti filantropici che avviano collaborazioni. Si potrebbero evitare sovrapposizioni nel campo d’azione, scambiarsi esperienze e generare sinergie, migliorare il rapporto con le istituzioni pubbliche, indirizzare meglio i fondi disponibili, ed altro ancora. Oggi la culla dell’associazionismo filantropico sono gli Stati Uniti, ma l’onda lunga sta giungendo anche in Europa, soprattutto declinata al femminile e proprio lo scorso ottobre è nata a Roma la rete Faith and Philanthropy».
Si può, magari un poco provocatoriamente, considerare almeno una parte degli interventi filantropici come “succedanei” di carenze e di mancati interventi da parte di Governi ed istituzioni pubbliche?
«In alcune aeree del mondo, il rapporto con le autorità locali va ottimizzato. I filantropi mettono a disposizione volentieri capitali di rischio, se i beneficiari lavorano con le Autorità per mantenere attivi i progetti finanziati e farne fruire il più persone possibili. Meglio se si avviano modelli di collaborazione innovativi che si possano poi replicare. In ogni caso le sfere operative fra funzioni filantropiche e compiti dei Governi dovrebbero rimanere distinte. La filantropia non può e non deve sostituire le istituzioni pubbliche».
Nella filantropia quanto assume rilievo l’aspetto fiscale?
«Nella filantropia strutturata l’aspetto fiscale non è, a mio parere, la ragione di fondo per cui un filantropo decide di donare. Se riportiamo l’attenzione sulla Svizzera, quello che l’Autorità di una certa giurisdizione, nazionale o cantonale che sia, può fare, è semplificare procedure ed adempimenti, favorendo i flussi dei fondi verso le attività cui sono destinati. Comunque in Svizzera nasce una nuova fondazione filantropica al giorno, un segno questo che la Confederazione ha saputo creare le condizioni quadro giuste ed è stata sempre in grado di riconoscere i segni dei tempi».
*Dr. Elisa Bortoluzzi Dubach, consulente di Relazioni Pubbliche, Sponsorizzazioni e Fondazioni, è docente presso varie Università e istituti superiori in Svizzera e Italia e co-autrice fra gli altri del volume «La relazione generosa-Guida alla collaborazione con filantropi e mecenati ».