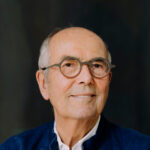Quanta importanza ha la comunicazione nella filantropia?
«È essenziale. La comunicazione ha un peso specifico diverso a seconda dei diversi ambiti. Basti pensare al suo ruolo nel comparto finanziario, ove fake news ed informazione distorta arrivano a generare vistose manipolazioni dei mercati. Tuttavia di questo esiste ancora scarsa consapevolezza, mentre se ne recepisce l’importanza in altri ambiti, quali a titolo di esempio il ruolo delle nuove tendenze della comunicazione sulla creazione di valori e sul comportamento giovanile. Ma nella stampa generalista (e talora anche di settore) il tema della comunicazione in filantropia, della scelta e del peso del linguaggio utilizzato, del suo influsso nella relazione fra mecenate e beneficiario, fra mecenate e istituzione, nello spostamento di capitali filantropici, ha trovato poco spazio».
Quali sono le cause di distorsione, o di disfunzione della parola, che possono avere un effetto sulla relazione filantropica, e in generale sul mercato della filantropia?
«Il primo caso può essere quello della parola falsa, cioè che oggi si suole definire come fake news. Si può ad esempio prendere un certo evento e generalizzarlo. Lo scandalo legato ad un filantropo diventa lo scandalo di tutto il mondo filantropico, con evidenti ricadute sugli investimenti e sul senso di sicurezza degli ambienti interessati. Il secondo punto concerne la parola usata inappropriatamente, generando divisioni e perdita di fiducia. Si prende un gossip e lo si amplifica pretestuosamente. In un mestiere come il nostro, in cui il rapporto umano riveste un ruolo centrale, certe parole creano divisioni, alimentano generalizzazioni banali, mentre nel settore è di importanza capitale l’aspetto relazionale e la creazione di un solido rapporto fra le parti. Capita di comunicare senza rispettare il principio della riservatezza, o di fornire informazioni che non sono comunque necessarie. Gran parte dei clienti giunge a noi attraverso chi già ci conosce, ed il silenzio assume un valore significativo. Un errore clamoroso di comunicazione che spesso si osserva consiste ad esempio nel diffondere troppo presto informazioni in merito ad una campagna di raccolta di capitali a favore di un progetto filantropico, creando una pressione sia su chi chiede sia su chi dà. L’uso della parola deve essere misurato, anzi centellinato come qualcosa di importante se non addirittura prezioso, alla stregua di un vino pregiato od un profumo raro ed esclusivo. Il silenzio ha un suo ruolo esclusivo, come silenzio arricchente, per ascoltare, sapere, capire, non per giudicare. Vi è poi l’aspetto della “parola gentile”. Se in altri contesti la gentilezza è sì cosa piacevole ed auspicabile ma non essenziale, nel nostro lavoro essa è “tutto”, tanto da determinare le sorti della relazione».
Come le modifiche del linguaggio e del lessico, l’intrusione della “neolingua”, Inglese ma non solo, influenzano la vostra comunicazione?
«Questo è un elemento centrale. Ho sempre pensato che è un valore aggiunto significativo, esprimere contenuti complessi in modo accessibile. A tiolo d’esempio l’Inglese è entrato dappertutto, con una terminologia che al comune cittadino risulta spesso incomprensibile. Di fronte a termini come Effective Altruism, Mission related investment ecc. il lettore non specialista si arrende o rimane confuso. Usare una certa terminologia “fa chich”, altrimenti si appare incompetenti. Io penso invece che la comprensibilità sia tutto nella comunicazione di un fenomeno che per sua natura è già estremamente complesso. Basti pensare come negli articoli della stampa generalista si faccia un’enorme confusione fra il mondo delle fondazioni, quello del mecenatismo individuale e quello dello sponsoring. Qui la differenza non é terminologica, ma di essenza, perché il mercato delle fondazioni è più del mecenatismo individuale e più del mercato dello sponsoring. La chiarezza terminologica è fondamentale, i neo-anglicismi aggiungono confusione terminologica. Accade così che Bill Gates diventi il filantropo per eccellenza, ma quest’ultimo non è certo rappresentativo del panorama italiano e men che meno di quello svizzero».
Come si adatta la comunicazione ai diversi contesti culturali, religiosi, etnici, sociali?
«È una questione primaria, perché il quadro religioso e culturale cambia l’approccio alla tematica. Consideriamo il contesto cattolico, in cui domina il termine “benefattore”. Il contesto culturale influenza fortemente alla base l’impostazione stessa della relazione tra filantropo e soggetto ricevente. Direi di più, influenza nel loro insieme i comportamenti sociali legati alla filantropia. Il termine generosità, collegato al mondo buddista per es., ha una valenza completamente diversa dallo stesso termine così come viene inteso nel mondo cattolico, in quanto il mondo buddista prevede tutta una serie di comportamenti a diversi livelli, alla cui cuspide sta il filantropo. Se poi consideriamo la cultura islamica, la zakat, cioè la donazione per i benestanti, più che un atto di generosità è una vera e propria norma regolata giuridicamente. Ecco perché il contesto culturale condiziona la filantropia sia in termini comportamentali e sia nell’uso terminologico. Risulta dunque del tutto fuorviante generalizzare: la filantropia in un Paese del Golfo o dell’Asia non ha alcuna somiglianza con quella italiana o svizzera. E tutto questo va poi considerato alla luce dei diversi quadri giuridici, che possono favorire o meno la filantropia. In Svizzera abbiamo una situazione per certi versi ideale, anche per quanto riguarda i filantropi, persone molto facoltose che vivono felicemente e svolgono la loro attività senza particolari problemi di eccesso di visibilità».
L’età del filantropo e del beneficiario influenzano la comunicazione?
«Assolutamente sì. Anche in questo bisogna essere molto attenti. Se, a titolo di esempio. scrivo ad un fondatore avanti negli anni, con un’attività filantropica in Inghilterra, che possiede un’immagine di status elevata, mi esprimerò in modo diverso rispetto a quando scrivo ad un collega quarantenne che lavora per una fondazione erogativa italiana. Anche qui il contesto culturale, insieme all’età, entra in gioco nel definire status e “distanza sociale”, condizionando anche la scelta del linguaggio, il “tono” del testo e la lunghezza del messaggio. In Europa, quando i filantropi non sono fondatori ma persone molto facoltose, di solito sono sopra i 60 anni, ed hanno staff che si occupano degli aspetti comunicazionali e dei social media. In generale per prendere contatto con queste persone è preferibile utilizzare la lettera tradizionale rispetto all’e-mail».
Nel tempo della cosiddetta “correttezza politica”, talvolta esasperata, soprattutto in materia di genere, la vostra comunicazione ne viene influenzata?
«Sì, ne ho avuto prova io stessa al momento della pubblicazione di alcuni miei articoli in tedesco. Mi sono state chieste modifiche terminologiche che esasperano il linguaggio e rischiano di rendere certi passaggi incomprensibili. Sono una donna e mi sono sempre battuta per i diritti della donna, ma mi pare che talvolta si presti più attenzione alla forma che non alla sostanza delle cose. Sarebbe meglio un atteggiamento sostanziale, pragmatico, piuttosto che toni esasperati destinati a complicare i rapporti».
Quale rapporto tra filantropia e nuovi mezzi di comunicazione?
«Premetto che la filantropia si avvicina ai social media a passi tardi e cauti. Ha un po’ di problemi con questi strumenti, per svariate ragioni. Sono usati per conferenze in rete o per la pubblicazione di articoli. Ma veicoli quali Facebook, Instagram, Telegram e simili richiedono cautela e non appaiono troppo adatti alle nostre attività, e peraltro stanno vivendo un momento un po’ difficile. Potremmo dire in sintesi che non si addicono all’eccellenza, alla qualità del nostro lavoro ed all’atmosfera particolare in cui essa prende forma. Per noi la scelta del contesto si rivela essenziale, ed in quei mezzi troviamo sovente messaggi urlati, vituperio, aggressività. La scelta delle parole si rivela invece per noi fondamentale nella doppia relazione filantropo-beneficiario e beneficiario-filantropo, con un humus di calma, tranquillità, fiducia reciproca, chiarezza su progetti ed interventi, il tutto attraverso un linguaggio adeguato, conciso ma esauriente e rigoroso nella sostanza. Le parole spingono il filantropo verso la scelta, sempre evitando un atteggiamento di dominanza. E se anche sorge un motivo di dissenso, se il piano proposto non appare attuabile o nascono fattori di squilibrio, l’eventuale dissenso va manifestato in modo gentile. Nei social media troviamo purtroppo spesso contrapposizioni esasperate e sovente neppure argomentate. Ricordiamo invece che anche nella dialettica e nella contrapposizione di idee, proposte, punti di vista, fiorisce la creatività, fattore essenziale delle relazioni filantropiche».
Mondo della filantropia e della finanza sono in stretto contatto, ma con stili di comunicazione molto diversi fra loro. Come conciliarli?
«Spesso si tratta semplicemente di “tradurre” i linguaggi, le mentalità, gli approcci. É ciò che caratterizza il nostro lavoro: dobbiamo essere veloci e versatili nel passare, ad esempio, da un contesto artistico ad uno scientifico, gestendo al contempo il rapporto col mondo finanziario da cui si traggono le risorse. In più dobbiamo verificare che comportamenti e strumenti finanziari impiegati siano corretti ed in linea con lo spirito di ciò che si vuole realizzare. Non mancano gli esempi di istituzioni con comportamenti non ottimali in termini sociali, ambientali o di governance, ma la cui comunicazione appare invece cristallina. Al riguardo, possediamo criteri di controllo abbastanza raffinati.
Da queste brevi considerazioni si può ricavare quanto la comunicazione sia importante nell’attività filantropica e quanto le sue sfaccettature, gli adattamenti ai vari contesti, i suoi contenuti e le loro modulazioni possano contribuire al successo delle nostre iniziative».
Dr. Elisa Bortoluzzi Dubach, consulente di Relazioni Pubbliche, Sponsorizzazioni e Fondazioni, è docente presso varie università e istituti superiori in Svizzera e Italia e co-autrice fra gli altri di La relazione generosa-Guida alla collaborazione con filantropi e mecenati.