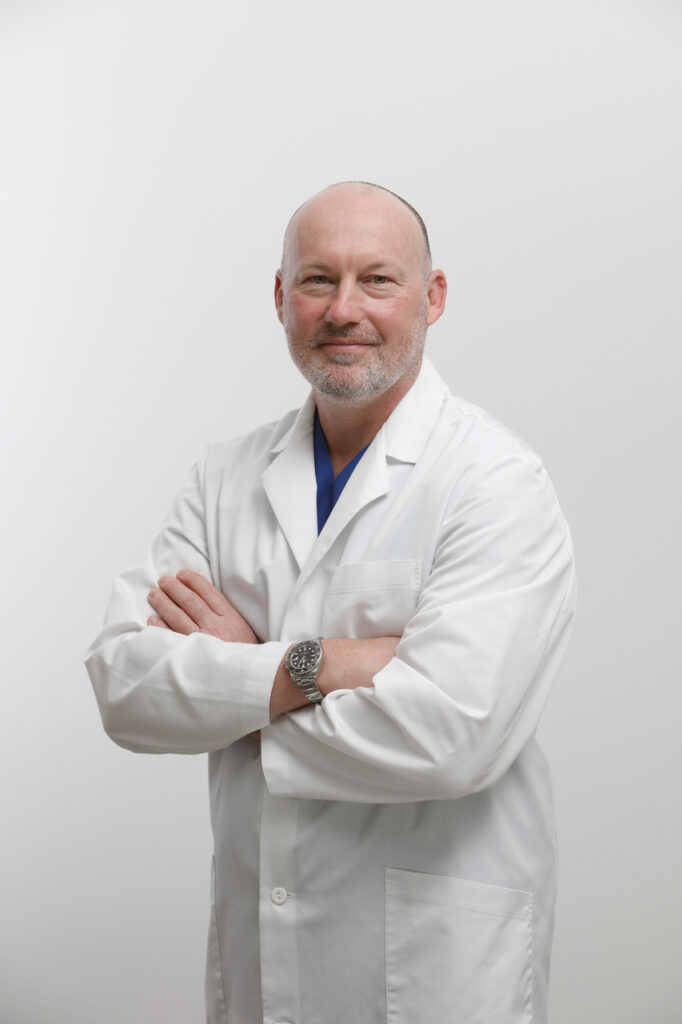Aspetto praticamente un’ora prima di poterlo incontrare, un’operazione più lunga del previsto lo ha bloccato in sala operatoria. Verso le tre la sua segretaria mi chiama, lo raggiungo nel suo studio, mi accoglie con un sorriso.
Immagino non abbia neanche avuto il tempo di mangiare qualcosa, mi spiace…
«Non si preoccupi, ho da sempre l’abitudine di consumare un pranzo leggerissimo, diciamo che sto facendo Quaresima… sa (pausa) in tutte le culture si trovano relazioni tra la salute, l’alimentazione e il digiuno. È importante avere un periodo all’anno dove si sta leggeri e un po’ di digiuno, con giudizio, credo proprio faccia bene al corpo e alla mente».
Forse è proprio per queste buone abitudini che lei è sempre attivo, quasi instancabile; opera ancora o il suo è soprattutto un ruolo di supervisore?
«Ho appena terminato un intervento su una signora russa che è venuta appositamente a Lugano per risolvere una problematica abbastanza complessa dal punto di vista coronarico, dunque sì, opero ancora. Normalmente opero i casi complessi e mi dedico con molta passione alle procedure più innovative. Imparare sempre qualcosa di nuovo, poter offrire al paziente cure all’avanguardia ed efficaci è per me un piacere irrinunciabile».
Come si vive il tempo in una sala operatoria? Soprattutto per una persona con un’agenda come la sua, dove un ritardo può compromettere tutta la giornata…
«Forse è meglio precisare che la sala operatoria che frequento io non è quella chirurgica, ma la sala di emodinamica o quella “ibrida”. Anche se i confini si fanno sempre più sfumati, le procedure di pertinenza del cardiologo interventista si distinguono da quelle propriamente chirurgiche per una diversa tipologia di accesso al cuore. I nostri non sono accessi chirurgici, ma percutanei: arriviamo a operare sul cuore mediante cateteri introdotti attraverso un vaso sanguigno, a livello del gomito o dell’inguine. Detto questo, e per rispondere alla sua domanda, quando si opera il tempo è legato al paziente, non alla vita esterna. Ieri ho avuto un caso molto complesso, c’era una paziente con una particolare deformazione e dal punto di vista tecnico era molto difficile “navigare” nel cuore. L’intervento è durato tre ore e mezzo e lo abbiamo portato a termine con un buon risultato, ma eravamo un po’ stanchi ed è proprio quando subentra la stanchezza che bisogna restare concentrati e non farsi distrarre da nulla. Va anche detto che lavoriamo sempre in equipe: anestesisti, ecocardiografisti e interventisti; nei casi complessi gli operatori medici con elevata esperienza sono due, si lavora in sintonia e ci si avvicenda spesso. È il cosiddetto “heart team” allargato, che permette di garantire al paziente la massima sicurezza e la massima precisione. Nella sala ibrida si procede addirittura a interventi combinati: operazioni chirurgiche mini-invasive e procedure transcatetere. Ci sono momenti in cui tra medici, anestesisti, infermieri di sala operatoria e interventisti, tecnici di laboratorio, siamo più di dieci a partecipare alla realizzazione di un intervento».
Le è mai capitato di aver paura durante un’operazione?
«Ritengo di non aver mai avuto paura, anche nei momenti più drammatici quando l’adrenalina va alle stelle. E’ tuttavia fondamentale avere un team pronto ad intervenire ed eseguire gli ordini del primo operatore. Avere paura significherebbe mettere in pericolo il paziente (si sofferma), durante gli interventi bisogna saper restare freddi, quasi glaciali».
Possiamo dire che praticamente, al giorno d’oggi, tutti gli interventi pianificati hanno ottimi risultati?
«Si deve e si può sempre fare meglio, ma effettivamente se l’intervento è programmato la nostra percentuale di successo è molto alta. Bisogna però sempre essere consapevoli che il rischio zero non esiste, che la complicanza è sempre possibile e non è sinonimo di errore, l’importante è saperla dominare. Naturalmente non sempre è facile… personalmente vivo due tipi di stress: quando un intervento è difficile, ma determina la salvezza di una persona, subentra lo stress positivo, quando invece si perde un paziente, che sicuramente aveva già una probabilità altissima di non farcela, arriva lo stress negativo, al quale non ci si abitua mai».
Nella sua famiglia, prima di lei, non c’erano medici, suo papà era architetto, suo nonno un imprenditore edile. Da studente modello ci si poteva immaginare che avrebbe seguito le orme paterne e invece ha scelto medicina…
«A dire la verità quando ho terminato la maturità pensavo di studiare diritto, poi, arrivando a Zurigo, mi sono interessato anche ad altre facoltà e ho scelto la più lunga e impegnativa: medicina. Quello che mi ha fatto capire di essere sulla strada giusta è stato l’incontro con i pazienti, al terzo anno. Si è trattato della mia personale “folgorazione sulla via di Damasco”, se tornassi indietro mille volte sceglierei sempre questa professione».
Ma durante i primi interventi non è mai stato male?
«No (sorride), anche se una volta ho rischiato, proprio all’inizio dei miei due anni all’Istituto di Patologia medica di Zurigo. Ero alle prime armi, giovane ticinese, e mi era stato assegnato – direi con una certa malizia, se a pensar male non si commettesse peccato – l’autopsia di un uomo deceduto da dieci giorni. Ricordo che tutti i colleghi svizzero tedeschi mi guardavano, aspettavano solo che stessi male, ma non gliel’ho data vinta, ho portato a termine l’autopsia».
Dopo patologia ha iniziato ad assistere a numerosi trapianti renali, poi però ha scelto il cuore…
«Ho avuto inizialmente la fortuna di seguire quale assistente una sessantina di trapianti renali, allora un’innovazione in campo mondiale. Poi però durante il mio dottorato mi sono concentrato sul cuore. Avevo deciso di studiare il cuore di persone morte per cause accidentali, dunque non legate a problemi cardiaci, nella città di Zurigo. La mia idea era quella di confrontare i cuori di questi soggetti con quelli dei militari deceduti per incidente durante il servizio attivo degli anni ‘40 e conservati all’Istituto di Patologia di Zurigo. Ebbene, ho scoperto che i militari presentavano coronarie più sane rispetto agli uomini degli anni ’60, in pieno boom economico e con le prime avvisaglie di quella condizione di sovralimentazione oggi assai comune. In poche parole il mio lavoro dimostrava che c’era stato, nel volgere di un periodo di tempo relativamente breve, uno spostamento della comparsa della malattia coronarica verso un’età più giovanile e la ragione era da imputare al cambiamento di stile di vita».
Il suo dottorato fu molto apprezzato anche oltre oceano, dove avrebbe dovuto recarsi, penso al posto di ricerca a Baltimore. Invece tornò in Ticino…
«Effettivamente (sorride), grazie al lavoro di dottorato, ma anche alle mia considerevole lista di pubblicazioni in cardiologia, avevo ricevuto un incarico di ricerca sull’infarto al Johns Hopkins Hospital di Baltimore. Avevo già pronta la valigia quando seppi che a Lugano cercavano un primario di medicina interna all’Ospedale Civico, l’unità più grande nel Canton Ticino. Non ho resistito e mi sono presentato. Ero il candidato più giovane e a trentadue anni mi sono trovato di fronte alla commissione di esperti universitari incaricati della scelta. Ricordo che mi domandarono cosa pensassi della mia candidatura e ricordo ancora la mia risposta: “Se cercate una persona con anni di esperienza sulle spalle quella persona non sono certo io; se invece volete una persona con grandi progetti e una visione futuristica vi invito a guardare le mie numerose pubblicazioni”».
Ed è in questo periodo che ha conosciuto sua moglie?
«No, la conoscevo già prima. I nostri genitori erano amici. Lei era malcantonese, abitava a Lugano e tutto è stato… un colpo di fulmine. Lei però era giovanissima, abbiamo sette anni di differenza, quindi ho dovuto aspettare. Mia moglie è sempre stata un grande sostegno per me, anche nella critica schietta: quando qualcosa non va me lo dice, trova sempre le giuste parole».
Ha passato quasi trent’anni al Civico, prima come primario di medicina, poi primario di cardiologia ed ha avuto la fortuna di veder realizzato un suo grande sogno: il Cardiocentro. Una gioia, una battaglia…
«Trent’anni fa c’erano pazienti che morivano prima di raggiungere gli ospedali della Svizzera interna. Noi eravamo già in grado di effettuare interventi di dilatazione coronarica, ma c’era ancora scetticismo, malgrado avessimo un tasso di successo altrettanto buono degli altri. E poi, soprattutto, non avevamo una cardiochirurgia. Pensi che dovevamo assicurare uno stand-by cardiochirurgico all’ospedale di Varese, dove trasferire i pazienti in caso di complicazioni. Ne abbiamo trattati oltre mille, di pazienti, e abbiamo dovuto affrontare solo dieci trasporti e soprattutto le nostre statistiche di mortalità erano inferiori rispetto ai riferimenti internazionali. Per questa ragione ho deciso di lottare per costruire un Cardiocentro pubblico, per il bene dei ticinesi, ma dopo mille battaglie la mia idea è stata bocciata. Quando però sono tornato alla carica con 30 milioni di franchi e ho proposto di creare una Fondazione non-profit, sarebbe stato difficile giustificare un altro no, mi è stato concesso un diritto di superficie di 25 anni su questo terreno (guarda fuori dalla finestra). Non avevo scelta… era un “prendere o lasciare”, normalmente i diritti di superficie sono per 99 anni, ma in quel momento o mi chinavo o non avrei potuto costruire tutto questo. Ora si dice “pacta servanda sunt” (i patti devono essere osservati), ma per restare alla civiltà latina possiamo anche dire che quelle furono forche caudine, in Ticino e sul finire del ventesimo secolo».
Incredibile però che sia riuscito a trovare trenta milioni di franchi…
«Il donatore, il dottor Eduard Zwick, era stato un mio paziente, gli avevo salvato la vita. Era arrivato in ospedale in condizioni drammatiche. Dopo l’intervento siamo diventati amici e quando ha saputo della mia sconfitta mi ha detto: “Ti aiuto io”. Non le nascondo che ora sono preoccupato, il diritto di superficie scadrà tra poco e c’è molta incertezza sul futuro del Cardiocentro».
Non è facile trovare una soluzione equilibrata, anche perché sul futuro del Cardiocentro si confrontano forze politiche diverse, e lei conosce bene il peso della politica, visto che è stato per anni in Parlamento…
«La politica… sono stato sedici anni in Parlamento e mi sono occupato tra l’altro della Nuova Legge Sanitaria del Canton Ticino, era il 1987. Volevo fare qualcosa di propositivo, perché è troppo facile lamentarsi di quello che fanno gli altri. Quindi sí la politica ticinese la conosco bene».
Anche sua figlia oltre ad essere medico è in politica…
«È vero, mia figlia è un’internista e ama la politica, una passione che per un certo periodo ha vissuto anche il maggiore dei miei due figli maschi, che al Cardiocentro ha dedicato fin dalla prima ora tutte le sue energie e le sue competenze strategiche e gestionali. Il minore, invece, fa il cardiologo interventista come me ed è tornato da noi dopo anni di formazione, di studio e di lavoro all’estero. Mi reputo fortunato e sono molto orgoglioso della mia famiglia, di cui fanno parte anche otto nipotini (soddisfatto)».
Gli uomini che lavorano molto, spesso sono padri e mariti assenti. Normalmente puntano sulla qualità della loro presenza in famiglia, più che sulla quantità, ma non sempre la soluzione è ottimale…
«Quando i miei figli erano piccoli ero spesso via, è vero, ma mia moglie è riuscita a trasmettere loro anche il mio amore. Sono convinto che se c’è la giusta armonia in famiglia, se si parla dell’assenza del padre in modo positivo – se l’assenza non è indifferenza ma dedizione a un lavoro che nel mio caso significa salvare delle vite umane – i figli capiscono. Devo essere onesto: nessuno della mia famiglia mi ha mai rimproverato di essere stato un padre assente».
Lei è sempre in formissima forse anche perché, oltre ad essere attento all’alimentazione, è sempre stato uno sportivo…
«Effettivamente mi è sempre piaciuto praticare dello sport. Ho fatto un po’ di tutto, ma mai a livello agonistico. Mi piacciono molto anche i grandi eventi sportivi come il basket o l’hockey. Ma la cosa che mi piace di più è vivere e sono convinto che nella vita è importante avere ogni giorno una motivazione, un interesse, bisogna continuare sempre a guardare avanti, sognare e gustare intensamente ogni momento. Il giorno in cui, per me, non ci saranno novità, interessi o voglia di imparare qualcosa (sospiro) capirò che è arrivato il momento di ritirarmi».
Potrà sempre dedicare più tempo all’arte o alla musica classica, immagino sia felice di aver a disposizione un luogo come il LAC a pochi minuti da casa…
«Molto e ne approfitto. Lugano dovrebbe però avere ancora più coraggio, ha molte potenzialità, progetti, ma quando si creano dei poli bisogna parallelamente essere pronti a poter accogliere molte persone. Penso ora al polo congressuale: se vogliamo essere all’avanguardia dobbiamo riuscire a portare in Ticino congressi grandi, con più di due, tremila persone, altrimenti rimaniamo in mezzo al guado e, alla fine, incompiuti. Il successo non lo raggiunge chi è più bravo e intelligente, il successo lo raggiunge chi è capace, darwinianamente parlando, di adattarsi alle condizioni e all’ambiente».
Visto che abbiamo parlato di poli non possiamo non parlare di un polo ospedaliero…
«Il polo ospedaliero dovrà essere una grande unione di forze. Un “Ospedale Ticino”, forte di un’integrazione virtuosa tra Ente Ospedaliero Cantonale, cliniche private e fondazioni non-profit. Questo, e secondo me solo questo, ci permetterebbe di essere competitivi rispetto alla sempre più forte concorrenza degli istituti d’oltralpe. In poche parole solo se uniamo le forze potremo dare fiducia ai pazienti, mantenendo una casistica elevata e dunque realizzando gli standard di una medicina di alta specializzazione. D’altra parte sarà anche estremamente importante che l’attività clinica degli istituti ospedalieri sia alimentata e arricchita da una formazione universitaria e da una ricerca di base, che in questi anni si sta positivamente sviluppando in Ticino e che occorre sostenere».
Dunque immagino sia positivo nei riguardi di una Facoltà di scienze biomediche in Ticino…
«Certo, dobbiamo crederci, tutti insieme: la politica e la popolazione. Per il Master dobbiamo puntare in alto, avere una struttura di docenti preparati ed entusiasti in Ticino e cooptare anche un gruppo selezionato scelto tra i migliori esperti internazionali in qualità di “visiting professors”. Ripeto: occorre avere obiettivi alti, avere la giusta ambizione e puntare a target di qualità elevati. Non saremo i primi… ma dovremo cercare di venire prima dei secondi».
Ci congediamo. Uscendo mi soffermo a pensare alla forza di un uomo che ben presto compirà ottant’anni e che ogni giorno si sveglia con la voglia di vivere, di imparare, di non arrendersi mai.